Da "ABC" a "Zitto": il "libricciuolo" di Giovanni Maria Vincenti - Andrea Cortesi
di Andrea Cortesi
«Con prolissa barba alla cintura, di quelle, che la notte conservansi entro a’ sacchetti. Vestito di un Robbone, alla foggia di Toga, sfibbiato al petto, perchè vi comparisse medaglione appeso, insegna di Dottorato. Nelle mani havea un bel paio di guanti di concia di gelsomini, con uno ricoperta la sinistra, e altro stretto nel pugno della stessa, tenend’ ignuda la destra, affine di farci vedere l’anello con la effigie del bue dorato, altro privilegio del suo Dottoramento nel Bò di Padova. Teneva sul naso occhialoni, accerchiati di nero cuoio alla Spagnuola, raccomandati all’orecchio da due forti corde di Liuto, che forse divisava il mastrone, percosse dal batter delle tempie, gli risvegliassero per occulta simpatia all’intelligenza il genio, e gli spiriti animali».
Con questo parodistico ritratto di un suo ipotetico censore si apre una delle opere grammaticali più curiose di tutto il Seicento: Il ne quid nimis della lingua volgare nelle Regole più praticabili e principali del teologo veneziano Giovanni Maria Vincenti. Le particolarità iniziano dal titolo stesso: ne quid nimis significa ‘nulla di troppo’, ‘lo stretto necessario’, come se Vincenti volesse tranquillizzare i suoi lettori sul fatto di non essersi troppo dilungato in inutili questioni grammaticali, ma di essere andato dritto al sodo. Peccato che, a discapito del titolo, l’opera non sia particolarmente agile, contando ben 852 pagine. Tutt’altro che il libricciuolo promesso dall’autore nell’introduzione.
1. Un grammatico allergico ai grammatici
L’opera di Vincenti venne stampata a Roma nel 1665, da un editore, Ignazio de’ Lazzeri, che fu tra i più attivi in campo grammaticale. Fu lo stampatore di fiducia dei Gesuiti e, in particolare, dai suoi torchi uscirono le opere di Daniello Bartoli, tra cui il celebre Torto e il diritto del non si può, in cui l’autore rivendicava la libertà nell’uso della lingua dallo stretto giogo in cui l’avevano ridotta i grammatici. In questo trattato – uscito per altro lo stesso anno del Ne quid nimis – la polemica era rivolta anche (ma non solo) contro l’Accademia della Crusca, che nel 1612 aveva dato alla luce la prima edizione del proprio celebre Vocabolario. Questo atteggiamento antipedantesco accomuna la ben più famosa opera di Bartoli a quella del nostro Vincenti. Nel proporre le soluzioni agli infiniti dubbi di lingua presentati nell’opera, infatti, Vincenti non accetta pedissequamente la linea dominante della tradizione grammaticale e si sottrae all’autorità dell’Accademia della Crusca: «Le Crusche se le abburattino pure gli Accademici, et i Pedanti» scrive sprezzante nella prefazione; e così anche i testi dei grandi autori del Trecento – modelli su cui si era ormai affermata la lingua letteraria – non vengono indicati come punti di riferimento assoluti in campo linguistico, ma saranno modelli solo per chi studia o vuole scrivere opere letterarie: «Rivolga pure i fogli dei Boccacci, de Danti, e dei Petrarchi, chi Sonetti studia, e Madrigali, ò Lettere amorose per la sua diva». È anche vero, però, che nella prassi Vincenti non si oppone sempre alla linea cruscante: quello che cerca il più delle volte è una mediazione, accettando tutte (o quasi) le alternative a disposizione per una singola forma.
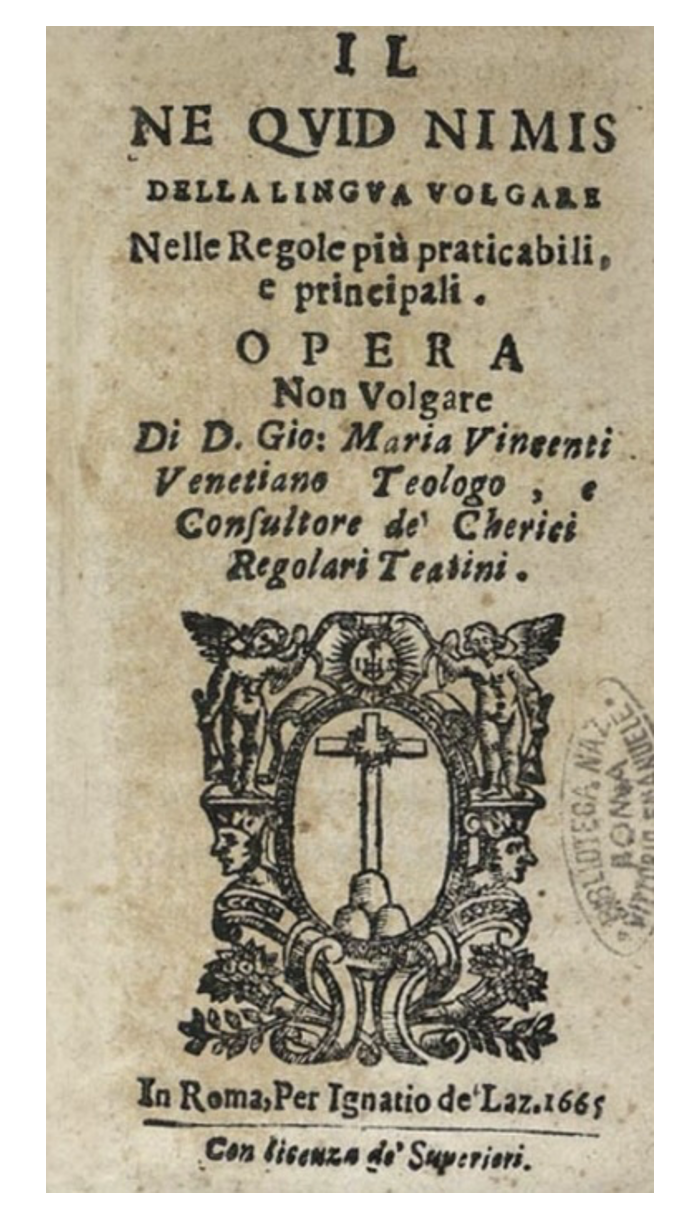
Fig. 1 Frontespizio dell’opera.
La sua posizione emerge chiaramente all’interno di alcuni paragrafi, ad esempio in quello dedicato all’alternanza tra le forme volemo e vogliamo per la 1a persona plurale dell’indicativo presente di volere. Vincenti difende la forma etimologica volemo contro buona parte dei grammatici del tempo (ad esempio Pergamini e Buommattei, ma era a favore Daniello Bartoli: cfr. Colombo 2007, p. 83): «Non vogliono in conto alcuno sentire molti questo volemo, parendo loro voce popolare. Ma non perche (diciam noi) sia una voce del popolo, perciò esser non può non popolar; e guai à gli Scrittori, se havessero à dar bando ad ogni voce, che ’l popol’ usa, usandon’ anche di ottime. Fù dunque volemo usato da chi non popolarmente parlò, quando disse. Se noi volemo ben veder chi sono. Conv. 10, E più sotto. Overo per più usato modo volemo dire Conv. 18.» Da un lato, quindi, Vincenti rivendica l’importanza dell’uso popolare, ma dall’altro non può fare a meno di aggrapparsi a una citazione d’autore, qui dantesca, per difendere la liceità della forma in questione.
Un altro esempio della sua insofferenza per un atteggiamento troppo rigidamente prescrittivo emerge nel paragrafo dedicato all’alternanza tra z (soluzione più moderna, avallata anche dalla Crusca) e ti per rendere il nesso latino -TI-, uno de punti ortografici più dibattuti tra Cinque e Seicento: «Non tanto per dire con libertà, com’è il dovere, il nostro sentimento, quanto per conservare il più che si può la licenza, e la libertà nello scrivere, fine, e scopo dà noi prefissoci in quest’Operetta, e perciò conservato dal principio fin qui al fine, conchiudiamo, che la questione tanto famosa proposta qui della Z e della T, se (cioè) dà valer ci habbiamo dell’una, ò pur dell’altra, e scrivere per esempio Lezione, ò pur Lettione, Letizia over Letitia, quistione la stimiamo, che poco più vaglia di una Z, ò (per meglio dire) assai meno, cioè un Zero. Scriva dunque ognuno à suo talento, e lasci scrivere à gli altri, conforme il suo». In sintesi: ognuno faccia un po’ come gli pare. Che Vincenti sia piuttosto disinvolto nell’uso della lingua lo dimostra anche il fatto che, all’interno di queste righe, coesistono la forma questione e quistione, con un’alternanza tra e ed i in posizione protonica (cioè prima dell’accento). D’altronde, all’interno del Ne quid nimis la soluzione per dirimere l’oscillazione tra forme con e o i in protonia, così come molte altre alternanze, dipende dalle singole parole: per la coppia già citata, o anche per nepote/nipote, Vincenti ammette entrambe le forme, mentre per decembre/dicembre o mesura/misura propende per la seconda.
2. Grammatica o vocabolario?
Gli argomenti trattati nell’opera sono organizzati in ordine alfabetico, come in un vocabolario, e divisi in una miriade di piccoli paragrafi. Fino a qui nulla di particolare: la prassi di ordinare alfabeticamente e non per macrotema gli aspetti linguistici trattati non era infatti rara all’epoca e proseguirà ancora nel Settecento. Risultato di questa impostazione è la proliferazione di paragrafi incentrati su parole che presentano lo stesso fenomeno e che quindi potevano, a ben vedere, essere accorpate. Un esempio si ha con i paragrafi dedicati alle coppie ale/ali e arme/armi, in cui il fenomeno trattato è l’oscillazione nell’uscita del plurale di alcuni nomi femminili; Vincenti tratta delle due coppie in punti separati, inserendo però un rimando sotto ogni voce. La sua posizione è la stessa per entrambe le coppie: come spesso accade, vengono ritenute corrette tutte e due le possibilità.
La tendenza all’accettazione delle polimorfia – tipica della tradizione grammaticografica italiana – ha in Vincenti un suo campione: ci vorrebbe troppo spazio per indicare tutti i casi in cui non prende una vera posizione, considerando accettabili tutte le alternative. Se questo atteggiamento è in linea con l’antipedantismo esplicitamente dichiarato dall’autore, è anche vero che, soprattutto in campo grammaticale, scegliere tutto può equivalere a non scegliere niente. In alcuni casi, però, il nostro grammatico appare più deciso e prescrittivo, ad esempio nel paragrafo dedicato alle diverse forme per indicare il numerale due: tra due, dua, doi, dui, Vincenti indica senza incertezze che andrà utilizzato solo il primo, mentre invita a evitare soprattutto gli ultimi due (su questo tratto cfr. Colombo 2007, p. 74). Ma andrà notato ancora una volta come il suo criterio di scelta sia orientato sulla singola parola e non organicamente su un fenomeno linguistico: le sue soluzioni si concentrano sul caso particolare e non sull’universale. Basta vedere, nel campo dei dittonghi, le diverse soluzioni offerte per le coppie mele/miele e fele/fiele: «Scrivesi il primo, non il secondo; al contrario di Fiele, che si usa, e non Fele» (riconoscendo però che in poesia, e soprattutto in posizione di rima, fele era molto spesso utilizzata).
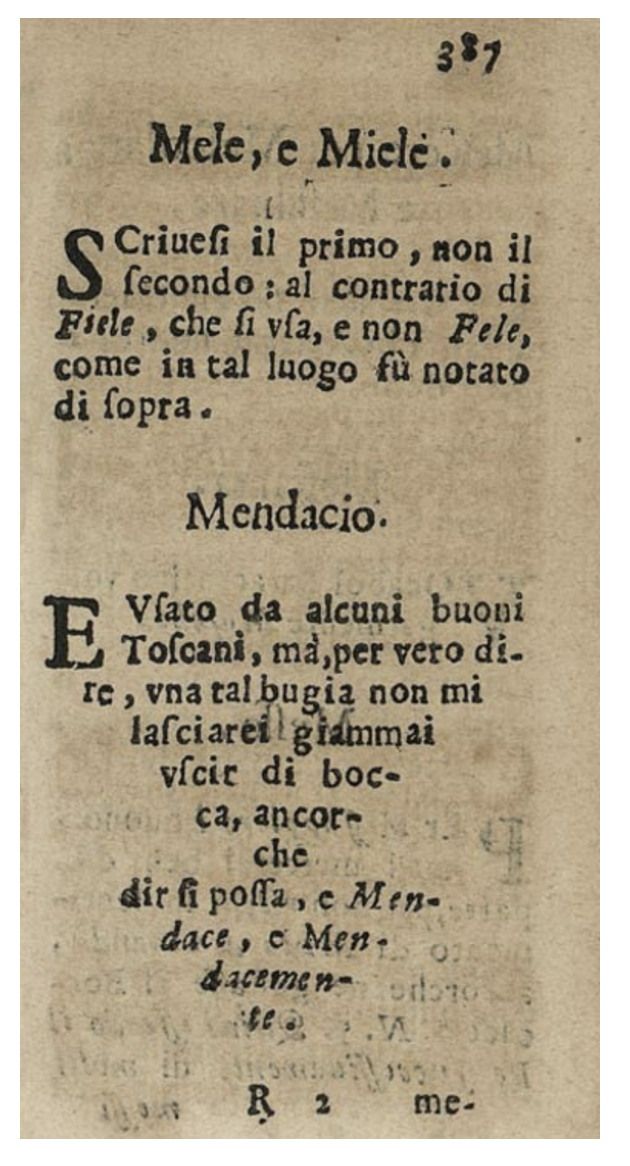
Fig. 2 La pagina in cui compare il paragrafo dedicato alle alternative mele e miele (p. 387).
Gli argomenti affrontati da Vincenti, come abbiamo visto non in modo organico ma (quasi) sempre partendo da una o più parole, sono molto vari e toccano tutti gli aspetti della lingua (meno che la sintassi, soprattutto del periodo). Troviamo alcune questioni ortografiche, come uso dell’h, degli accenti e degli apostrofi (che ancora oggi creano non pochi problemi) e moltissimi aspetti fonetici: dai dittonghi (cuore/core) alla sonorizzazione (ago/aco), dall’anafonesi (conseglio/consiglio) all’alternanza tra e/i, sia toniche (ancella/ancilla) che atone (decembre/dicembre) e tra o/u (vulgo/volgo), oltre alle doppie (opinione/oppinione) e ai vari accidenti vocalici (estimare/stimare, opera/opra). Nel campo morfologico si hanno osservazioni sul numero (ad esempio i plurali in e di ala ed arma) e sul genere (come in puzzo/puzza) dei nomi, sull’uso di alcuni pronomi, e numerose note sulla polimorfia di alcune voci verbali, come devo/debbo/deggio, fussi/fossi, renduto/reso, temei/temetti ecc. Non manca qualche sconfinamento nella microsintassi, in particolare nelle voci che riguardano la costruzione delle congiunzioni (Conciosiacosache, se con l’Indicativo) e di certi verbi (Mandare col Gerondio), o ancora sull’accordo (Nomi Accordati co’ Nomi di vari generi; Nomi accordati co’ verbi in vari Numeri). Infine, per quanto riguarda il lessico, abbiamo sia commenti a singole parole, sia ad espressioni idiomatiche come a crepa pelle e a spina pesce (quest’ultima evidentemente non riferita, come oggi, a una tipologia di parcheggi, bensì a un modo di avanzare a zig-zag, «serpeggiando» come riporta anche il Vocabolario della Crusca sin dalla prima edizione).
Impostando la trattazione sulle singole forme e non più sistematicamente sui fenomeni, è inevitabile che piani grammaticali diversi si sovrappongano all’interno della stessa voce. Prendiamo il paragrafo intitolato Ellera, Hellera, Hedera, Hedra in cui vengono discusse ben quattro forme diverse per indicare l’edera. A parte la soluzione («la prima più in uso, l’ultima in veruno, le altre due scritte saran senza errore») importa qui notare la sovrapposizione di aspetti linguistici diversi: l’uso o meno dell’h (ellera contro le altre), le varianti formali della parola (hellera-hedera), la sincope (hedra). Lo stesso vale per il gruppo Lauda, Laude, Loda, Lode, tra le quali esclude solo lauda, accettando implicitamente forme con o senza dittongo e l’alternanza, in queste ultime, tra uscita in -a e in -e.
3. Una grammatica “ironica”
Al di là delle scelte strettamente grammaticali dell’autore, ciò che contraddistingue il Ne quid nimis è sicuramente il tono ironico che Vincenti usa nel commentare le voci che passa in rassegna.
Leggiamo ad esempio ciò che scrive riguardo al dubbio tra la forma zanzara e l’alternativa zenzara: «se, col restringere l’A nella E, riuscisse di cortare o spuntare l’aculeo à questo importuno, fastidioso, e mordace animaletto, Mordicus sarebbe da noi sostenuto, che Zenzara si scriva con la E, non Zanzara con l’A. Mà, perche à questo nulla ci può servire, scriviamo, ò Zanzara, ò Zenzara, che tutto ben sarà scritto». Dal punto di vista grammaticale, ancora una volta Vincenti non risolve il dubbio ma accoglie entrambe le possibilità; ciò che più colpisce è però il tentativo, a volte abbastanza forzato, di creare un collegamento con il significato della parola, riuscendo spesso a strappare un sorriso al lettore.
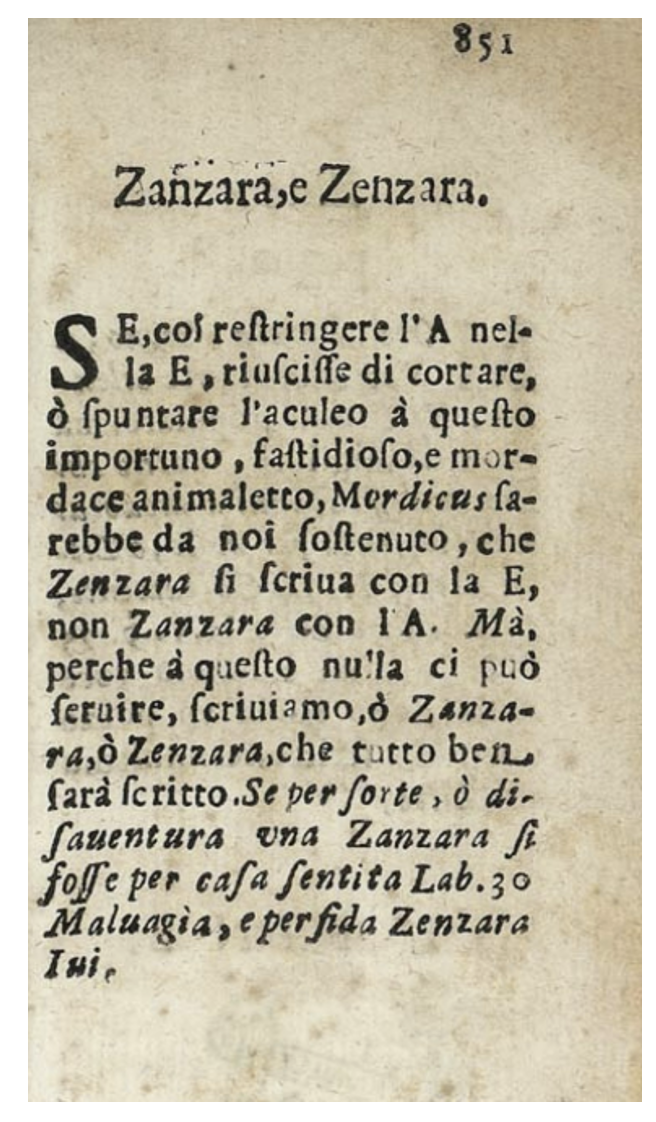
Fig. 3 La p. 851, dove si discute delle forme zanzara e zenzara.
Gli esempi sono moltissimi, infiniti. Eccone una breve carrellata, spaziando tra i vari piani della lingua: adolescente: voce «spregiata, da chi è adolescente nella lingua. Però stimata da chi in quella cresciuto»; allumare/alluminare/illuminare: «Fra tanti lumi molti vanno all’oscuro, non sapendo qual più risplenda degli accennati. Di ognuno dic’io de’ tre egualmente si serve, e li pone sul candeliere, chi scrive senza timore di rimanere al buio, non sempre dicendo Illuminare, che il più chiaro»; barbagiani/barbagiano: «Ma chi non è Barbagiani sempre scriverà solamente Barbagiani»; filosofo/philosopho: «più frequente Filosofo che Philosofo perche ancora più sono i Filosofi, che i Philosofi, Filosofi cioè senza H, che non vagliono un’H»; orecchia/orecchio: «Onde in plurale Orecchia, e Orecchi tutti son ben detti. Ciò che ne dica qualche troppo orecchiuto»; pruina/brina: «Hoggi darebbe nel freddo, chi scrivesse Pruina, benche già l’usasse Petrarca Canz. 19, con più altri» e così via per molte altre voci. Non proprio quello che ci si aspetterebbe nel consultare una grammatica, perlomeno oggi.
4. In sintesi: da ABC a Zitto
Il ne quid nimis non ha avuto alcun impatto nella storia della grammatica dell’italiano (prevedibilmente, aggiungiamo), né deve essere stato letto da molti, come dimostra il fatto che non è mai stato ristampato. Dopo secoli di oblio, viene citato nella monumentale Storia della grammatica italiana dello studioso e grammatico Ciro Trabalza (1908), che dovette essere particolarmente incuriosito dall’opera di Vincenti, tanto da dedicarle anche un breve articolo dal titolo Un curioso criterio stilistico d’un grammatico secentista (1903). L’aggettivo stilistico non è scelto a caso: più che un’organica teoria grammaticale, è proprio il gusto personale dell’autore che sembra portarlo, caso per caso, a scegliere (o a non scegliere) una forma piuttosto che un’altra. Il tutto condito da quella dose di ironia che rende la lettura dell’opera, per gli avventurosi che volessero avvicinarla, meno noiosa di altre. L’intento polemico anticruscante, l’impostazione alfabetica e l’ampiezza degli argomenti trattati seppur in modo asistematico rendono infatti quest’opera, per quanto poco o per nulla conosciuta, una tappa particolarmente interessante nel secolare percorso delle grammatiche che, a quel tempo, rappresentavano spesso mezzi per dibattiti linguistici tra dotti, più che strumenti rivolti ai giovani apprendenti.
Come poteva concludersi un’opera del genere, se non con la voce Zitto? Dopo averne dato una rapida definizione («Moto, parola, segno, ò Voce che dinota Silentio») e sugli usi («Voce non popolare, mà usata dà migliori»), Vincenti, che aveva aperto il trattato con la voce ABC 851 pagine prima, si congeda così dal lettore: «Se dunque è buona voce Zitto, dopo haver’un pezzo discorso, e scritto, terminiamo con Zitto».

Fig. 4 Il primo paragrafo dell’opera, dedicato alla voce ABC (p. 1) e la pagina finale (p.852).
marzo 2024
Per saperne di più
Ciro Trabalza, Un curioso criterio stilistico d’un grammatico secentista, in Id., Studi e profili, Torino, Paravia, 1903, pp. 80-85.
Ciro Trabalza, Storia della grammatica italiana, Milano, Hoepli, 1908, pp. 343-344.
Michele Colombo, Alcuni fenomeni linguistici nelle grammatiche secentesche da Pergamini a Vincenti, in «Studi di grammatica italiana», XXVI, 2007, pp. 67-105.





