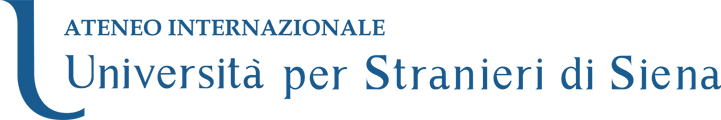Regole ed osservazioni della lingua toscana
Ridotte a metodo per uso del Seminario di Bologna da D. Salvadore Corticelli bolognese Cherico Regolare di S. Paolo
Autore:
Salvadore Corticelli | Corticelli Salvatore
Indice
A' CONVITTORI, ED ALUNNI DEL SEMINARIO DI BOLOGNA (p. 3)
LIBRO PRIMO - Delle parti della toscana orazione (p. 9)
Cap. I. Del Toscano Alfabeto. (ivi)
Cap. 2. Delle sillabe. (p. 12)
Cap. 3. Delle parole. (p. 15)
Cap. 4. Quante, e quali sieno le parti della toscana orazione. (p. 16)
Cap. 5. Del nome sustantivo, e dell'addiettivo. (p. 18)
Cap. 6. De' nomi alterati. (p. 20)
Cap. 7. De' nomi partitivi, e de' numerali. (p. 23)
Cap. 8. Delle varietà, o sieno passioni del nome. (p. 25)
Cap. 9. Del segnacaso. (p. 29)
Cap. 10. Dell'articolo. (p. 31)
Del primo articolo. (p. 32)
Del secondo articolo. (p. 33)
Del terzo articolo. (p. 33)
Cap. 11. Della declinazione de' nomi. (p. 34)
Prima Declinazione. (p. 34)
Seconda declinazione. (p. 35)
Terza declinazione. (p. 35)
Quarta declinazione. (p. 36)
Cap. 12. De' nomi indeclinabili. (p. 36)
Cap. 13. De' nomi eterocliti di doppia uscita. (p. 38)
Cap. 14. De' nomi eterocliti, che hanno un solo plurale, ma con desinenza fuori di regola. (p. 41)
Cap. 15. De' nomi difettivi. (p. 42)
Cap. 16. De' pronomi, e prima del pronome IO. (p. 45)
Cap. 17. Del pronome Tu. (p. 47)
Cap. 18. Del pronome Se. (p. 49)
Cap. 19. De' pronomi derivativi. (p. 50)
Cap. 20. De pronomi dimostrativi di persona. (p. 52)
Pronomi, che dimostrano persona prossima a chi parla. (p. 53)
Pronomi, che dimostrano persona prossima a chi ascolta. (p. 55)
Pronomi dimostrativi di persona terza. (p. 57)
Pronomi, che aggiungono asseveranza, o espressione. (p. 63)
Cap. 21. De' pronomi dimostrativi di cosa. (p. 66)
Questo. (p. 66)
Cotesto. (p. 67)
Quello. (p. 67)
Ciò. (p. 67)
Cap. 22. De' pronomi relativi. (p. 67)
Cap. 23. De' pronomi universali indeterminati. (p. 71)
Pronomi di generalità. (p. 71)
Pronomi, che dinotano distribuzione. (p. 75)
Pronomi di qualità. (p. 81)
Pronomi, che dinotano diversità. (p. 83)
Cap. 24. Del Verbo. (p. 86)
Cap. 25. Delle variazioni del Verbo. (p. 89)
Cap. 26. Alcune generali osservazioni sopra le conjugazioni de' Verbi. (p. 91)
Cap. 27. Conjugazione del Verbo essere. (p. 95)
Osservazioni sopra il Verbo Essere. (p. 97)
Cap. 28. Conjugazione del Verbo avere. (p. 100)
Osservazioni sopra 'l Verbo Avere. (p. 102)
Cap. 29. Uso de' Verbi essere, e avere nella conjugazione degli altri Verbi, e quando avere si ponga per essere. (p. 104)
Cap. 30. Conjugazione del Verbo amare, ch'è la prima regolare, co' suoi anomali. (p. 107)
Osservazioni sopra la prima conjugazione. (p. 109)
Verbi anomali della prima conjugazione. (p. 110)
Cap. 31. Conjugazione del Verbo temere, ch'è la seconda regolare. (p. 114)
Osservazioni sopra la seconda Conjugazione. (p. 116)
Cap. 32. De' Verbi anomali della seconda Conjugazione. (p. 118)
Cap. 33. Conjugazione del Verbo leggere, ch'è la terza regolare. (p. 123)
Osservazioni sopra la terza Conjugazione. (p. 125)
Cap. 34. Verbi anomali della terza Conjugazione. (p. 129)
Cap. 35. Conjugazione del Verbo sentire, ch'è la quarta regolare. (p. 134)
Cap. 36. Anomali della quarta Conjugazione. (p. 136)
Verbi terminanti in isco. (p. 138)
Cap. 37. De' Verbi difettivi. (p. 140)
Cap. 38. De' Verbi passivi, e degl'impersonali. (p. 142)
Cap. 39. Del participio. (p. 144)
Cap. 40. Del Gerundio. (p. 149)
Cap. 41. Della preposizione. (p. 150)
Cap. 42. Del Ripieno. (p. 154)
Particelle, che si adoperano per evidenza. (p. 155)
Particelle, che si adoperano per ornamento. (p. 159)
Accompagnanomi. (p. 162)
Accompagnaverbi. (p. 163)
Cap. 43. Dell'Avverbio. (p. 165)
Cap. 44. Della interjezione. (p. 169)
Cap. 45. Della Congiunzione. (p. 170)
LIBRO SECONDO - Della Costruzione toscana. (p. 173)
Cap. 1. Idea generale della costruzione toscana. (p. 173)
Ordinata collocazione delle parti dell'orazione. (p. 174)
Dipendenza delle parti dell'orazione, l'una dall'altra. (p. 179)
Concordanza delle parti dell'orazione fra se. (p. 180)
Cap. 2. Della costruzione de' Verbi attivi. (p. 185)
Primo Ordine. (ivi)
Secondo Ordine. (p. 190)
Terzo Ordine. (p. 193)
Quarto Ordine. (p. 197)
Quinto Ordine. (p. 199)
Sesto Ordine. (p. 201)
Settimo Ordine. (p. 203)
Cap. 3. Della costruzione de' Verbi passivi. (p. 207)
Cap. 4. De' Verbi assoluti. (p. 208)
Cap. 5. Della costruzione de' Verbi neutri. (p. 210)
Primo Ordine. (p. 211)
Secondo Ordine. (p. 212)
Terzo Ordine. (p. 218)
Quarto Ordine. (p. 224)
Quinto Ordine. (p. 226)
Sesto Ordine. (p. 230)
Settimo Ordine. (p. 233)
Cap. 6. Della costruzione de' Verbi Neutri passivi. (p. 235)
Primo Ordine. (p. 236)
Secondo Ordine. (p. 240)
Terzo Ordine. (p. 245)
Quarto Ordine. (p. 248)
Quinto Ordine. (p. 249)
Sesto Ordine. (p. 251)
Settimo Ordine. (p. 253)
Cap. 7. Della costruzione de' Verbi impersonali. (p. 255)
Primo Ordine. (p. 255)
Secondo Ordine. (p. 256)
Terzo Ordine. (p. 259)
Quarto Ordine. (p. 260)
Quinto Ordine. (p. 264)
Cap. 8. Della Costruzione de' Verbi Locali. (p. 265)
Stato in luogo. (p. 266)
Moto da luogo. (p. 272)
Moto per luogo. (p. 273)
Moto a luogo. (p. 275)
Moto verso luogo (p. 277)
Moto fino a luogo. (p. 279)
Della distanza d'un luogo dall'altro. (p. 280)
Cap. 9. Di varj casi, che sono comuni a molti Verbi. (p. 282)
Cap. 10. Della Costruzione degl'infiniti de' Verbi. (p. 286)
Cap. 11. Della Costruzione del gerundio. (p. 297)
Cap. 12. Della Costruzione del participio. (p. 304)
Cap. 13. Della Costruzione del nome. (p. 308)
DELL'ARTICOLO. (p. 308)
DEL SEGNACASO. (p. 315)
DEL NOME SUSTANTIVO. (p. 318)
DE' NOMI ADDIETTIVI. (p. 320)
COL GENITIVO. (p. 320)
COL DATIVO. (p. 322)
COLL'ACCUSATIVO, E LA PREPOSIZIONE A. (p. 322)
COLL'ACCUSATIVO, E LA PREPOSIZIONE PER. (p. 323)
COLL'ABLATIVO. (p. 323)
DE NOMI COMPARATIVI. (p. 324)
DE' SUPERLATIVI. (p. 325)
DE' PARTITIVI. (p. 326)
DE' PRONOMI. (p. 326)
Cap. 14. Della Costruzione della preposizione. (p. 327)
DELLE PROPOSIZIONI SEMPLICI. (p. 327)
A. (p. 329)
DA. (p. 332)
IN. (p. 334)
PER. (p. 336)
CON. (p. 339)
DENTRO, ENTRO. (p. 340)
SOPRA. (p. 341)
SOTTO. (p. 343)
TRA, FRA. (p. 343)
PRESSO, VICINO. (p. 346)
RASENTE. (p. 349)
LUNGO. (p. 349)
LUNGI, LONTANO, DISCOSTO. (p. 349)
VERSO, INVERSO. (p. 350)
FINO, INFINO, SINO, INSINO. (p. 351)
CIRCA. (p. 351)
OLTRE. (p. 351)
AVANTI, DAVANTI, INNANZI, DINANZI, PRIMA. (p. 352)
DIETRO, DOPO. (p. 355)
CONTRO, CONTRA. (p. 356)
GIUSTA, GIUSTO, SECONDO. (p. 357)
ECCETTO, SALVO, FUORI, IN FUORI. (p. 358)
SENZA. (p. 359)
QUANTO. (p. 360).
DELLE PREPOSIZIONI COMPOSTE. (p. 360)
A modo, maniera, guisa, foggia &c. (p. 360)
Altre preposizioni composte, che servono al genitivo. (p. 360)
Preposizioni, che servono al dativo. (p. 361)
Preposizioni, che servono all'accusativo. (p. 364)
Preposizioni, che servono all'ablativo. (p. 365)
Cap. 15. Della Costruzione dell'avverbio. (p. 365)
$ I. Degli avverbj, che hanno caso. (p. 366)
ECCO. (p. 366)
Avverbj dinotanti quantità. (p. 367)
Altri avverbj col caso. (p. 368)
$ II. Avverbj di particolare osservazione. (p. 371)
Avverbj non tanto noti comunemente. (p. 371)
Avverbj di vario uso. (p. 376)
Cap. 16. Della costruzione dell'interjezione. (p. 395)
O, OH, OI. (p. 395)
AH, AHI. (p. 396)
DEH. (p. 396)
GUAI. (p. 396)
COSI'. (p. 397)
Cap. 17. Della costruzione della congiunzione. (p. 397)
Delle congiunzioni sospensive, e condizionali. (p. 397)
Delle congiunzioni indicanti contrarietà. (p. 398)
CONGIUNZIONI, CHE TOLGONO LA CONTRARIETA'. (p. 401)
DELLE CONGIUNZIONI DI CAGIONE. (p. 401)
DELLE CONGIUNZIONI AVVERSATIVE. (p. 404)
DELLE CONGIUNZIONI COPULATIVE, E DISGIUNTIVE. (p. 405)
DELLE CONGIUNZIONI AGGIUNTIVE. (p. 407)
DELLE CONGIUNZIONI ELETTIVE. (p. 407)
DELLE CONGIUNZIONI ILLATIVE. (p. 408)
DI VARIE ALTRE CONGIUNZIONI. (p. 409)
Cap. 18. Della costruzione figurata. (p. 412)
DELLA ELLISSI (p. 413)
DEL PLEONASMO. (p. 419)
DELLA SILLESSI. (p. 421)
DELL'ENALLAGE. (p. 421)
DELL'IPERBATO. (p. 426)
DELLE PARTICELLE, E DEGLI AFFISSI. (p. 429)
LIBRO TERZO. Della maniera di pronunziare, e di scriver toscano. (p. 434)
Cap. I. Del valore, e della pronunzia delle lettere. (p. 434)
Cap. 2. Dell'Accento, e dell'Apostrofo. (p. 439)
Cap. 3. Delle stroncature delle sillabe. (p. 441)
Cap. 4. Dello accrescimento delle parole. (p. 443)
Cap. 5. Quando le parole si possano scemare in principio. (p. 445)
Cap. 6. In quanti modi possano le parole scemarsi in fine. (p. 447)
Cap. 7. Delle parole composte. (p. 458)
Cap. 8. Delle lettere maggiori, e minori, e quali sieno le regole del loro uso. (p. 461)
Cap. 9. De' punti, e delle virgole. (p. 462)
Cap. 10. Delle sillabe lunghe, e brievi. (p. 468)
TAVOLA De' Libri, e de' Capitoli della presente Opera. (p. 470)
TAVOLA Delle abbreviature, e degli Autori, da' quali sono tratti gli esemj citati in quest'Opera. (p. 474)
INDICE Delle Materie, che si contengono in quest'Opera. (p. 484)
Testo in formato elettronico
/ BEGIN PAGE 1 /
REGOLE
ED
OSSERVAZIONI
della Lingua Toscana
Ridotte a metodo
per uso
DEL SEMINARIO DI BOLOGNA
DA
D. SALVADORE CORTICELLI BOLOGNESE
Cherico Regolare di S. Paolo.
IN BOLOGNA
Nella Stamperìa di Lelio dalla Volpe. 1745.
Con licenza de’ Superiori.
/ BEGIN PAGE 2 /
/ BEGIN PAGE 3 /
A’ CONVITTORI, ED ALUNNI
DEL SEMINARIO
DI BOLOGNA.
DElle regole della Lingua Toscana scris-
sero con somma lode celebri Autori,
il Bembo , il Castelvetro , il Salvia-
ti , il Buommattei ; e singolarmente due grand’
uomini della Compagnia di Gesù , Marco An-
tonio Mambelli , e Daniello Bartoli ; i qua-
li , per sentimento di un famoso Toscano (*),
benchè ultimi nell’ordine de’ tempi , per l’a-
cutezza nondimeno , e per la diligenza , con
cui hanno trattata questa materia , degnissimi
sono di essere collocati fra’ primi . Ma quan-
tunque gli accennati egregj maestri , colle lo-
ro esattissime osservazioni , abbiano spianate
molte difficultà, e tolti via non pochi intop-
pi, che troppo difficil rendevano questa lin-
gua : contuttociò , a volerne agevolare a’ gio-
vani lo studio , desiderar si potrebbono alcu-
ne cose di più ; le quali non sono punto fa-
cili ad ottenersi , ma , dove ottener si potesse-
ro , sarebbono al pubblico di grandissima uti-
lità .
A 2 E pri-
![]()
( * ) Carlo Dati oraz. dell’ obbl. di ben parlare la
propria lingua .
/ BEGIN PAGE 4 /
E primieramente cosa di molto vantaggio
sarebbe , che le tante regole , ed osservazio-
ni , le quali sono sparse ne’ volumi de’ soprac-
citati Gramatici, e che altri non può, senza
lunga fatica , tenere a mente, venissero insie-
me raccolte , e con sì acconcio metodo di-
stribuite , che far potessero nella memoria de’
giovani distinta insieme , e profonda impres-
sione. Di più , non avendo i sopraddetti Au-
tori trattato, se non ben poco , della costru-
zione toscana , utilissima cosa farebbe chi pie-
namente , e ordinatamente il facesse. E for-
se dal non essersi ciò fatto fin qui proviene
quella difficultà , che proviamo talvolta nello
scrivere pulitamente in toscano , quale non
sogliamo incontrare nello scrivere in Latino
con proprietà ; perchè nella lingua Latina ab-
biamo pronte alla mente le regole della sin-
tassi, non già così nella volgare ; nella qua-
le perciò scrivendo ci convien non di rado
ritrar dal foglio la penna , e starci sospesi a
pensare , come vada espressa con proprietà di
linguaggio questa , o quella cosa . Finalmen-
te, essendo gli Autori del buon secolo della
Lingua Toscana pieni di belli, e graziosi mo-
di di favellare : nè bastando la lettura di essi
perchè altri possa aver pronti al bisogno que’
modi , i quali son molti , e fuggono facil-
mente dalla memoria : se trovar si potesse ma-
niera di raunarne un buon numero , e metter-
gli
/ BEGIN PAGE 5 /
gli in ordine a vantaggio degli studiosi, gio-
verebbe ciò più che molto al cultivamento di
questa pregiatissima lingua.
Ed ecco , o virtuosi giovani , quello, che
io ho , non dirò già fatto , ma almen tenta-
to di fare nell’ Opera, che vi presento . Io
aveva , già sono molti anni passati , raccolte
da’ migliori Autori molte osservazioni di Lin-
gua Toscana : e ciò solamente per mio uso
privato , e per ricreare talvolta 1’ animo af-
faticato dalle gravi cure de’ miei ministeri:
ma nella erezione di queste scuole, a noi dal
regnante Pontefice, e nostro insieme Arcive-
scovo , con somma clemenza , affidate , sono
stato stimolato a riordinarle , e a darle alla
pubblica luce . E più mirando io all’ utilità
vostra , che alla mia insufficienza, mi sono
messo all’ impresa . Ho scelto per tal fine il
metodo , con cui suole insegnarsi nelle scuo-
le la Lingua Latina ; e perchè a voi già
noto , e famigliare ; e perchè l’ ho giudica-
to acconcissimo a mettere in buon’ ordine le
regole , che sono sparse ne’ nostri Gramati-
ci ; e a trattar pienamente della volgar co-
struzione; e a porre in buona veduta mol-
ti fiori di parlare tratti dagli Scrittori del
miglior secolo ; che tale appunto è l’ idea
proposta di sopra, di ciò, ch’è opportuno a
promuovere lo studio della Lingua Toscana .
Parimente ho giudicato ben fatto di servirmi
A 3 de’
/ BEGIN PAGE 6 /
de’ termini gramaticali, che si adoperano da’
Latini, benchè la nostra lingua abbia i suoi
termini proprj, per non recar confusione col-
la diversità: e ho seguito in questo il savis-
simo parere del Cavalier Lionardo Salviati ,
di Benedetto Varchi, e d’altri di que’ Tosca-
ni, che contano : e tanto più, perchè i ter-
mini gramaticali de’ Latini sono ricevuti dal
Vocabolario della Crusca .
In tre libri adunque è divisa quest’Opera .
Nel primo si dà una chiara , e distinta noti-
zia delle parti dell’orazione toscana, affinchè
imparino i giovani a farne uso buono, e con-
venevole, e non iscambino da una all’altra.
Nel secondo si tratta della costruzione di tut-
te le parti dell’ orazione, perchè veggano gli
studiosi il modo di ben disporle, e non ne
turbino l’ordine , e la giacitura. Nel terzo
finalmente , secondo il metodo de’ Latini Gra-
matici , si tratta della maniera di pronunzia-
re , e di scrivere toscanamente.
Nelle regole, e nelle osservazioni ho usa-
ta la maggior brevità , che mi è stata possi-
bile: ma negli esempj sono stato anzi libera-
le, e profuso , che no : perchè la brevità del-
la regola giova a ben tenerla a memoria, e
l’abbondanza degli esempj serve a dilucidar-
la. Gli esempj sono , quando si può, di que-
gli Autori, che vanno per la maggiore , che
sono Dante, Petrarca, e ’l Boccaccio, e so-
pra
/ BEGIN PAGE 7 /
pra tutti quest’ultimo nel Decamerone, ch’è
la prosa migliore, che abbia la nostra lingua.
In mancanza di questi si citano i Villani , il
Passavanti , il Crescenzio, ed altri del buon
secolo ; e in difetto anche di questi, si addu-
cono esempj di buoni , ed approvati moder-
ni . Sicuri poi saranno gli esempj addotti in
quest’opera, perchè tratti , o dal Vocabolario
della Crusca , o da moderne corrette edizioni.
Gli esempj del Vocabolario saranno quelli ,
ne’ quali si citerà il nome dell’ Autore, o al
più il titolo dell’Opera, ma non già il libro,
nè ’l capitolo, nè la pagina : e quelli, che
saranno interamente contrassegnati , saranno i
tratti dalle buone edizioni da me vedute . Nel-
le autorità del Boccaccio, quando non è ci-
tato il titolo dell’ Opera, s’intenda l’autorità
essere del Decamerone. E quando fra uno
esempio, e l’altro vi saranno due lineette =,
senza nuova citazione , sarà segno , l’esem-
pio seguente essere del medesimo autore del
precedente. Al fine dell’Opera vi sarà un’In-
dice copioso , e talmente distribuito , sicchè
altri possa a un tratto ritrovare ciò , che gli
occorre .
Mi resta per ultimo d’animarvi, o valorosi
giovani , ad intraprendere seriamente questo
studio, e ad usarvi una particolar diligenza.
Le regole gramaticali sono minuzie, che non
si apprendono senza molestia : ma il ben sa-
A 4 per-
/ BEGIN PAGE 8 /
perle, e l’averle, all’ occasione , in contan-
ti, è cosa di molto vantaggio. A veder la-
vorare i moderni Romani artefici di musaico,
sembra la loro una misera, e gretta faccen-
da : perchè altro e’ non fanno, che mirar pie-
truzze, e accozzarle insieme, e osservarne mi-
nutamente la digradazion de’ colori: ma quan-
do è poi compiuto il lavoro, e ne riesce un
bel quadro , con figure quasi vive, e spiranti,
e sì bene atteggiate, che ne disgradano l’ope-
ra di famoso pennello : allora si dà per bene
impiegata ogni più minuta fatica, e si cele-
bra , con piacere , l’ eccellenza dell’artefice,
e la bellezza dell’ arte. Così lo studiare le mi-
nute osservazioni della lingua ci sembra cosa
rincrescevole, e da fanciulli; ma l’udir poi
ragionare alcuno ben pratico delle regole gra-
maticali ci arreca maraviglioso diletto ; mercè
della proprietà, e della buona armonia del di-
scorso, la quale è base, e fondamento dell’
eloquenza. Valetevi adunque , di queste mie
fatiche, gli errori scorsi nelle quali potranno
essere scusati dalla vastità della materia , e
compensati dalla buona volontà di giovare
a’ vostri studj. Vivete felici.
RE-
/ BEGIN PAGE 9 /
REGOLE
ED OSSERVAZIONI
Della Lingua Toscana.
LIBRO PRIMO
Delle parti della toscana orazione
CAP. I.
Del Toscano Alfabeto .
VEnti lettere, senza più , ha il toscano al-
fabeto, e sono queste: A B C D E F G H
I L M N O P Q R S T U Z .
Mancano adunque a noi tre de’ caratteri
dell’alfabeto Latino, cioè KXY . In vece del
K ci serviamo del CH. La forza dell’ X lati-
no la sogliamo esprimere colla S o semplice ,
o raddoppiata, come exemplum , esemplo, Ale-
xander, Alessandro. Ci serviamo contuttociò
alcuna volta dell’ X, come di carattere fore-
stiero : o per profferire qualche voce stranie-
ra , la quale, pronunziata colla S, potrebbe
prendersi per un’altra voce nostrale ; onde di-
ciamo v. g. Xanto , per isfuggire l’ equivoco
della parola Santo : o veramente per iscrivere
alcu-
/ BEGIN PAGE 10 /
alcune parole prette latine , usate da’ nostri Au-
tori , come: exabrupto, exproposito, exprofes-
so. L’ Y non ha uso alcuno nella lingua to-
scana.
Le sopraddette lettere sono gli elementi del-
la scrittura, e contrassegnano gli elementi del
parlare . Per elemento del parlare intendiamo
una semplice emissione di fiato , formata cogli
strumenti ad articolar la voce destinati .
Di questi elementi alcuni da se soli hanno
suono, e si formano colla semplice apertura
della bocca , e si variano secondo i varj modi,
ne’ quali una tale apertura si fa, e le lettere,
che li contrassegnano, si chiamano vocali : al-
tri non hanno per se stessi suono , ma consisto-
no in una certa vibrazione di fiato, formata
con varj percotimenti , e accostamenti delle
labbra, della lingua , e de’ denti . Questa vi-
brazione per se stessa non iscolpisce suono, ma
cadendo sopra uno elemento vocale, v’aggiu-
gne un modo, e un’ impressione particolare.
Quindi le lettere , che contrassegnano questi
elementi , si chiamano consonanti .
Le lettere vocali sono cinque, cioè AEIOU ;
le consonanti sono le rimanenti lettere del sud-
detto alfabeto, dal Q , e dall’ H in fuori; aggiu-
gnendovi però l’I, e l’ U, che sotto forma d’ J, e
d’ V si adoperano a maniera di consonanti. Il Q,
e l’H da alcuni si chiamano mezze lettere, per-
chè appresso di noi non hanno da se vibrazio-
ne,
/ BEGIN PAGE 11 /
ne, che possa rilevare elemento. In fatti il Q
senza l’ U non rileva ; l’H rileva solamente
col C, o col G, e da se sola punto ; benchè
talvolta serva per contrassegnare una certa pro-
nunzia allungata , per così dire , con istrascico,
come in ah , eh , uh .
Con venti lettere adunque noi proccuriamo
di esprimere gli elementi del parlare, i quali
appresso di noi ascendono al numero di tren-
taquattro . Con cinque vocali perciò variamen-
te pronunziate noi esprimiamo sette diversi
suoni , e con quindici consonanti ventisette di-
verse vibrazioni, come nel terzo libro si ve-
drà.
Delle consonanti altre si dicono mute , cioè
BCDGPTZ , perchè i loro nomi , bi , ci , di ,
gi , pi , ti , zeta, cominciano da consonante ;
altre semivocali, cioè FLMNRS, perchè i lo-
ro nomi cominciano da vocale , esse , elle, em-
me &c. e di queste semivocali quattro si chia-
mano liquide , cioè LMNR , perchè sono assai
correnti, e di molto spirito. E si noti , che av-
vedutamente abbiamo espressi i nomi delle pri-
me sei lettere mute coll’ i, e non coll’ e, co-
me gl’esprimono i Latini, e ancora molti Ita-
liani, dicendo : be, ce, de &c. , perchè coll’i
gli pronunziano , e sempre gli pronunziarono
i Fiorentini . Bocc. g. 6 n. 5. egli crederebbe che
voi sapeste l’abbiccì . E Giovanni Villani lib.2.
cap. 13., parlando dell’ Imperador Carlo Ma-
gno ,
/ BEGIN PAGE 12 /
gno , dice: fe edificare tante Badie , quante let-
tere ha nell’ Abbiccì .
Circa il genere de’ nomi delle lettere dell’al-
fabeto , la regola più ricevuta è la seguente .
Le due vocali A , ed E, con tutte le consonanti
ad esse appoggiate, sono di genere femmini-
no, onde si dice: la a, la h, la e, la m, e co-
sì del resto. Si eccettua la lettera straniera K,
ch’ è di genere mascolino, e si dice : il K . Le
tre vocali IOU , insieme colle loro consonanti ,
sono di genere mascolino , e si dice : l’ i, il
b, il c, il d, l’ o, l’ u, il q , e così discorren-
do. Di tutto ciò vedi il Salviati Avvertim.
lib. 3. cap. I., il Buommattei tratt. 3., e il
Manni lez. 2.
CAP. II.
Delle sillabe.
SIllaba chiamasi ogni elemento dell’ umano
discorso , che ha il suono suo rilevato , e
spiccato. Quindi ogni sillaba dee avere la sua
vocale , perchè senza vocale non può esservi
suono.
In tre modi una vocale può rilevare il suo-
no : da se sola : insieme con una , o due al-
tre vocali : o insieme con una, o più conso-
nanti .
Da se sola una vocale rileva il suono ,
quan-
/ BEGIN PAGE 13 /
quando è monogramma, cioè non ha in sua
compagnia alcun’ altra lettera , come a segno
del terzo caso , e congiunzione , o particella
di vario uso , e simili. E ancora per entro
una parola può una vocale rilevar suono da
se , cioè quando sopr’ essa non cade vibrazio-
ne alcuna di consonante : così nella parola
amore a fa sillaba da se, perchè la m vibra
sopra la seconda vocale .
Altre volte la vocale rileva suono congiun-
ta con una , o due altre vocali , e allora chia-
masi dittongo, o trittongo, cioè compressione
di due, o tre vocali sotto un medesimo ravvol-
gimento di fiato .
De’ dittonghi altri sono distesi , altri raccol-
ti . I distesi son quelli , che fanno sentire
amendue le vocali in maniera, ch’ e’ non ap-
pariscono quasi dittonghi , come aere, ai per
alli, aurora , feudo , maisì , Borea , Europa ,
e simili , ne’ quali la principal vocale è la
prima ; e l’altra si sente bensì chiara, e spic-
cata , ma ciò non toglie, che la sillaba non
sia una sola , perchè la seconda vocale si pro-
nunzia unita , e , in certo modo, ravvolta al-
la prima. I Dittonghi raccolti sono quelli ,
che si pronunziano talmente uniti, che la pri-
ma vocale perde molto di suono, e la secon-
da è la principale, perchè sopr’ essa la voce
si posa , come in piano, cielo, tuono, gielo, e
somiglianti.
Ha
/ BEGIN PAGE 14 /
Ha la lingua toscana anche de’ trittonghi,
come suoi, vuoi , miei , figliuoi, lacciuoi &c.,
ne’ quali si comprimono tre vocali in un sol
fiato ; e in questi la principal vocale suol’ es-
ser quella di mezzo , su cui la voce princi-
palmente si posa.
Finalmente una vocale rileva suono con-
giunta con una, o più consonanti , quando
innanzi, o dopo cade sopra di essa la vibra-
zione di una, o di più consonanti . Avanti la
vocale possono esservi fino a tre consonanti ,
ma dopo non ne può aver più d’ una, se non
si trattasse di alcuna voce forestiera , come
Agilulf. Ecco gli esempj di una fino a quat-
tro consonanti in una sillaba BA Badia; BRA
Bravo ; BRAC Bracco ; SPRAN Spranga . Si
noti, che le consonanti non si troveranno mai
tre in una sillaba avanti la vocale, se la pri-
ma non è un’ S. Ancora si osservi , che niu-
na sillaba nella nostra lingua comincia da due
medesime consonanti, e perciò quando in una
parola v’ è una consonante raddoppiata, la
prima delle due lettere si ascrive alla prece-
dente sillaba, e l’altra alla seguente, come
nel terzo Libro vedremo.
CA-
/ BEGIN PAGE 15 /
CAP. III.
Delle parole.
PArola, che ancora dicesi vocabolo, e di-
zione, altro non è, che una voce artico-
lata significativa di alcuna idea dell’ animo no-
stro. Le sillabe sono il medesimo alle parole,
che alle sillabe sono le lettere ; onde siccome
può la sillaba essere di una, o di più lette-
re, così d’una , o di più sillabe può essere la
parola.
Delle parole altre sono semplici, altre com-
poste. Le semplici sono quelle, che sono for-
mate di sillabe non significanti da se sole, al-
meno rispetto al tutto, come monarca, libe-
rale , principe &c., perchè le sillabe di que-
ste parole , o non significano cos’alcuna , co-
me mo , nar , o se significano altro, ciò non
ha che fare col significato di quella parola
intera , come li , le , ci possono essere parti-
celle significative , ma ciò non ha rapporto
alle parole liberale , o principe . Le parole com-
poste sono quelle , che sono formate di più
semplici, come Granduca , galantuomo , gen-
tiluomo &c. Talvolta però nelle parole com-
poste v’ è qualche parte, che da se non signi-
fica , ma solo in composizione, come la par-
ticella arci nella parola arciprete, stra nella
voce straricco, e simili.
Le
/ BEGIN PAGE 16 /
Le parole, tanto semplici , quanto compo-
ste possono essere in varie maniere da noi ac-
cresciute, o scemate, e ciò per dar forza, o
vaghezza al discorso, o per togliere alcuna
asprezza di pronunzia ; ma di ciò nel terzo
libro si tratterà.
Alcuni stimano, che per parlar ben toscano
convenga sceglier le parole, che più sono
lontane dal latino ; ma il Salviati avvert.
lib. 2. cap. 15. riprova questa opinione, e dice,
ch’ e’ non sa dove sia appoggiata , perchè a
parlar bene toscano , chiaro è , le voci do-
vere esser pure , e nostrali, e niun riguardo
in questa parte volersi avere , o di latino, o
di greco. Aggiugnerei io volentieri, che , non
essendo in arbitrio di chicchessia il formar
nuove voci toscane , quelle debbono adope-
rarsi , che sono dall’ uso , e dal giudicio de’
Toscani approvate , senza darsi impaccio di
fuggire la somiglianza colle voci latine.
CAP. IV.
Quante, e quali sieno le parti della toscana
orazione.
OTto sono le parti della toscana orazione,
cioè nome, pronome , verbo , participio ,
preposizione , avverbio, interjezione, e congiun-
zione. Di queste otto parti altre sono declina-
bili,
/ BEGIN PAGE 17 /
bili, cioè variabili ne’ loro modi, altre inde-
clinabili, cioè invariabili , e che non mutano
aspetto giammai . Le declinabili sono quattro ,
cioè nome , verbo , pronome , e participio , le
altre quattro sono indeclinabili.
Nome è parola declinabile per casi, la quale
significa alcuna cosa, senza dinotar tempo, co-
me uomo , Pietro, virtù.
Pronome è parola declinabile , la quale , coll’
accennare alcun nome , viene a significare alcu-
na cosa , come io , tu , colui .
Verbo è parola declinabile, che significa al-
cuna cosa con tempo , come amo , scrivo , leggo.
Participio è parola declinabile , la quale for-
mandosi da alcun verbo , accenna alcun significa-
to di quello , come amante , amato .
Preposizione è una parola indeclinabile , la
quale aggiunta ad altra parte dell’ orazione ,
ha forza di variarla nel caso , e nella significa-
zione , come vado a Roma, vengo da Roma .
Avverbio è una parola indeclinabile , che ag-
giunta al Verbo , ha forza di esplicare gli acci-
denti di quello , come Pietro studia diligente-
mente la lezione .
Interjezione è una parola indeclinabile, che
s’ intramette per entro il parlare , per accennare
i subiti affetti dell’ animo, come ah , oh , oimè .
Congiunzione è una parola indeclinabile , la
quale ha forza di unire insieme le parti dell’ora-
zione , come perchè , pure, dunque .
B CAP.
/ BEGIN PAGE 18 /
CAP. V.
Del nome sustantivo , e dell’ addiettivo.
LA prima, e più solenne divisione del no-
me è in sustantivo, e in addiettivo. Il no-
me sustantivo è quello, che significa una su-
stanza , ovvero alcuna cosa a guisa di sustanza ,
che per se medesima si sostenga : e può perciò
stare nell’ orazione, senz’ appoggiarsi ad altro
nome, come Uomo , virtù . L’addiettivo è quel-
lo , che accenna alcun modo , o qualità della
cosa , e non può stare nell’ orazione , senz’ ap-
poggiarsi a un sustantivo o espresso, o sottin-
teso : espresso , come Uomo prudente ; sottinte-
so , come il prudente, cioè l’Uomo prudente.
Ci sono de’ nomi , i quali si adoperano ora
sustantivi , ora addiettivi , e chiamansi parteci-
panti , o di mezzo . Basteranno di ciò due esem-
pj, di tanti , che apportar si potrebbono . Fra-
te, e Maestro si usano e per sustantivi , e per
addiettivi . Bocc nov. I. Fu lor dato un frate an-
tico, di santa , e di buona vita . Ecco frate su-
stantivo. E g. 6. n. 10. Era questo Frate Cipolla
di persona piccolo . Eccolo addiettivo. E g. 8.
n. 9. Il Maestro lo scusava forte . Ecco maestro
sustantivo. E g. I. n. 10. Maestro Alberto da Bo-
logna . Eccolo addiettivo. Salviati avvert. vol.
2. lib. I. cap. I.
I no-
/ BEGIN PAGE 19 /
I nomi sustantivi , che dinotano individual-
mente una persona , o una cosa , si chiama-
no proprj , come Pietro, Bologna, Reno ; e quel-
li , che dinotano cose comuni , ed incerte ,
appellativi si chiamano , come Uomo , città ,
fiume . Agli appellativi si possono ridurre gl’in-
finiti de’ verbi, quando stanno per nomi , come
il dire , lo stare , l’ udire &c. Appellativo an-
cora è il nome collettivo, il quale nel nume-
ro singulare accenna moltitudine, come gen-
te , esercito , greggia , e simili.
Per ciò , ch’ appartiene all’origine de’ no-
mi , quelli , che non derivano da altra voce,
si chiamano primitivi , come monte, mare,
buono ; e quelli, che da altre voci sono dedot-
ti, chiamansi derivativi. Quindi altri sono no-
minali, perchè vengon da nome, come scu-
diere da scudo ; altri verbali , che son formati
da un verbo , come bravata da bravare ; al-
tri pronominali, che da pronome si deducono,
come nostrale da nostro . Ancora altri si chia-
mano patrj , perchè traggonsi dalla patria, co-
me Bolognese; altri nazionali dalla nazione,
come Italiano, Toscano ; altri dal possedimen-
to , o appartenenza , come cavallo regio , sol-
dato Austriaco ; altri dall’imitazione , come sti-
le Boccaccesco ; e altri da altro , che non giova
qui annoverare .
B2 CA-
/ BEGIN PAGE 20 /
CAP. VI.
De’ nomi alterati.
NOmi alterati si chiamano quelli, i quali
ricevono aumento , o diminuzione nella
loro semplice significazione ; e perciò altri so-
no aumentativi , altri diminutivi , e di questi
nomi alterati è oltremodo ricca la nostra lin-
gua .
Gli aumentativi , quando dinotano grandez-
za, si chiamano accrescitivi, e finiscono in
one, e in ona, in otto, e in otta , in ozzo , e
in ozza, come Dottorone, donnona, contadinotto ,
contadinotta , foresozzo , foresozza &c. , i qua-
li più significano , che i semplici loro . E tal-
volta , per maggiore accrescimento , si muta il
genere di femminino in mascolino, come in
donnone , e campanone , i quali sembra che signi-
fichino alquanto più, che il dir donnona, e cam-
panona.
Alle volte gli aumentativi dinotano peggio-
ramento , o malvagità, e diconsi peggiorativi ;
e finiscono in accio , e in accia , come omaccio ,
femminaccia : ovvero in azzo , e in azza , co-
me popolazzo , brunazza . Peggiorativi ancora
sono gentame , gentaglia , e altri sì fatti . Alcu-
na volta però i nomi a questo modo terminati
non sono affatto peggiorativi, ma dinotano so-
lamen-
/ BEGIN PAGE 21 /
lamente qualche dispregio , come quando di-
ciamo d’uno: Egli è un buono omaccio , un buon
figliuolaccio. Anzi il Bocc. g. 8. n.9. ne adope-
ra uno in buon senso, dicendo : O ella vi par-
rebbe la bella femminaccia!
De’ diminutivi alcuni sono dispregiativi ,
altri vezzeggiativi. I dispregiativi dinotano
dispregio, ed escono in etto , ello , uccio , uz-
zo , volo , atto, attolo &c. , co’ loro corrispon-
denti femminini, come Dottoretto , femminet-
ta , cappelluccio, donnuccia , villanello, villa-
nella , poetuzzo , tegghiuzza , tristanzuolo ,
donnicciuola, omiciatto , omiciattolo , e simili. A
questi si possono aggiugnere casipola, e casupola.
I vezzeggiativi dinotano vezzo, e lusinga , e
finiscono ordinariamente in ino, e in ina, come
Tonino, Bettina, fanciullino, fanciullina &c., e ciò
singolarmente si usa ne’ nomi proprj de’ fanciul-
li . E talora si adoperano per vezzo anche i di-
spregiativi, come quando diciamo ad alcuno
per modo di lusinga : cattivello, poveretto &c.
Quando poi l’accrescimento , e la diminu-
zione del significato si fa con rapporto , e re-
lazione , si adoperano i nomi comparativi , e
i superlativi. Ora un nome, che significa sem-
plicemente alcuno accidente, senza rappor-
to , ed eccesso, si chiama positivo, come buo-
no, cattivo, grande. Se poi significa qualche
accrescimento , o diminuzione rispetto al po-
sitivo, si chiama comparativo, come migliore,
B3 peg-
/ BEGIN PAGE 22 /
peggiore , men buono , men cattivo , maggiore ,
minore &c. E se significa tutto l’ effetto del cre-
scere, o dello scemare, si chiama superlativo,
come ottimo, bonissimo, massimo, grandissimo,
pessimo, cattivissimo.
De’ comparativi formati ci sono solamente
maggiore, minore, migliore, e peggiore ; onde
gli altri si rendono tali coll’ aggiugnere alcu-
no avverbio, dicendo , per esempio: più, o
men bello &c.
Talvolta ancora si adopera più, e meno in
vece de’ comparativi maggiore, e minore . Bocc.
g. 6. nel princ. Della più bellezza, e della me-
no delle raccontate novelle disputando.
Alcuna volta altresì , presso gli antichi , si
truova aggiunta la particella più al compara-
tivo . Retor. Tull. Molto più maggiori maestri
di te ci son molti ; e in altri esempj presso al
Salviati vol. 2. lib. I. cap. 4.
De’ superlativi, dettrattine quattro , cioè
Ottimo , pessimo , massimo , minimo , gli altri esco-
no in issimo , come bellissimo , ricchissimo &c.
Superlativi ancora dir si possono que’ nomi,
a’ quali s’ affigge in principio la sillaba tra ,
tras , o trans : così gli antichi dicevano trabel-
lo per bellissimo ; e il Bocc. g. 5. n. 2. adopera
transricchire per ismoderatamente arricchire ,
la qual voce nel Vocabolario è notata per an-
tica.
Al superlativo altresì può forse ridursi il po-
sitivo
/ BEGIN PAGE 23 /
sitivo replicato, come buono buono , grande gran-
de , piccin piccino &c. perchè dinota eccesso.
Bocc. nov. I. perciò vi priego , Padre mio buo-
no , che così puntalmente d’ ogni cosa , d’ ogni
cosa mi domandiate , come se mai confessato non
mi fossi . E g. 2. n. 3. Che se allato allato a
Filostrato vedea . E ancora i seguenti modi di
die vi si riducono . Bocc. g. 3. n. 8. Ferondo
uomo materiale , e grosso senza modo. E g. 2.
n.7. Dolente , fuor di misura , senza alcuno in-
dugio , ciò che il Re di Cappadocia domandava ,
fece .
CAP. VII.
De’ nomi partitivi , e de’ numerali.
SE si riguarda alla divisione , e al numero,
che significansi nelle cose , i nomi altri so-
no partitivi , altri numerali . I nomi partitivi
sono quelli , i quali significano o una cosa
fra molte , o molte cose insieme : una cosa
fra molte , come uno, solo, alcuno , chi , cia-
scuno , e simili : molte cose insieme , come tut-
ti , molti , niuno &c. I nomi numerali sono
quelli , che significano numero .
I numerali sono di tre sorte , cardinali ,
ordinali , e distributivi. I cardinali significa-
no numero assolutamente , e senz’ordine , co-
me uno, due, tre &c. , e sono ordinariamente
B 4 addiet-
/ BEGIN PAGE 24 /
addiettivi, dicendosi per esempio: tre giova-
ni , sette donne , cento novelle &c. ; ma talvol-
ta si adoperano in forza di sustantivi , come
quando diciamo : il due, il tre &c., e in giu-
cando : tre cinqui, tre setti , tre novi &c.
Gli ordinali significano numero con ordine,
ovvero l’ultimo di tal numero , come primo ,
secondo , terzo , &c. , e sono quasi sempre ad-
diettivi, dicendosi : il primo Uomo, il secondo &c.;
ma pure alcuna volta si usano sustantivi , co-
me quando si dice : un terzo, o un quarto d’ora ,
cioè una terza , o una quarta parte .
I distributivi significano distribuzione , o sia
quantità numerata , come decina , ventina ,
centinajo , migliajo &c., e sono sempre sustan-
tivi , perchè stanno senz’appoggio .
Talvolta si adopera il cardinale in forza
di distributivo o addiettivamente , o sustanti-
vamente . Bocc. nel Proem. da un dieci , o do-
dici de’ suoi vicini alla Chiesa accompagnati ;
cioè da una decina , o dozzina . E g. 8. n. 10
Con tanti panni lani, che alla Fiera di Salerno
gli erano avanzati, che potevano valere un
cinquecento fiorini d’ oro.
CAP.
/ BEGIN PAGE 25 /
CAP. VIII.
Delle varietà , o sieno passioni
del nome.
TRe sono le varietà , o passioni del nome,
cioè genere , numero , e caso .
I generi de’ nostri nomi sono tre ; mascoli-
no, come Uomo , Pietro , Principe , valore,
pensiero &c., femminino, come donna, Anna,
Reina, spezie &c., e comune, che si usa in
amendue i generi, del quale appresso parle-
remo.
Il genere neutro, che non sia nè mascoli-
No, nè femminino , stimano i Gramatici , che
la nostra lingua non l’abbia : e pure trovansi
ne’ primi maestri alcune voci neutralmente
poste, come da’ seguenti esempj potrà ciascu-
no comprendere. Bocc. g. 2. nel fine: reputo
opportuno di mutarci di qui. Cioè opportuna
cosa . E g. 5. n. I. subitamente fu ogni cosa
di romore , e di pianto ripieno. E sembrano
neutri altresì terzo, quarto , migliajo , cen-
tinajo , e simili. Bocc. g. 8. n.7. Questa non
è stata lunga per lo terzo, che fu la sua. Nov.
ant. 93. Questi non avea il quarto danari. Bocc.
Introd. Nelle quali a centinaja si mettevano i
sopravvegnenti.
Ma ritornando al genere comune, primie-
ramen-
/ BEGIN PAGE 26 /
ramente servono ad amendue i generi quegli
addiettivi , che finiscono in e , e dinotano
qualità, come parente , nobile , illustre , singu-
lare , grande , potente , prudente , celebre , e al-
tri sì fatti, come ognuno potrà da se facil-
mente conoscere.
Ancora ci sono de’ sustantivi, che usansi in
amendue i generi, de’ quali porremo qui i più
ricevuti, ed usati da’ buoni autori nell’ uno,
e nell’altro genere .
AERE. Bocc. Ed evvi, oltre a questo, l’aere
assai più fresco . E nell’Ameto . Ma poichè
l’ aere a divenir bruna incominciò.
ARBORE . Amm. Ant. Arbore trasportato
sovente, non prende vita. Crescenz. In prima di-
ciamo del cultivamento di tutte in comune , e po-
scia del cultivamento delle singulari arbori.
FINE . Bocc. Uno amore a lieto fine perve-
nuto = Venuta di questa ( novella ) la fine, la
Reina verso la Fiammetta rivolta, ch’ essa l’or-
dine seguitasse le comandò .
FONTE . Bocc. Dintorno alla fonte si pose-
ro a sedere . E nell’ Amet. Entrata nel chiaro
fonte, tutta infino alla gola si mise nelle bell’
acque.
FUNE. Bocc. Accomandando ben l’un de’ca-
pi della fune a un forte bronco, per quella si
collò nella grotta. Petrar. E ’l fune avvolto
Era alla man, che avorio, e neve avanza.
GENESI. Gio. Vill. Cominceremo dal prin-
cipio
/ BEGIN PAGE 27 /
cipio del Genesi . Davanz. Scism. Lasciasse lo-
ro un per cento di quanto hanno, e guadagnas-
sonsi quell’ uno col sudore del volto , come co-
manda la Genesi.
ORDINE PER DISPOSIZIONE. Bocc. Se
con sana mente sarà riguardato l’ ordine delle
cose . Stor. Pist. Presa l’ ordine tra loro , il
trattato fue rivelato al Duca.
ORDINE PER CONGREGAZIONE DI
RELIGIOSI . Bocc. Io ho avuta sempre spe-
zial divozione al vostro Ordine. Gio. Vill. Al
tempo del detto Papa Innocenzio si cominciò la
santa Ordine de’ Frati Minori.
OSTE PER ESERCITO . Bocc. Congregò
una bella, e grande , e poderosa Oste . Gio.
Vill. Così avvenne nel nostro bene avventu-
roso oste .
TEMA PER ARGOMENTO . Bocc. La te-
ma piacque alla lieta brigata. Petrar. Ma per
non seguir più sì lungo tema, Tempo è , ch’ io
torni al mio primo lavoro . In femminino però
si trova usato di rado.
I due nomi, Ecclissi, e parentesi, che so-
no di Greca origine , dovrebbono essere ap-
po noi senza legge ; pure ecclissj si truo-
va sempre usato mascolino, e parentesi fem-
minino , come dal Vocabolario , e dalla
lettura degli Autori potrà ciascuno vede-
re .
Cercine, cioè l’ involto, che adoperano co-
loro,
/ BEGIN PAGE 28 /
loro , che portano pesi in testa , e fiocine ,
cioè la buccia dell’acino dell’uva, sono ma-
scolini, come appare dal Vocabolario.
Ci sono ancora alcuni nomi, i quali si usa-
no in amendue i generi, ma con qualche va-
riazione di significato.
DIMANE per significare il dì vegnente , si
usa mascolino . Albertan. L’ un dimane diman-
da l’ altro dimane. Quando significa il prin-
cipio del giorno, è femminino. Dante. Quan-
do fui desto innanzi la dimane , Piagner sentì
fral sonno i miei figliuoli.
MARGINE per estremità è d’amendue i ge-
neri. Dante. Lo fondo suo , ed ambo le pendi-
ci Fatte eran pietra , e i margini dallato. Fi-
renz. Asin. Posciachè con gran fatica ella si fu con-
dotta alla margine dell’ altra ripa , a pena no-
tando scampammo. Quando significa cicatrice,
è femminino . Bocc. Si ricordò , lei dovere
avere una margine , a guisa d’ una crocetta,
sopra l’ orecchia sinistra .
E altresì da osservare , che la lingua to-
scana ne’ generi de’ nomi non istà a tutte le
regole della lingua Latina. Così metodo, pe-
riodo , e sinodo, che presso i Latini son di ge-
nere femminino, appresso di noi son masco-
lini . Così ancora i nomi degli alberi , che
son femminini nella lingua Latina, noi gli
facciamo mascolini, eccettuatine quercia ed
elce . Anzi è costume della nostra lingua ,
quan-
/ BEGIN PAGE 29 /
quando l’albero, e ’l frutto hanno il mede-
simo nome , di fare mascolino il primo, e
femminino il secondo, dicendo v. g. pero l’al-
bero , e pera il frutto , e così melo, e mela
il noce , e la noce, e gli altri ancora.
C’è di più il genere promiscuo , il quale
comprende alcuni animali , de’ quali non ab-
biamo i nomi per amendue i generi , e per-
ciò con un solo nome comprendiamo il ma-
schio , e la femmina , come sono rondine,
tordo , luccio , corvo , pantera , lepre , vipera ,
scarafaggio , anguilla &c. Manni lez. 4.
Dal genere passando finalmente alle altre
due varietà del nome, cioè numero, e caso,
in queste punto non discordiamo da’ Latini .
Due perciò sono i numeri de’ nostri nomi, sin-
gulare, e plurale, e sei i casi, cioè Nomi-
nativo , o sia caso retto , genitivo, dativo,
accusativo, vocativo, e ablativo.
CAP. IX.
Del segnacaso.
LA terminazione , o sia uscita de’ nomi
nella nostra lingua è bensì varia , passan-
do dal numero singolare al plurale, onde di-
ciamo per esempio nel singolare Uomo , don-
na , nel plurale Uomini , donne : ma non ha
varietà alcuna ne’ casi di ciascun numero ,
ser-
/ BEGIN PAGE 30 /
servendo una sola invariata voce al singola-
re, e un’ altra sola al plurale, ed è in que-
sto simile alla lingua Ebraica , e differente
dalla Greca , e dalla Latina , le quali accen-
nano i casi coll’alterazione delle voci. Quin-
di, per conoscere i casi, adoperiamo alcune
preposizioni, le quali aggiunte a’ nomi, ac-
cennano in quali casi adoperare si vogliano
da chi parla , o scrive, e perciò chiamansi
segnacasi.
Intorno al numero de’ segnacasi ci ha di-
versità di pareri fra’ nostri Gramatici, perchè
alcuni ne assegnano sei, e altri di soli tre si
contentano . Noi, senza metterci ad esaminar
questo punto, diremo col Bembo, e col Buom-
mattei , tre essere i segnacasi più ordinarj,
cioè DI, che serve al genitivo, A, che serve
al dativo , e DA , che serve all’ ablativo :
e questi tre segnacasi , senz’ alterazione al-
cuna , servono al singulare , e al plurale .
Il nominativo , e l’ accusativo non hanno
segno, perchè si possono agevolmente cono-
scere ; e così parimente il vocativo, il qua-
le viene abbastanza contrassegnato dalla cir-
costanza del chiamare altrui ; e al più vi
si pone avanti la vocale O, come avverbio di
vocazione , dicendo : o Pietro, o Paolo . E
quest’ uficio di segnare i casi può farsi ancora
da altre preposizioni, ma le tre addotte so-
no le più frequenti nell’ uso.
Si
/ BEGIN PAGE 31 /
Si declinano adunque i nomi col segnaca-
so a questo modo . Singulare Nominat. Uomo,
Donna . Genit. D’ Uomo, di Donna . Dativ. Ad
Uomo, A Donna. Accus. Uomo, Donna. Vocat.
O Uomo, o Donna. Ablat. Da Uomo , da Don-
na. Plurale Nominat. Uomini, Donne. Genit.
D’ Uomini, Di Donne . Dativ. Ad Uomini , A
Donne . Accusat. Uomini, Donne. Vocat. O Uo-
mini, o Donne. Ablat. Da Uomini, da Donne.
CAP. X.
Dell’ articolo.
L’Articolo è una particella, che aggiunta a
nome, o pronome ha forza di determinare ,
e distinguere la cosa accennata . Questa deter-
minazione , e distinzione si fa dall’ articolo
col particolarizzare in certo modo una cosa.
Così s’ io dico Re , posso essere inteso di qua-
lunque Re ; ma se io, stando in qualche rea-
me , dirò : il Re , sarò per lo più inteso di
quello, ch’ è ivi dominante . Parimente se io
dicessi : io non ho danari, sarebbe inteso, ch’
io non ne avessi punto ; ma se io dicessi ,
trattandosi di fare alcuna spesa ; io non ho i
danari , s’ intenderebbe della quantità neces-
saria a far quella spesa. I Latini , che non
avevano articoli , non potevano esprimersi,
se non se dicendo : Rex , e nummos non ha-
beo ,
/ BEGIN PAGE 32 /
beo, e perciò mancavano di qualche determi-
nazione, e distinzione.
Tre sono i nostri articoli, cioè il , lo , la ;
i primi due servono al genere mascolino , e
il terzo al genere femminino . L’articolo per
se stesso non è declinabile, non avendo altro
più che le tre accennate voci nel singulare
il , lo , la , e nel plurale i , gli, le, ma in-
corporandosi a queste voci quelle del segna-
caso, l’articolo si rende variabile, o sia de-
clinabile secondo i casi del nome , e del pro-
nome . La declinazione dell’articolo va per
cinque casi solamente , perchè il vocativo non
riceve articolo .
Del primo articolo.
SIngulare Nominat. Il. Genit. Del . Da-
tiv. Al . Accusat. Il. Ablat. Dal. Plurale
Nominat. I , o Li. Genit. Delli , o De’ . Da-
tiv. Alli, o A’ Accusat. I , o Li. Ablat. Dal-
li, o Da’.
Quest’articolo si adopera con tutti i nomi
mascolini di qualunque declinazione, che co-
minciano da consonante, fuorchè innanzi a
que’ nomi, che cominciano da più consonan-
ti , la prima delle quali è un’S., o immedia-
tamente dopo la particella per.
Del
/ BEGIN PAGE 33 /
Del secondo articolo.
SIngulare Nominat. Lo. Genit. Dello. Da-
tiv. Allo. Accusat Lo. Ablat. Dallo. Plu-
rale Nominat. Gli . Genit. Degli . Dat. Agli.
Accusat. Gli. Ablat. Dagli. Quest’ articolo si
adopera avanti a’ nomi mascolini di qualun-
que declinazione , che cominciano da voca-
le , o da S congiunta con altre consonanti ,
o dopo la particella per ; onde si dice : lo
abate, l’orto , lo studio, per lo quale, e non
mai per il quale . Anzi il Boccaccio dopo le
parole accorciate , che finiscono in R , ado-
pera volentieri quest’ articolo , e dice: Mon-
signor lo Re , Messer lo Prete, Messer lo Giu-
dice, e simili .
Del terzo articolo.
SIngulare Nominat. La. Genit. Della. Dat.
Alla. Accusat. La . Ablat. Dalla. Plura-
le Nominat. Le. Genit. Delle. Dat. Alle.
Accusat. Le. Ablat. Dalle . Quest’ articolo si
adopera con tutti i nomi femminini di qual-
sivoglia declinazione .
C CAP.
/ BEGIN PAGE 34 /
CAP. XI.
Della declinazione de’ nomi .
LA Declinazione altro non è, che la va-
riazione del nome ne’ numeri , e ne’ casi.
La varietà de’ numeri si conosce dagli arti-
coli , e dalla terminazione ancora del nome ,
la quale , come dicemmo , è ne’ due numeri
diversa : ma la varietà de’ casi, che dal no-
me non può conoscersi, il quale in ciascun
numero , come fu detto , esce allo stesso mo-
do , si conosce dagli articoli , e da’ segna-
casi . Le declinazioni ordinarie , e regolari
de’ nomi sono quattro, le quali porremo qui
distribuite coll’ articolo . Chi le vorrà fare
col segnacaso, tolga via l’ articolo, e a’ ge-
nitivi , dativi , e ablativi di ciascun nume-
ro ponga il segnacaso.
Prima Declinazione.
QUesta Declinazione comprende i nomi
mascolini terminanti in A . Mutando
l’A in I, si forma il plurale.
Singulare Nominat. Il Profeta. Genit. Del
Profeta . Dat. Al Profeta . Accus. Il Profeta.
Vocat. O Profeta. Ablat. Dal Profeta.
Plurale Nominat. I Profeti, Genit. De’ Pro-
feti.
/ BEGIN PAGE 35 /
feti . Dat. A’ Profeti . Accusat. I Profeti. Vo-
cat. O Profeti . Ablat. Da’ Profeti.
Seconda Declinazione.
QUesta Declinazione comprende i nomi
femminini terminanti in A. Mutata l’A
in E resta formato il plurale .
Singulare Nominat. La Donna. Genit. Del-
la Donna . Dativ. Alla Donna. Accusat. La
Donna . Vocativ. O Donna . Ablativ. Dalla
Donna .
Plurale Nominat. Le Donne. Genit. Delle
Donne. Dativ. Alle Donne . Accusat. Le Don-
Ne . Vocat. O Donne . Ablat. Dalle Donne.
Terza Declinazione.
QUesta Declinazione comprende i nomi
mascolini, e femminini terminanti in E,
la quale mutata in I, n’esce il plu-
rale .
Singulare Nominat. Il Padre, la Madre.
Genit. Del Padre, della Madre . Dat. Al Pa-
Dre , alla Madre Accusat. Il Padre , la Ma-
dre . Vocat. O Padre , o Madre . Ablat. Dal
Padre, dalla Madre .
Plurale Nominat. I Padri, le Madri. Ge-
nit. De’ Padri, delle Madri . Dativ. A’ Pa-
dri, alle Madri. Accusat. I Padri, le Ma-
C 2 dri
/ BEGIN PAGE 36 /
dri. Vocat. O Padri, o Madri, Ablat. Da’
Padri, dalle Madri.
Quarta Declinazione.
QUesta Declinazione comprende i nomi
mascolini, e femminini terminanti in O,
e mutato questo in I, resta formato
il plurale .
Singulare Nominat. Il capo, la mano . Ge-
nit. Del capo , della mano . Dat. Al capo, al-
la mano. Accusat. Il capo, la mano . Vocat.
O capo, o mano . Ablativ. Dal capo , dalla
mano.
Plurale Nominat. I capi, le mani. Genit.
De’ capi, delle mani. Dat. A’ capi , alle ma-
ni. Accusat. I capi , le mani . Vocat. O ca-
pi, o mani. Ablat. Da’ capi, dalle mani.
CAP. XII.
De’ nomi indeclinabili.
ABbiamo de’ nomi indeclinabili , intorno
a’ quali porremo alcune regole, tratte
dal Salviati vol. 2. lib. I. cap. 17., dal Buom-
mattei tratt. 8. cap. 18., e dal Manni lez. 4.
Re-
/ BEGIN PAGE 37 /
Regola prima.
I Nomi, i quali nel singulare finiscono in
consonante , come Alatiel, Agilulf, e si-
mili, sono indeclinabili nel numero, e se si
volessero mettere in plurale, non si variereb-
bero , ma si direbbe : due Alatiel, più Agi-
lulf &c. Nota però il Manni, che i Tosca-
ni sogliono ridurre nel singulare a termina-
zione di vocale non pochi nomi forestieri,
che per se stessi terminano in consonante, e
dire per esempio: Davide , Gabriello , Raf-
faello , Gerusalemme , Israele , e sì fatti, i
quali perciò divengono declinabili ; dimodo-
chè la regola de’ nomi finienti in consonan-
te ha luogo assai di rado.
Regola seconda.
I Nomi, che hanno l’ accento in sull’ulti-
ma, come sono i nomi tronchi, e i mo-
nosillabi, sono indeclinabili, come sono Cit-
tà , carità , virtù, piè, Re, gru, e simili , on-
de si dice : le città , le carità , le virtù, i
piè, i Re, le gru. Quando però tali nomi
si pronunziano interi , e si dice , a cagion
d’esempio, Cittade , caritade , virtude , o vir-
tute, piede , Rege &c., allora sono declina-
C 3 bili,
/ BEGIN PAGE 38 /
bili, ciascuno secondo la regola della sua
declinazione.
Regola terza.
I Nomi , che finiscono in I sono ordinaria-
mente indeclinabili, onde si dice : Parigi,
molti Parigi , un mestieri , molti mestieri , un
mulattieri, due mulattieri &c.
Appendice .
Spezie , superficie , requie sono indeclina-
bili , onde si dice: le spezie , le superfi-
cie e forse le requie .
CAP. XIII.
De’ nomi eterocliti di doppia uscita .
CI sono de’ nomi nella lingua toscana , i
quali nella loro declinazione escono dal-
le ordinarie regole degli altri nomi , e per
questo chiamansi eterocliti. Alcuni nomi pri-
mieramente hanno doppia uscita nel singula-
re , o nel plurale, e di questi non si posso-
no stabilire vere regole , essendo cosa dipen-
dente dall’ uso. Lasciando perciò molti di ta-
li nomi , che anticamente avevano doppia
uscita , e ora non l’ hanno più , faremo al-
cune
/ BEGIN PAGE 39 /
cune osservazioni sopra l’ uso moderno intor-
no a’ nomi di tal sorta, tratte dagli Autori
citati di sopra , e dal Vocabolario della
Crusca.
Osservazione prima.
ALcuni nomi hanno più d’un singulare,
e più d’un plurale. Così nel singulare
si dice : ala , ale , e alia , e nel plurale : ale,
ali , e alie . Nel singulare : arma, e arme,
e nel plurale: armi , e arme. Nel singulare
canzona, e canzone ; e nel plurale canzone,
e canzoni. Nel singulare dote, e dota , e nel
plurale doti, e dote. Nel singulare frode, e
froda, e nel plurale frodi , e frode. Nel sin-
gul. fronde , e fronda e nel plural. frondi, e
fronde. Nel singul. lode , e loda , e nel plur.
Lodi , e lode . Nel singul. macina , e macine ,
e nel plur. macine, e macini. Nel sing. redi-
ne , e redina , e nel plur. redini , e redine .
Nel sing. scure , e scura , e nel plur. scuri,
e scure. Nel sing. tosse, e tossa , e nel plur.
tossi , e tosse . Nel singul. veste, e vesta , e
nel plur, vesti , e veste . Nel sing. orecchio,
e orecchia, e nel plur. orecchi, e orecchie.
C 4 Osser-
/ BEGIN PAGE 40 /
Osservazione seconda .
ALtri nomi hanno più terminazioni nel sin-
gulare, e una sola nel plurale. Due
ne hanno console , e consolo , scolare , e sco-
laro , cavaliere, e cavaliero, pensiere , e pen-
siero. Di tre sono mestiere , mestieri , e me-
stiero : destriere , destrieri, e destriero : leg-
giere , leggieri , e leggiero : mulattiere , mu-
lattieri , e mulattiero . Tutti però hanno la
sola terminazione in I nel plurale.
Osservazione terza .
MOlti altri nomi hanno un solo singula-
re, ma nel plurale hanno più uscite ,
talvolta ancora con incremento . Di questi
nomi se ne trovano molti negli Antichi, ma
non sono ricevuti dal buono uso vegliante
degli odierni Toscani . Ecco i più usitati . Anel-
li , e anella ; bracci , e braccia ; budelli , e budel-
la ; calcagni, e calcagna ; carri, e carra ; castel-
li, e castella ; ciglj , e ciglia ; corni , e corna ;
diti , e dita ; ditelle, e ditella ; fili , e fila ; fon-
damenti , e fondamenta ; frutti , frutte , e frut-
ta ; fusi , e fusa ; gesti , geste , e gesta ; ginoc-
chi, e ginocchia ; granelli, e granella ; interiori,
e interiora ( che manca del singulare ) ; legni, e
legna ; lenzuoli , e lenzuola ; muri , e mura ;
ossi ,
/ BEGIN PAGE 41 /
ossi , osse , e ossa ; quadrelli , e quadrella; risi,
e risa ; membri, e membra; sacchi , e sacca ;
tempi, e tempora , onde diciamo : le quattro
tempora ; vestimenti , e vestimenta .
CAP. XIV.
De’ nomi eterocliti , che hanno un solo
Plurale , ma con desinenza fuori
di regola .
DI questi parimente porremo alcune os-
servazioni cavate da’ libri sopra allega-
ti , perchè non se ne possono formar regole
alla guisa gramaticale .
Osservazione prima.
ALcuni nomi, che nel singulare escono in
O , hanno un solo plurale in A , coll’
articolo femminino , come uovo fa le uova ;
miglio le miglia ; moggio le moggia ; stajo le
staja ; pajo le paja ; centinajo , migliajo , le
centinaja , le migliaja. E così anche i plu-
rali in A de’ nomi accennati nel capitolo pre-
cedente osservaz. 3. hanno l’articolo femmi-
nino.
Osser-
/ BEGIN PAGE 42 /
Osservazione seconda.
DE’ nomi, che nel singulare finiscono in
co , alcuni nel plurale escono in ci, al-
tri in chi. In ci terminano amici, dimestici,
nemici, pubblici , tragici , canonici , cherici,
medici , monaci , eretici , porci, ebraici, gre-
ci . In chi escono fichi , antichi , abbachi , fuo-
chi , cuochi, biechi , ciechi . Alcuni anche pos-
sono terminarsi nell’uno , e nell’ altro modo,
come pratici , e pratichi, salvatici, e salva-
tichi ; mendici , e mendichi.
Osservazione terza .
DE’ nomi , che nel singulare finiscono in
go, alcuni nel plurale terminano in gi,
altri in ghi . In gi escono Teologi, Astrolo-
gi, sparagi. In ghi finiscono draghi , alber-
ghi, dittonghi, spaghi, vaghi , sacrileghi,
funghi. Alcuni hanno l’ una, e l’ altra termi-
nazione , come dialogi, e dialoghi ; analogi,
e analoghi.
CAP. XV.
De’ nomi difettivi .
ANche di questi porremo alcune osserva-
zioni sopra l’uso, tratte da’ già citati
Autori.
Osser-
/ BEGIN PAGE 43 /
Osservazione prima .
NOzze ; vanni per penne , spezie per dro-
ghe ; parecchi, e parecchie mancano del
singulare, e si adoperano sempre in plurale.
Osservazione seconda .
I Nomi numerali cardinali , da uno in su,
quando stanno per addiettivi , mancano del
singulare , onde si addattano solamente a’ plu-
rali , e diciamo : tre anni , quattro case &c.
ma quando stanno per sustantivi , hanno amen-
due i numeri con diversità di terminazione ,
e si dice da’ Toscani : il quattro , e i quat-
tri ; il cinque, e i cinqui &c. Si avverta pe-
rò , che tre, sei, e dieci , quando si adope-
rano sustantivi , servono ad amendue i nu-
meri , ma colla stessa terminazione , dicen-
dosi : un tre ; un sei , un dieci ; due tre , due
sei , due dieci . A questi si può forse aggiu-
gnere due perchè si trova bensì dui nel Vo-
cabolario, ma usato da’ Poeti per conto del-
la rima .
Osservazione terza .
NIuno, nessuno , veruno , ciascuno, ciasche-
duno, qualcuno, ognuno, qualunque, qual-
sivoglia , ogni , e uno , e una numerali ad-
diet-
/ BEGIN PAGE 44 /
diettivi mancano del plurale , perchè sem-
pre sono aggiunti a sustantivi singulari , e
accennano cosa singulare , o a modo di sin-
gulare. Alcuno quando significa , o da se ,
o aggiunto ad altro nome , più cose inde-
terminate , ha plurale . Boccacc. nov. 99.
nel princip. Secondo che alcuni affermano . E
nel Proem. Di niuna altra cosa servieno ,
che di porgere alcune cose dagl’infermi ad-
domandate. Parimente uno , e una sustantivi
hanno plurale . Boccacc. Tanto l’ età l’ uno,
e l’altro da quello, ch’ esser solevano, gli avea
trasformati . E nella Fiamm. Sperava l’ une
cresciute, e l’ altre dover trovare scemate.
Osservazione quarta .
DIo , Sole , Luna, benchè significhino co-
se di lor natura singolari , hanno plu-
rale. Dante . Al tempo degli Dei falsi, e bu-
giardi = Ma s’ ella viva sotto molti soli , Di-
temi chi Voi siete = Onde s’ io ebbi colpa, Più
lune ha volto il sol, poichè fu spenta.
Osservazione quinta .
VEntuno , trentuno , quarantuno , e simili
mancano del plurale , nè variano ter-
minazione o sieno avanti , o dopo il loro
sustantivo , e solo questo si fa singulare, s’ è
dopo,
/ BEGIN PAGE 45 /
dopo , e, s’ è avanti , plurale , onde diciamo :
ventuno scudo , scudi ventuno . Dante nel Con-
viv., citato dal Buommatt., disse : altre no-
vantuna ruota . E il Petrarca nel noto verso:
Tennemi amore anni ventuno ardendo.
Osservazione sesta .
Prole , progenie , e stirpe non si usano in
plurale ; e il simile era di progenia , che
gli antichi dicevano : e così mane per mattina.
CAP. XVI.
De’ pronomi , e prima del pronome IO.
HA il pronome tre generi , mascolino,
femminino , e neutro : ha due numeri,
singulare , e plurale : ha cinque casi , cioè
tutti i casi del nome , dal vocativo in fuo-
ri ( che altro pronome non l’ ha , se non se
il pronome tu ) . Ha finalmente tre persone ,
io è la prima, tu la seconda, e gli altri pro-
nomi sono tutti di terza persona .
De’ pronomi altri sono primitivi, come io ,
tu , se, altri derivativi , come mio , tuo , suo ,
nostro , vostro . I pronomi , i quali dimostra-
no alcuna cosa , come io , tu , questo , quel-
lo &c. , si chiamano dimostrativi ; e relativi
quelli , i quali si riferiscono ad alcuna per-
sona,
/ BEGIN PAGE 46 /
sona , o cosa , come quale , che , cui , chi &c.,
e possessivi quelli , che accennano possedi-
mento , come mio , tuo , vostro &c. Que’ pro-
nomi poi , i quali possono significare ogni co-
sa , e che non particolarizzano determinata-
mente , come uno , alcuno , chiunque , alquan-
to &c. , si chiamano universali indetermina-
ti . Finalmente il pronome può stare in for-
za di sustantivo , e in forza d’ addiettivo ,
come si vedrà in appresso . Ma passiamo a
trattare de’ pronomi primitivi.
IO pronome primitivo , dimostrativo , su-
stantivo, d’amendue i generi , insieme colle
particelle mi , me , ci , ce , ne , le quali tal-
volta in forza di esso si adoperano , si de-
clina nel seguente modo .
Singulare Nominat. Io. Genit. Di me. Dat.
A me , mi , me . Accusat. Me , mi . Ablat. Da
me .
Plurale Nominat. Noi. Genit. Di noi. Dat.
A noi , ci , ce , ne . Accusat. Noi, ci, ce, ne.
Ablat. Da noi .
Le particelle suddette , che fanno le veci
del pronome , possono usarsi spiccate innan-
zi al Verbo , e ancora affisse alla fine del
Verbo , di modo che del Verbo , e di esse
si formi una sola parola .
MI serve per dativo, e per accusativo al
pronome Io col Verbo , o dopo il pronome
relativo . Bocc. Voi mi potete torre quant’ io
tengo ,
/ BEGIN PAGE 47 /
tengo , e donarmi , siccome vostro Uomo , a chi
vi piace = Nè negare il mi puoi, se io il di-
siderassi = Bastiti l’ averlomi fatto conoscere .
In vece di mi si adopera me nel dativo in-
nanzi al pronome relativo, e alla particella
ne . Bocc. Tu dì di farmelo vedere ne’ vivi =
Per veder fare il tomo a que’ maccheroni, e
tormene una satolla .
CI serve per dativo , e per accusativo col
Verbo, o dopo il pronome relativo , e vale lo
stesso , che a noi, e noi . Bocc. Correrannoci
alle case , e l’ avere ci ruberanno = Il vostro
senno , più che ’l nostro avvedimento , ci ha
qui guidati . In vece di ci si adopera ce avan-
ti il pronome relativo , e la particella ne .
Bocc. g. 10. n. 8. Gli amici noi abbiamo qua-
li ce gli eleggiamo, e i parenti quali gli ci
dà la fortuna = Tu non ce ne potresti far più.
NE serve parimente per dativo , e per ac-
cusativo plurale. Bocc. Il mandarlo fuori di
casa nostra così infermo , ne sarebbe gran bia-
simo . E nell’ Introd. Sole in tanta afflizione
n’ hanno lasciate ; cioè hanno lasciato noi.
CAP. XVII.
Del pronome Tu.
TU pronome primitivo, dimostrativo, su-
stantivo , seconda persona , di genere
comune , colle particelle ti , te , vi , ve , che
ne
/ BEGIN PAGE 48 /
ne fanno sovente le veci , si declina come
siegue .
Singulare Nominat. Tu. Genit. Di te . Dat.
A te , ti , te . Accusat. Te , ti . Vocat. O tu
Ablat. Da te .
Plurale Nominat. Voi. Genit. Di Voi . Dat.
A voi , vi , ve . Accusat. Voi, vi, ve . Vo-
cat. O voi. Ablat. Da voi .
TI serve per dativo, e per accusativo sin-
gulare , o spiccato , o affisso col Verbo , o
dopo il pronome relativo . Bocc. g. 8. n. 7.
S’ egli ti fu tanto la maladetta notte grave ,
e parveti il fallo mio così grande, che non ti
posson muovere a pietate alcuna le amare la-
grime , nè gli umili prieghi , almeno muovati
alquanto , e la tua severa rigidezza diminuisca
questo solo mio atto = Dio il ti perdoni. TE in
vece di ti si dice avanti il pronome relati-
vo , e la particella ne . Bocc. Io non me ne
maraviglio, nè te ne so ripigliare = Senz’ al-
cun maestro, io tel trarrò ottimamente .
VI serve per dativo, e per accusativo plu-
rale col verbo , o dopo il pronome relativo ;
ma avanti al pronome relativo , o alla par-
ticella ne si adopera ve. Bocc. S’ io v’ amassi,
come già amai, io non avrei ardire di dirvi
cosa , che io credessi , che nojar vi dovesse =
S’ elle vi piacciono io le vi donerò volentie-
ri = Piacevi di rivolerlo , ed a me dee piace=
re , e piace di renderlovi = Come questo av-
venu-
/ BEGIN PAGE 49 /
venuto mi sia , brievemente vel farò chiaro =
Ch’ io dica il vero , questa pruova ve ne pos-
so dare = Mi piace di farvene più chiare con
una picciola novelletta .
CAP. XVIII.
Del pronome Se.
SE pronome primitivo, che manca del no-
minativo, e del vocativo, e colle stesse
voci serve ad amendue i generi , e numeri,
si declina col segnacaso nel modo seguen-
te , colla particella si , che ne supplisce le
veci .
Genit. Di se. Dat.A se,si. Accusat. Se, si.
Ablat. Da se .
Questo pronome significa il riverbero, per
così dire , della significazione nella terza per-
sona , di cui si tratta, o sia il ritorno dell’
azione nell’agente . Si adopera in tutti i ge-
neri , e numeri . Bocc. Il Duca queste cose
sentendo , a difesa di se similmente ogni suo
sforzo apparecchiò = Ciascuna verso di se bel-
lissima = Apertamente confessarono , se essere
stati coloro , che Tedaldo Elisei ucciso aveano .
La particella si fa le veci di questo pro-
nome nel dativo, e nell’ accusativo d’amen-
due i generi, e numeri Bocc. Davanti si vi-
de due, che verso di lui con una lanterna in
D mano
/ BEGIN PAGE 50 /
mano venieno = Gran festa insieme si fecero =
Di quindi marina marina si condusse fino a Tra-
ni = E g. 2. n. 8. Essa sopra il seno del Con-
te si lasciò colla testa cadere = Alla qual co-
sa il Priore, e gli altri Frati creduli s’ ac-
cordarono . = Dopo alquanto risentita , e leva-
tasi , colla fante insieme , verso la casa di lui
si dirizzaro.
Se usato in forza di sustantivo significa l’ in-
Terno , e ammette l’articolo . Salvin. ne’ disc.
Parmi , che nel suo se così dicesse Platone .
CAP. XIX.
De’ pronomi derivativi.
MIo , tuo, suo, nostro, vostro si chiama-
no pronomi derivativi , perchè deriva-
no , e si formano da’ primitivi, e possessivi,
perchè dinotano possedimento.
Mio nel plurale fa miei ; mia mie ; tuo tuoi ;
tua tue ; suo suoi ; sua sue ; nostro nostri ; no-
stra nostre ; vostro vostri , vostra vostre . Si de-
clinano come gli altri pronomi , talvolta coll’
articolo , talvolta col segno del caso.
Quando tali pronomi sono addiettivi ac-
compagnati col loro sustantivo, vogliono l’ar-
ricolo, o altra particella , che gli regga.
Bocc. Per quanto tu hai caro il mio amore =
Aveva , siccome se , le sue cose messe in ab-
bando-
/ BEGIN PAGE 51 /
bandono = O molto amato cuore, ogni mio ufi-
cio verso te è fornito = Se tu ti contenti di la-
sciare appresso di me questa tua figlioletta . E
g. I. n. 2. Questa fatica , per mio consiglio, ti
serberai in altra volta .
Qualche fiata da tali pronomi addiettivi ,
come sopra , si toglie ogni appoggio d’ arti-
colo , e d’altra particella , per proprietà di
linguaggio , e così in prosa , come in ver-
so. Bocc. Ho fatte mie piccole mercatanzie .
Petrar. Sua ventura ha ciascun dal dì , che na-
sce . Bocc. Che tu mandi il segnal tuo al Mae-
stro Simone , che è così nostra cosa , come tu
sai . Dante . Matto è chi spera , che nostra
ragione . Possa trascorrer la ’nfinita via, Che
tiene una sustanzia in tre persone . Petrar. Un
dubbio verno, un’ instabil sereno E‵ vostra fa-
ma , e poca nebbia il rompe , E ’l gran tem-
po a’ gran nomi è gran veneno , Passan vostri
trionfi, e vostre pompe. E noi sogliamo di-
re tutto dì : mio, o suo padre , tua madre,
nostro fratello , vostra sorella .
Talvolta questi pronomi si congiungono col
Verbo sustantivo, senz’alcuno appoggio d’ar-
ticolo , o di nome , e significano libertà , o
appartenenza . Bocc. Labir. p. 52. Alla qua-
le disposizione fu la Divina grazia sì favo-
revole, che infra pochi dì la mia perduta li-
bertà racquistai , e come io mi soleva , così
sono mio. E g. 8. n. 4. Son disposta, poscia-
D 2 chè
/ BEGIN PAGE 52 /
chè io così vi piaccio , a voler esser vostra .
Nel plurale, senz’ appoggio di nome , ma
coll’ articolo, si adoperano tali pronomi per
significare i parenti , i famigliari , e simili .
Petrar. Ove giace ’l tuo albergo , e dove nac-
que Il nostro amor , vo’ , ch’ abbandoni , e la-
sce , Per non veder ne’ tuoi quel , che a te
spiacque . Bocc. Vassene , pregato da’ suoi, a
Chiassi . Petrar. Vidi verso la fine il Saraci-
no , Che fece a’ nostri assai vergogna, e dan-
no .
Si adoperano ancora tali pronomi neutral-
mente, senz’appoggio di nome, ma coll’ar-
ticolo, e significano la roba, l’ avere, le so-
stanze . Bocc. Non so cui io mi possa lasciare
a riscuotere il mio da loro più convenevole di
te. Nov. ant. La vecchia disse a colui allora :
vieni , e domanda il tuo . Bocc. Or mangi del
suo , s’egli n’ ha , che del nostro non mange-
rà egli oggi = Se io vi vidi , io vi vidi in
sul vostro.
CAP. XX.
De’ pronomi dimostrativi di persona.
DI questi pronomi alcuni dimostrano per-
sona prossima a chi parla , altri perso-
na prossima a chi ascolta , altri persona ter-
za , e distinta da chi parla , e da chi ascol-
ta ,
/ BEGIN PAGE 53 /
ta , ed altri finalmente si aggiungono per as-
severanza , e per maggior forza d’ espres-
sione.
Pronomi , che dimostrano persona prossima
a chi parla .
QUESTI è pronome mascolino, che si di-
ce solamente d’uomo , e manca del vo-
cativo. Si declina a questo modo. Sin-
gulare , Questi, di questo, a questo, questo,
da questo. Plurale . Questi, di questi, a que-
sti , questi, da questi.
Quando adunque si dice questi in nomina-
tivo sustantivamente , e senz’ appoggio , s’ in-
tende questo Uomo . Bocc. Questi è il mio Si-
gnore , questi veramente è Messer Torello . Pe-
trar. Questi in sua prima età fu dato all’ ar-
te Da vender parolette , anzi menzogne.
Adoperandosi come addiettivo accompa-
gnato col sustantivo , allora , anche in no-
minativo , si dice questo . Bocc. Questo gar-
zoncello s’ incominciò a dimesticare con questo
Federigo.
Il dir questo in nominativo sustantivamen-
Te , parlando d’ Uomo , è riputato errore .
Pure alcuni adducono esempj in contrario de-
gli Autori del buon secolo , singolarmente
uno del Petrarca nel Trionfo della Fama ,
così citato dal Vocabolario : Questo cantò gli-
D 3 erro-
/ BEGIN PAGE 54 /
errori , e le fatiche Del figliuol di Laerte .
Ma il Manni lez. 6. dice , che le buone im-
pressioni leggono questi , e non questo .
Trovasi alcuna volta questi nel nominati-
vo , benchè non riferito ad Uomo . Bocc.
Dall’ una parte mi trae l’ amore , e d’ altra mi
trae giustissimo sdegno : quegli vuole , ch’ io ti
perdoni, e questi vuole , che contro a mia na-
tura in te incrudelisca Potrebbe forse dirsi ,
che ’l Boccaccio , siccome dà in certo mo-
do la persona a quelle due passioni , così ad-
datti loro i pronomi proprj dell’ Uomo .
QUESTA pronome femminino , che si di-
ce solamente di donna , e manca del voca-
tivo si declina così . Singulare . Questa , di
questa , a questa , questa , da questa. Plurale.
Queste, di queste , a queste , queste , da queste .
Questo pronome si adopera ordinariamente
addiettivo accompagnato col sustantivo . Si
trova però usato assolutamente, e a modo di
sustantivo , e nel caso retto , e negli obbli-
qui, e vale nel singulare : questa donna , e
nel plurale : queste donne . Petrar. Questa an-
cor dubbia del fatal suo corso Intrò di prima-
vera in un bel bosco = Queste gli strali , E la
faretra , e l’ arco avean spezzato A quel pro-
tervo , e spennacchiate le ali . Bocc. nel La-
bir. Ha faccenda soperchia pur di far motto a
questa , e a quell’altra , e di sufolare ora ad
una, ora a un’ altra nelle orecchie.
CO-
/ BEGIN PAGE 55 /
COSTUI pronome mascolino vale lo stes-
so, che questi , cioè quest’ uomo . Si declina
a questo modo . Singulare . Costui , di costui ,
a costui , costui , da costui . Plur. Costoro , di
costoro , a costoro , costoro , da costoro . E così
Costei femminino , che nel singulare si decli-
na col segnacaso ; ma non ha proprio plu-
rale , e si serve di quello di costui .
Si truova usato di cosa inanimata , e di
animale fuori della spezie dell’ Uomo . Bocc.
Filoc. Io ho meco questo anello : la virtù di
costui credo , che ’l mio periclitante legno aju-
tasse = Di questo intendimento un pappagallo
mi tolse : a seguitar costui si dispose alquan-
to più l’ animo , che alcuno degli altri uccelli .
Dante . O Alberto Tedesco , che abbandoni Co-
stei ( l’Italia ) ch’ è fatta indomita , e selvag-
gia .
Si adopera talvolta nel genitivo senza se-
gno. Bocc. Salabaetto lieto s’ uscì di casa co-
stei = Gio. Vill. Al costui tempo Leone Papa
Quarto fece rifare la Chiesa di Santo Piero .
Pronomi , che dimostrano persona prossima
a chi ascolta .
COTESTI, COTESTA . Singulare . Cote-
sti, cotesta ; di cotesto , di cotesta ; a co-
testo , a cotesta ; cotesto , cotesta ; da cotesto ,
da cotesta . Plur. Cotesti, coteste ; di cotesti ,
D4 di
/ BEGIN PAGE 56 /
di coteste ; a cotesti , a coteste ; cotesti , co-
teste ; da cotesti , da coteste .
Questo pronome nel nominativo singulare
si dice solamente d’ uomo, e vale l’ uomo
prossimo a chi ascolta. Dante. Cotesti , che
ancor vive , e non si noma, Guardere’ io , per
veder s’ il conosco , E per farlo pietoso a que-
sta soma .
Quando si adopera addiettivo col sustanti-
vo , nel nominativo singulare si dice: cote-
sto . Bocc. Innanzi che cotesto ladroncello ,
che v’ è costì dallato , vada altrove .
Ne’ casi obbliqui del singulare , e nel plu-
rale si dice , non solamente d’ uomo , ma di
ogni altra cosa . Dante . E tu, che se’ costì
anima viva , Partiti da cotesti , che son mor-
ti . Bocc. Veggendovi cotesti panni indosso , i
quali del mio marito morto furono .
COTESTUI vale lo stesso , che cotesti . Si
declina così . Singolare . Cotestui, di cote-
stui, a cotestui, cotestui, da cotestui. Plur. Co-
testoro, di cotestoro, a cotestoro, cotestoro ; da
cotestoro . Bocc. Se cotestui se ne fidava, ben
me ne posso fidare io . Nov. Ant. Perchè bat-
tete voi cotestoro?
Pro-
/ BEGIN PAGE 57 /
Pronomi dimostrativi di persona terza.
QUattro sono i pronomi di questa sorta ;
tre corrispondenti al latino ille , illa,
e sono egli, ella ; quegli , quella ; co-
lui, colei ; è uno corrispondente al latino
ipse, ed è esso, essa.
EGLI , colle particelle il, lo, gli , li , che
ne fanno le veci , e si chiamano pronomi re-
lativi, si declina così . Singulare . Egli , e per
accorciamento ei, ed e’ , di lui, a lui, gli,
li, lui, il, lo, da lui. Plurale . Egli, e’ , o egli-
no , di loro, a loro, loro, gli , li, da loro.
Questo pronome si dice di persona. Bocc.
Io intendo di torre via l’ onta , la quale egli
fa alla mia sorella = Avendo riguardo alla
ingratitudine di lui verso mia madre mostra-
ta = Com’ egli hanno tre soldi , vogliono le fi-
gliuole de’ gentiluomini, e delle buone donne per
moglie = E g. 10. n. 8. A lui, e alla madre
narrò lo ’nganno , il quale ella , ed eglino da
Gisippo ricevuto aveano = E loro, i quali amor
vivi non aveva potuti congiugnere , la morte
congiunse . Si truova detto talvolta anche di
cosa inanimata . Bocc. Filoc. Egli avea l’a-
nello assai caro , nè mai da se il dipartiva ,
per alcuna virtù, che stato gli era dato ad in-
tendere , che egli avea . E di bestia nel Bocc.,
il quale del buon falcone di Federigo disse :
pre-
/ BEGIN PAGE 58 /
presolo, e trovatolo grasso , pensò lui esser de-
gna vivanda di cotal donna.
Egli si truova presso a qualche antico usa-
to ne’ casi obliqui . Così Francesco da Bar-
berino disse : Ma guardati da egli, Che so-
glion esser fegli.
Il dire lui per egli, e loro per eglino nel
nominativo, è errore di gramatica contro al-
la suddetta declinazione, benchè si oda tut-
todì ne’ discorsi famigliari. Nel Vocabolario
si portano due esempj di Autori moderni ,
cioè del Burchiello , e del Firenzuola ne’ Lu-
cidi , i quali adoperarono lui per egli , ma
s’aggiugne , che il fecero sregolatamente .
Quando però il Verbo essere si adopera in
certe forme, usasi dopo di esso lui per egli.
Bocc. g. 2. n. 5 Costoro , che dall’ altra parte
Erano , siccome lui , maliziosi , tiraron via il
Puntello . E g. 3. n. 7. Maravigliossi forte Te-
daldo, che alcuno in tanto il simigliasse , che
fosse creduto lui . Anzi si trova lui reggere
altro verbo attivo. Bocc. n. 4. Dalla sua col-
pa stessa rimorso , si vergognò di fare al mo-
naco quello , ch’egli , siccome lui , aveva me-
ritato .
Gli antichi per egli usavano elli, ed ello,
e nel plurale elli, ed ellino . Liv. M. Appio ,
diss’elli, per forza d’ arme mi convien quinci
esser cacciato . Petrar. E veggio ben quant’ elli
a schivo m’ hanno = E rallegrisi il Ciel, ov’ el
lo
/ BEGIN PAGE 59 /
lo è gito . Nov. ant. 38. Ellino nell’ altre co-
se l’ ubbidiano .
Quanto alle sopraccennate particelle , il ,
e lo fanno le veci di lui accusativo singula-
re , il primo innanzi a consonante , l’ altro
innanzi a vocale , o all’ s seguita da altra
consonante. Bocc. Assai volte in vano il chia-
mò = Se d’ una cosa sola non lo avesse la for-
tuna fatto dolente = Tanto l’ affezione del fi-
gliuol lo strinse, ch’ egli non pose l’ animo al-
lo ’nganno fattogli dalla moglie .
Gli , e li servono per dativo singulare , e
per accusativo plurale Bocc. Per alcuno ac-
cidente sopravvenutogli , bisognandogli una
buona quantità di danari , gli venne a memo-
ria un ricco Giudeo = Trovarono chi per va-
ghezza di così ampia eredità gli uccise. Gio.
Vill Il seguente dì apparve per visione Cri-
sto a Ruberto, dicendoli , che in forma di leb-
broso li s’ era mostrato , volendo provare la sua
pietà . Petrar. O li condanni a sempiterno pianto.
L’usare gli, o li per dativo plurale , di-
cendo per esempio: gli, o li diede per diede
loro, è bensì modo usitato nel volgo , ma è
poco regolato, come dice il Vocabolario, il
quale contuttociò ne adduce molti esempj
d’ antichi .
ELLA pronome femminino si declina a que-
sto modo. Singolare . Ella , di lei, a lei, o le,
lei , o la , da lei . Plurale , Elle , o elleno , di
loro , a loro , loro , o le , da loro.
Si
/ BEGIN PAGE 60 /
Si noti , che le particelle la , e le , che si
adoperano in vece del pronome ella, si chia-
mano , come i detti di sopra , pronomi rela-
tivi, nel modo , che si spiegherà sul fine del
libro secondo .
Ella si dice nel nominativo , e non lei ,
com’ è usanza del volgo . Si fa da’ gramati-
ci molta quistione sopra alcuni esempj de-
gli antichi , ne’ quali pare, che lei sia stato
usato in caso retto . Il più celebre è quello
del Petrarca sonetto 93. citato da’ migliori
gramatici , e , quel ch’ è più, dal Vocabola-
rio alla V. Disprezzare , in questo modo : E
ciò, che non è lei, Già per antica usanza odia ,
e disprezza . Pure il Manni lez. 5., con ad-
durre manuscritti, legge così : E ciò, che non
è in lei , Già per antica usanza odia , e di-
sprezza. Vedi al lib. 2. de’ gerundj .
La per ella nel retto , benchè nel parlar
famigliare molto da’ Toscani si dica , e se ne
trovino esempj di scrittori , non pare, dicesi
nel Vocabolario , assolutamente da usarsi .
Gli antichi Poeti usarono ella ne’ casi obli-
qui . Petrar. E sosterrei , Quando ’l ciel ne
rappella , Girmen con ella in sul carro d’ Elia .
Lei nel dativo è stato talora usato senza
segno . Dante. Ond’ io risposi lei: non mi ri-
corda , Ch’ io straniassi me giammai da voi .
Talvolta lei si trova riferito a bestia , o a
cosa inanimata . Pctrar. Fama nell’ odorato , e
ricco
/ BEGIN PAGE 61 /
ricco grembo D’ arabi monti lei ( la Fenice ) ri-
pone , e cela . Bocc. Videro il drappo, ed in
quello la testa non ancor sì consumata, che essi
alla capellatura crespa non conoscessero , lei es-
ser quella di Lorenzo .
Circa le suddette particelle , le serve di
dativo singulare , e di accusativo plurale .
Bocc. La giovane cominciò a dubitare , non
quel suo guardar così fiso movesse la sua ru-
sticità ad alcuna cosa , che vergogna le potes-
se tornare = S’ elle vi piacciono , io le vi do-
nerò . La serve di accusativo singulare. Bocc.
Ad una lor possessione la ne mandò.
QUEGLI si declina così . Singulare . Que-
gli , o que’ , di quello , a quello , quello , da
quello. Plurale. Quelli, quegli, que’ , o que-
glino , di quelli, a quelli, quelli, da quelli.
Trovasi alcuna volta quegli in caso retto
non riferito ad Uomo , come appare dall’
esempio del Boccaccio citato sotto al pro-
nome questi.
Talvolta ancora si trova usato in caso ret-
to quello in vece di quegli , riferendosi ad
Uomo . Petrar. Quel, ch’ infinita providenzia,
ed arte Mostrò nel suo mirabil magistero. Al-
bertan. Maggiormente è da amare lo ladro ,
che quello, che sta cotidianamente in bugie.
Ne’ casi obbliqui del singolare si trova, con-
tro la regola, quegli , o quei riferito a Uo-
mo. Dante . I’ mi rendei Piangendo a quel, che
volen-
/ BEGIN PAGE 62 /
volentier perdona. Passav. pag, 69. Per questo
entrare nella Chiesa intende la confessione, per
la quale altri si rappresenta, per lo comanda-
mento della Chiesa , a quegli , che Vicario di
Cristo è nella Chiesa.
QUELLA pronome femminino si declina
senza variazione col segnacaso, e in plurale
fa quelle. Si usa per colei , col relativo do-
po Petrar p. 2. son. 23 Le mie notti fa tri-
ste, e i giorni oscuri Quella , che n’ ha por-
tato i pensier miei.
COLUI , e COLEI si usano solamente di
persona . Si declinano senza variazione col
segnacaso. In plurale fanno coloro , che ser-
ve ad amendue i generi. Colei si trova det-
to , e di persona ideale, e di cosa inanima-
ta . Il Petrarca fa parlare la morte così : Io
son colei, che sì importuna , e fera Chiama-
ta son da voi , e sorda , e cieca . E Dante,
parlando della rena , dice: Lo spazzo era una
rena arida , e spessa , Non d’ altra foggia fat-
ta, che colei, Che fu da’ piè di Caton già sop-
pressa .
ESSO, ESSA, lo stesso che egli , ed ella.
Si declinano senza variazione in amendue i
numeri col segnacaso . Esso nel plurale fa
essi ; essa , esse . Posti avanti a nome sustan-
tivo sono addiettivi . Bocc. g. 2. n 3. Ebbe
tre figliuoli , quantunque il maggiore a diciot-
to anni non aggiugnesse , quando esso Messer
Tebal-
/ BEGIN PAGE 63 /
Tebaldo ricchissimo venne a morte. Dante.
Vid’ io in essa luce altre lucerne . Avanti no-
me addiettivo, o pronome hanno forza di
sustantivi. Bocc. Acciocchè esso solo possedesse
la guadagnata preda. E g. I. n. 3 Sì furono
simiglianti , che esso medesimo , che fatti gli
avea fare, appena conosceva, qual si fosse il
vero . E g. 2. n.10. Con ardentissimo diside-
rio esso stesso dispose d’ andar per lei.
Pronomi , che aggiungono asseveranza,
o espressione .
DESSO, DESSA pronomi asseverativi,
che dimostrano con maggior efficacia,
e voglion dire : quello stesso , quel proprio ,
quella stessa , quella proprio . Non hanno al-
tro caso , che il nominativo in amendue i
numeri. Bocc. Hai tu sentito stanotte cosa niu-
na? tu non mi par desso . Petrar. Ch’ i’ grido :
ell’ è ben dessa, ancora è in vita.
Talvolta dimostrano , non persona, ma co-
sa. Bocc, g. 10. n. 9. Vide quelle robe , che al
Saladino aveva la sua donna donate , ma non
estimò dover poter essere, che desse fossero. E
g. 6. n. 5. Niuna cosa dalla natura , madre di
tutte le cose, ed operatrice, col continuo girare
de’ cieli, fu, ch’ egli collo stile , e colla penna,
e col pennello non dipignesse sì simile a quella,
che non simile, anzi piuttosto dessa paresse.
Si
/ BEGIN PAGE 64 /
Si usano alcuna volta in significato di co-
lui , o colei . Bocc. g. 10. n. 8. Io temo, che i
parenti suoi non la dieno prestamente ad un’ al-
tro, il qual forse non sarai desso tu . E g. 3.
n. 3. Ti dico io di lei cotanto , che se mai io ne
trovai alcuna di queste sciocchezze schifa , el-
la è dessa.
Talora desso posto neutralmente significa co-
sì proprio, come si dice, si teme, o si spera.
Bocce. g. 2. n. 8. Il gentiluomo, e la sua donna,
questo udendo , furon contenti , in quanto pure
alcun modo si trovava al suo scampo , quantun-
que loro molto gravasse , che quello , di che du-
bitavano , fosse desso , cioè di dover dare la
Giannetta al loro figliuolo per isposa.
MEDESIMO , MEDESIMA si adoperano
in compagnia di altro pronome , o di un no-
me , e con questi si accordano nel genere , e
nel numero, faccendo nel plurale medesimi , e
medesime, e si declinano ancora coll’ artico-
lo , e aggiungono forza d’ espressione . Il dire
medemo , come pur usano alcuni , è errore,
e medesmo è voce poetica . Bocc. Labir. Guar-
dando tra molte , che quivi n’ erano in quello
medesimo abito = Il terzo quasi in questa me-
desima sentenzia , parlando , pervenne = E g.
4. n. 2. Prima se medesimi, e poscia coloro , che
in ciò alle loro parole dan fede , sforzandosi d’in-
gannare = Purchè noi medesime nol diciamo .
Petrar. Di me medesmo meco mi vergogno.
Mede-
/ BEGIN PAGE 65 /
Medesimo posto coll’ articolo, o con pro-
nome neutro , vale l’ illud idem de’ Latini.
Di ciò apporta il Cinonio uno esempio del
Bocc. nel Labirinto, che dice : E quello, che
di questa parte ho detto , quel medesimo di-
co della seconda .
In vece di medesimo talvolta si dice uno .
Ricord. Malesp. La nostra Città di Fiorenza ,
ch’ era uno co’ Romani , non potea respira-
re . Dante. Amore , e ’l cor gentil sono una
cosa .
STESSO, STESSA vagliono quanto mede-
simo, e medesima, e con pari regola procedo-
no. Bocc. Creduto abbiamo , che costei nella
casa, che mi fu quel dì stesso arsa , ardesse. Pe-
trar. Ma com’ è , che sì gran romor non suone
Per altri messi, o per lei stessa il senta? Bocc.
nel Proem. Avendo essi stessi , quando sani era-
no , esemplo dato a coloro , che sani rimaneva-
no . E g. 3. n. I. Elle non sanno delle sette vol-
te le sei quello , ch’ elle si vogliono elleno stes-
se . E neutralmente . Petrar. p. 2. son. 61.
Che quello stesso, ch’ or per me si vole , Sem-
pre si volse .
E CAP.
/ BEGIN PAGE 66 /
CAP. XXI.
De’ pronomi dimostrativi di cosa.
CI sono quattro pronomi dimostrativi di
cosa; cioè questo , questa , questo , che
dimostra cosa prossima a chi parla , e cor-
risponde all’ hic , hæc , hoc de’ Latini: cotesto,
cotesta , cotesto , che dimostra cosa prossima
a chi ascolta , e corrisponde all’ iste , ista ,
istud de’ Latini : quello , quella , quello , che
dimostra cosa terza , e non prossima a’ par-
lanti, e corrisponde all’ ille , illa , illud de’
Latini. Quando tali pronomi son mascolini ,
o femminini , sono addiettivi ; ma quando
sono neutri, si adoperano a modo di sustan-
tivi. Il quarto è il pronome ciò , che si ado-
pera indifferentemente per gli altri tre , ma
neutralmente . Vegniamo agli esempj.
Questo.
Bocc. g. I. n. 5. Dama, nascono in questo
paese solamente galline , senza gallo alcuno?
E g. 9 n. 8 Fostù a questa pezza dalla loggia
de’ Cavicciuli? E g. 10. n. 6. Queste parole
amaramente punsero l’ animo del Re . Petrar.
canz. 33. Che fanno meco omai questi sospiri,
Che nascean di dolore? E Bocc. g.I.n. 2. Quando
Giannotto intese questo , fu oltremodo dolente.
Dan-
/ BEGIN PAGE 67 /
Cotesto.
Dante Inf. cant. 29. Se l’ unghia ti basti
Eternalmente a cotesto lavoro. Boccacc. n. I.
Cotesta non è cosa da curarsene . E ivi . Co-
me ti se’ tu spesso adirato? O , diße Ser Ciap-
pelletto , cotesto vi dico io bene, che io ho mol-
to spesso fatto.
Quello.
Bocc. Introd. Prendendo le nostre fanti , e col
le cose opportune faccendoci seguitare oggi in
questo luogo, e domani in quello , quella alle-
grezza, e festa prendendo , che questa tempo può
porgere . E ivi : io non so quello, che de’ vo-
stri pensieri voi v’ intendete di fare.
Ciò.
Bocc. Introd. Ad un fine tiravano assai cru-
Dele ; ciò era di schifare, e di sfuggire gl’ in-
Fermi . E n. I. Va via, figliuol , ch’ è ciò, che
tu dì? E n. 3. A volervene dire ciò, che io ne
sento, mi vi convien dire una novelletta , qual
voi udirete . E g. 3. n. I. Ed egli è il miglior del
mondo da ciò costui.
CAP. XXII.
De’ pronomi relativi.
QUALE, che in plurale fa quali , se ha
l’articolo, è pronome relativo, che si
riferisce a persona, o a cosa antece-
E2 dente,
/ BEGIN PAGE 68 /
dente , e si declina con amendue gli artico-
li mascolino, e femminino. Bocc. Dioneo , il
quale, oltre ad ogni altro , era piacevole gio-
vane . E ivi : Filomena, la quale discretissima
era . E ivi . De’ quali l’uno era chiamato Pan-
filo . E ivi : Sette giovani donne, i nomi delle
quali io in propria forma racconterei . E g. 4.
n. 2. Usano i volgari un così fatto proverbio :
chi è reo, e buono è tenuto , può fare il ma-
le , e non è creduto . Il quale ampia materia
a ciò , che m’ è stato proposto , mi presta di fa-
vellare . E nell’ Introd. Mossi non meno da te-
ma , che la corruzione de’ morti non gli offen-
desse, che da carità , la quale avessero a’ tra-
passati .
In vece del pronome quale si usa la par-
ticella onde . Bocc. Essi fanno ritratto da quel-
lo , onde nati sono . Petrar. Voi, ch’ ascoltate
in rime sparse il suono Di que’ sospiri, ond’ io
nudriva il core .
Quale senz’ articolo dinota qualità assolu-
ta. Bocc. Seco pensando, quali infra piccol ter-
mine dovean divenire .
CHE relativo di sustanza riferisce tutti i
generi , e tutti i numeri . Si declina col se-
gnacaso , e la stessa voce serve ad amendue
i numeri . Bocc. Potranno conoscer quello , che
sia da fuggire = Siccome quella , ch’ era d’ al-
to ingegno . = Le cose , che appresso si legge-
ranno . Petrar. Gli occhi , di ch’ io parlai sì
caldamente. Che
/ BEGIN PAGE 69 /
Che relativo di qualità, o quantità vale lo
stesso , che quanto, o quale . Bocc. Dio il sa,
che dolore io sento = Odi gli osti nostri , che
hanno non so che parole insieme = Che uomo è
costui ?
Al che relativo s’ aggiugne talvolta l’ arti-
colo il, e vale: la qual cosa . Bocc. Il che
degl’ innamorati uomini non avviene = Io vi
farei goder di quello, senza il che per certo
niuna festa compiutamente è lieta. E talora si
sottintende l’ articolo , singolarmente nelle
parentesi . Bocc. L’ un fratello l’altro abban-
donava , e ( che maggior cosa è ) i padri , e
le madri i figliuoli. E talora in vece dell’ar-
ticolo vi si pone il segnacaso. Bocc. n. 7.
Domandò, quanto egli allora dimorasse presso
a Parigi, a che gli fu risposto , che forse a sei
miglia.
Che talvolta si usa per nel quale Bocc. In
quel medesimo appetito cadde , che cadute era-
no le sue Monacelle .
CHI significa colui che , alcuno , il quale , o
quale . Serve ad amendue i generi , e nume-
ri , e si declina invariato col segnacaso per
amendue i numeri . Bocc. Da chi non le cono-
sce sarebbono, e son tenute grandi, ed onestis-
sime donne . = Chi sieno i mercatanti, che l’han-
no = Non credi tu trovar qui chi il battesmo
ti dea? = Parli chi vuole in contrario .
CUI relativo di persona , d’ amendue i ge-
E3 neri,
/ BEGIN PAGE 70 /
neri , e numeri , che si declina invariato col
segnacaso , il quale spesso lascia per proprie-
tà di linguaggio. Bocc. g. 2. n.7. La figliuola
del Soldano, di cui è stata così lunga fama ,
che annegata era = Il buon uomo , in casa cui
morto era, disse alla Salvestra = Macchie ap-
parivano a molti , a cui grandi, e rade , e a
cui minute, e spesse. Petrar. Voi , cui fortuna
ha posto in mano il freno Delle belle contrade.
Bocc. Non guardando cui motteggiasse, creden-
do vincere, fu vinta. Dante. Lo buon maestro
disse : figlio , or vedi L’ anime di color , cui
vinse l’ira. Bocc. Come essi, da cui egli cre-
dono, sono beffati. Petrar. E quella, in cui l’e-
tade Nostra si mira .
Talora si pone coll’ articolo avanti, che
non è però suo , ma del nome , ed in tal
caso è sempre genitivo . Bocc. Gli cui costu-
mi , ed il cui valore son degni di qualunque
gran donna .
Si adopera ancora alcuna volta per rela-
tivo di bestie , e di cose inanimate . Bocc.
g. 4 n.7. Era sotto il cesto di quella salvia
una botta di maravigliosa grandezza , dal cui
venenifero fiato avvisarono , quella salvia es-
sere velenosa divenuta. E n. 8. Tra l’ altre
naturali cose, quella , che meno riceve consi-
glio , o operazione in contrario , è amore, la
cui natura è tale, che più tosto per se medesi-
mo consumar si può, che per avvedimento tor via.
CA-
/ BEGIN PAGE 71 /
CAP. XXIII.
De’ pronomi universali indeterminati.
NE sono di quattro sorte , perchè alcuni
dinotano generalità, altri distribuzione,
altri qualità , altri diversità .
Pronomi di generalità .
OGNI significa tutto di numero, ed è
pronome invariabile , di genere comu-
ne, che si declina nel singulare col segnaca-
so , ma si addatta malvolentieri al plurale,
col quale contuttociò l’ accordarono talvolta
gli antichi. Corrisponde all’ omnis de’ Lati-
ni , e si accompagna , a maniera d’ addietti-
vo, co’ nomi d’ amendue i generi. Bocc. n.2.
E , per quello ch’ io estimi , con ogni solleci-
tudine , e con ogni ingegno, e con ogni arte,
mi pare che si procaccino di riducere a nulla,
e di cacciare del Mondo la Cristiana Reli-
gione .
Ogni cosa vale il tutto , e perciò talvolta
si accorda neutralmente . Bocc. Essendo fred-
di grandissimi, ed ogni cosa piena di neve , e
di ghiaccio = Domandò l’ Oste , là dove esso
potesse dormire ; al quale l’ Oste rispose : in ve-
rità io non so: tu vedi, che ogni cosa è pieno.
E4 Ognu-
/ BEGIN PAGE 72 /
Ognuno vale omnis quisque . Bocc. Con gran-
dissima ammirazione d’ ognuno , in assai brie-
ve spazio di tempo , non solamente le prime
lettere apparò , ma valorosissimo tra’ filosofanti
divenne. Dante . Ognuna in giù tenea volta
la faccia . In vece d’ ognuno si dice talora ogni
uomo . Bocc. n. 7. Mise ogni uomo a tavola.
Ognora è avverbio, e vale semper. Bocc.
Nicostrato più ognora si maravigliava .
TUTTO , se è posto sustantivamente, va-
le ogni cosa, totum, omnia. Boccacc. Secondo
l’ ammaestramento datole da Antigono rispose ,
e contò tutto . Se si riferisce a quantità con-
tinua , è nome addiettivo , e vale intero per
ciascuna parte, totus, integer. Bocc. Loro tut-
to rotto, e tutto pesto il traßero delle mani =
Tutta livida, e rotta nel viso. Se poi si rife-
risce a quantità discreta , è pronome, e va-
le ogni, ognuno, omnis, e si declina per amen-
due i numeri col segnacaso, e fa nel plura-
le tutti , tutte. Bocc. Tutti sopra la verde er-
ba si puosero in cerchio a sedere = E nel La-
bir: Tutti i pensieri delle femmine , tutto lo
studio , tutte l’ opere a niuna altra cosa tira-
no , se non a rubare , a signoreggiare , e ad
ingannare gli uomini .
Si noti, che ’l pronome tutto , nel detto
senso, si adopera per lo più nel plurale . Si
può però adoperare nel singulare , co’ nomi
collettivi . Fiorett. S. Franc. Fece chiamare
Frate
/ BEGIN PAGE 73 /
Frate Ginepro, e, presente tutto il convento,
lo riprese. Bocc. A lui la cura, e la solleci-
tudine di tutta la nostra famiglia commetto . E
ancora co’ nomi d’ altra sorta , accennando
quantità virtuale . Bocc. g. 4. n. 10. Nel qua-
le ella pose tutta la sua speranza , tutto il suo
animo , e tutto il ben suo .
Colle voci dinotanti numero vi si pone
le più volte tra queste, e tutto la particella
e. Boccacc. Che andate voi cercando a quest’
ora tutti e tre? Esp. Salm. Queste antifone so-
no tutte e sette del secondo tuono.
Tutto quanto vale prorsus omnis . Bocc. Tut-
ti quanti perirono .
NIUNO, NESSUNO , E NISSUNO ne-
gativi generali, che si adoperano solamente
nel singulare, col femminino niuna &c. , de-
clinandoli ancora col segnacaso. Vagliono il
nemo de’ Latini. Si adoperano in forza di su-
stantivi, e di addiettivi, Bocc. Il luogo è as-
sai lontano di qui, e niuno mi vi conosce. E
Fiamm. Niuna ebbe mai gli Dij sì favorevo-
li, che nel futuro gli poteße obbligare = Niun
campo fu mai sì ben cultivato, che in esso o or-
tica , o triboli , o alcun pruno non si trovaße
mescolato fra l’ erbe migliori = Niuna gloria è
ad un’ aquila aver vinta una colomba. Passav.
Disse , che volea dare guadagno piuttosto a
lui, che a niuno altro.
Se niuno &c. si pongono con altra nega-
zione,
/ BEGIN PAGE 74 /
zione, o a modo di domanda , o di dubbio,
affermano , e vagliono alcuno . Bocc. Egli non
ve n’è niuno sì cattivo, che non vi paresse
uno ’mperadore. Nov. ant. 54. Non è neuna
cosa sì bella, ch’ ella non rincresca altrui quan-
do che sia. Bocc. g. 4. n. 6. Se la tua anima
ora le mie lagrime vede, o niun conoscimen-
to , o sentimento , dopo la partita di quella ,
rimane a’ corpi, ricevi benignamente l’ ultimo
dono. Nov. ant. 21. Lo ’mperadore disse : co-
me può essere? trovossi in Melano niuno , che
contradiasse alla podestade?
VERUNO per se è lo stesso , che niuno ;
ma colla negativa, e colla particella sen-
za, siasi solo, o col sustantivo, vale alcu-
no. Passav. I peccati veniali in veruno modo si
perdonano senza i mortali. Bocc. Anzi non fa
egli caldo veruno = Nè so quando trovar me
ne poßa veruno = Fareste danno a noi, senza
fare a voi pro veruno.
NIENTE , NULLA particelle negative ge-
nerali fanno, in certo modo, figura di pro-
nomi , in quanto ammettono l’ articolo, il se-
gnacaso , e le preposizioni . Si usano con al-
tra negativa, e senza ; e quando l’ hanno si
sogliono posporre al Verbo , e anteporre
quando non l’hanno . Bocc. Siccome quella,
che dal dolore era vinta , e che niente la notte
passata aveva dormito, s’ addormentò. Cavalc.
Specch. cr. Se l’uomo magnanimo desse ogni co-
sa
/ BEGIN PAGE 75 /
sa per amore , non gli parrebbe avere dato
niente. Bocc. De’ quali (frati) il numero è
quasi venuto al niente = Senza che la don-
na di niente s’ accorgesse = Le disse altre cose
aßai , le quali tornarono in niente E nella
Fiamm. Chi in alcuna cosa può sperare , di nul-
la si disperi = Altramente mai non ne farò
nulla = Riducere a nulla la Cristiana Reli-
gione.
Quando si usano per via di domandare, di
ricercare, o di dubitare, o pure colla parti-
cella senza, hanno senso affermativo . Bocc.
Gli si fece incontro, e, sulutatolo, il doman-
dò, s’ egli si sentisse niente. ( cioè alcun ma-
le ) = Potrebb’ egli essere, ch’ io avessi nulla?
( cioè alcun male ) = Colla mano subitamen-
te corsi a cercarmi il lato, se niente v’ avessi.
Lib. Son. E sono al tuo piacer , se tu vuoi
nulla. Vit. Ss. Pad. Cercando d’ intorno, se
niente d’ acqua trovassero. Bocc. Senza del
suo cruccio niente mostrare alla giovane, pre-
stamente seco molte cose rivolse = Calandrino,
senza dir nulla, volse i passi verso la casa
della paglia.
Pronomi, che dinotano distribuzione.
DI questi alcuni hanno qualche diffinizio-
ne di quantità, come uno, e ciascuno,
altri significano indefinitamente, e, per dir
così,
/ BEGIN PAGE 76 /
così , vagamente, come alcuno, qualcuno,
tale , e simili.
UNO, UNA, come pronomi dinotanti prin-
cipio di quantità discreta , sono per se stessi
senza plurale, e si declinano nel singulare
col segnacaso. Talvolta si adoperano come
sustantivi, talvolta come addiettivi. Bocc. g.
I. in Proem. Novellando, il che può porgere,
dicendo uno, a tutta la compagnia, che ascol-
ta , diletto = Avevasi un’ oca a danajo, e
un papero giunta = Aveva grandissima ver-
gogna, quando uno de’ suoi strumenti fosse al-
tro che falso trovato = Giosefo, trovato un
baston tondo d’un querciuolo giovane , se n’ an-
dò in camera . E nell’ Amet. Ma perchè ci fa-
tichiamo noi di volergliti ad uno ad uno nar-
rare. Petrar. Ad una ad una annoverar le
stelle. Bocc. Dove voi vogliate le vostre ricchez-
ze recare in uno, e me far terzo posseditore
con voi insieme di quelle. Gio: Vill. In prima
era con borghi, e villate, e fortezze sparse,
ma i detti le recaro in una a modo di Città.
Bocc. Ma, recandoti le molte parole in una ,
io son del tutto disposto ad andarvi.
In uno, in una avverbialmente vagliono
unà, simul. Gio. Vill. Richiese cautamente l’ al-
tro collegio, che quando lor piacesse, si congre-
gassero in uno . Matt. Vill. Gli mosse a congiu-
ra, e in una a cercar de’ modi.
Uno, correlativo ad altro , sì in singolare,
come
/ BEGIN PAGE 77 /
come in plurale, riferendo due cose mento-
vate , vale primo de’mentovati, o pure, in-
sieme con altro , vale amendue. In tali casi
uno ammette l’ articolo, e il plurale. Bocc.
Fiamm. Siccome fecero i Saguntini, e gli Abi-
dei, gli uni tementi Annibale Cartaginese, e
gli altri Filippo Macedonico = Sperava l’ une
cresciute , e l’ altre dover trovare scemate =
Tanto l’ età l’ uno, e l’altro da quello, ch’
esser solevano, gli aveva trasformati. Petrar.
Ov’ è ’l bel ciglio, e l’ una, e l’ altra stella,
Che al corso del mio viver lume dienno?
CIASCUNO, CIASCUNA pronome distri-
butivo , che ancora dicesi ciascheduno, vale
unusquisque, si adopera addiettivo, e sustan-
tivo, si declina col segnacaso, e non ha
plurale, benchè gliel dessero alcuni antichi.
Passav. pag. 89. E in ciascuno caso il laico
è tenuto di celare i peccati, ch’ egli udì in
confessione, come dee fare il prete. Bocc. Con
gran piacere di ciascuna delle parti = Co-
minciarono a dire ciascuno, da lui essergli
stata tagliata la borsa. Petrar. Quanto ciascu-
na è men bella di lei, Tanto cresce il desio,
che m’ innamora .
Quando nella distribuzione si vuol signifi-
care il contingente, o sia la rata , e la por-
zione di checchessia, che tocca a ciascuno,
si aggiugne al pronome ciascuno la particella
per, e in vece di ciascuno si può dire anche
uno,
/ BEGIN PAGE 78 /
uno , o uomo Bocc. g. 10. n. 9. Fattesi venir
per ciascuno due paja di robe. E lett. Pin.
Ross. Niuno altro guernimento per soddisfaci-
mento della natura portavano, che un poco di
farina per uno, con alquanto lardo. E g. 6.
n. 2. Che per un fiasco andasse del vin di
Cisti, e di quello un mezzo bicchiere per uo-
mo desse alle prime mense.
QUALUNQUE , QUALSISIA , QUALSI-
VOGLIA , quando non esprimono la forza
del relativo, vagliono ciascuno . Bocc. Per
iscusato si dovea avere il Duca, e qualunque
altro, che per avere una così bella cosa fa-
cesse tradimento. Firenz. disc. Uomini valenti,
e virtuosi, e in qualsivoglia esercizio eccel-
lenti.
QUALCHE, e ALCUNO pronomi indefi-
niti vagliono aliquis, aliqua, e si declinano
per amendue i numeri col segnacaso; il primo
però colla stessa invariata terminazione serve
ad amendue i generi, e numeri, e il secondo si
declina nel plurale alcuni, e alcune. Il primo
è sempre addiettivo, il secondo si adopera
anche in forza di sustantivo. Bocc. Se io fossi
pur vestito, qualche modo ci avrebbe = Egli
trovi qualche cagione di partirsi da me. Petrar.
Deh or foss’ io col vago della luna Addormen-
tato in qualche verdi boschi. Bocc. g. 10. n. 4.
Quando alcuno vuole sommamente onorare il
suo amico, egli lo ’nvita a casa sua = Non
con-
/ BEGIN PAGE 79 /
consiglierei io alcuno , che dietro alle pedate
di colei, di cui dire intendo, s’ arrischiasse
d’ andare = Nocque ad alcuna già l’ esser sì
bella : Questa più d’ altra è bella, e più pu-
dica. Bocc. g. 4. n 8. Alcuni sono, i quali
più, che l’ altre genti, si credon sapere, e san-
no meno = E g. 2. nel Proem. Dopo alcun bal-
lo, s’andarano a riposare = Nè vi poteva d’ al-
cuna parte il sole.
In vece d’ alcuno si dice talvolta uomo . Bocc.
Quello, con picciola fatica , in picciolo spazio,
con tutta la ciurma , senza perderne uomo,
ebbero a man salva.
QUALCUNO , QUALCHEDUNO si re-
golano come alcuno. Passav. pag. 194. Santo
Antonio una volta orando , vide tutto ’l mondo
pieno di lacciuoli tesi, e lagrimando disse : or
chi potrà scampare di tanti laccivoli, che non
sia preso da qualcuno ! Petrar. Cogliendo omai
qualcun di questi rami = S’eßer non può, qual-
cuna d’ este notti Chiuda omai queste due fonti
di pianto .
TALE si prende alcuna volta per qualcu-
no , alcuno, in amendue i generi. Bocc. nell’
Introd. E tali furono , che per difetto di quelle
( bare ) sopra alcuna tavola ne ponieno. E g. 4.
in fin. Forse più dichiarato l’ avrebbe l’aspetto
di tal donna, che nella danza era, se le tene-
bre della sopravvenuta notte il roßore, nel viso
di lei venuto , non aveßer nascoso. Gell. Sport.
Sta-
/ BEGIN PAGE 80 /
Stamane mi ha fatto motto tale, e tale mi ha
riso in bocca, e inchinatomi, che un mese fa fa-
ceva vista di non mi vedere .
QUALE talvolta vale chi distributivo Bocc:
E le lor donne , e i figliuoli piccioletti , qual se
n’ andò in contado, e qual qua , e qual là as-
sai poveramente in arnese . Anche quale si
usa per chiunque . Bocc. Non sono le mie bel-
lezze da lasciar amare nè da tale , nè da
quale.
ALQUANTO, variato per generi , e nu-
meri col segnacaso, vale qualcuno, alcuno &c., e
nel plurale si adopera anche a modo di sustan-
tivo . Bocc. g. 4. n. 8. Dopo alquanto spazio co-
minciò a dire . Gio. Vill. Ritornò d’ Alamagna
con alquanta gente , che ebbe dal Re Ridolfo.
Petrar. L’ industria d’ alquanti uomini s’ av-
volse Per diversi paesi . Bocc. E quinci tacen-
do , alquante lagrime mandate per gli occhi
fuori , comincio ad attendere = Alquanti, che
risentiti erano all’ arme corsi, n’uccisero. Pe-
trar. Ma d’ alquante dirò, che ’n su la cima Son
di vera onestate.
Alquanto sustantivamente, e neutralmente,
col genitivo , vale l’ aliquid de’ Latini . Bocc.
Con alquanto di buon vino , e di confetto il ri-
Confortò .
Pro-
/ BEGIN PAGE 81 /
Pronomi di qualità .
TALE pronome dinotante qualità, che in
plurale fa tali, è di genere comune, e
si declina col segnacaso, e si adopera da su-
stantivo , e da addiettivo Ha le più volte la
corrispondenza di quale, cotale, o che. Bocc.
Tale , quale tu l’hai , cotale la dì. E n. 2.
Pensa, che tali sono là i Prelati, quali tu gli
hai qui potuti vedere. E n. 4. Potrebbe esser
tal femmina , o figliuola di tale uomo , ch’ egli
non le vorrebbe aver fatta quella vergogna.
Si usa anche senz’ alcuna corrispondenza.
Bocc. nell’ Introd. La cosa dell’ uomo infermo
stato , o morto di tale infermità , tocca da un’
altro animale , quello infra brevissimo spazio
occidesse = Portando nelle mani, chi fiori, chi
erbe odorifere, e chi diverse maniere di spe-
zierie , quelle al naso ponendosi spesso , esti-
mando essere ottima cosa, il cerebro con cota-
li odori confortare .
Si adopera ancora neutralmente a modo di
sustantivo , e vi si sottintende stato , termi-
ne &c., e dinota miseria. Bocc. g. 3. n. 1. So-
no io, per quello , che infino a qui ho fatto ,
a tale venuto, che io non posso fare nè poco,
nè molto . Petrar. I. p. canz. 31. Qual più di-
versa , e nova Cosa fu mai in qualche stra-
nio clima ; Quella , se ben si stima , Più mi
rassembra : A tal son giunto , Amore.
F Nell’
/ BEGIN PAGE 82 /
Nell’ uso si dà l’ articolo a tale , dicendo
il tale , la tale , un tale , e vale colui, colei,
un cert’ Uomo .
COTALE , lo stesso che tale, e che si ado-
pera colle medesime regole , e da sustantivo ,
e da addiettivo , come si vede da’ due esem-
pj del Boccaccio ivi addotti . Si usa col pro-
nome dimostrativo, e coll’ articolo. Bocc. Pa-
reva seco quella cotale infermità nel toccator
trasportare = E questo cotale del luogo , e del
modo , nel quale a vivere abbiamo , ordini,
e disponga = I cotali son morti, e gli altret-
tali sono per morire .
Si usa talvolta cotale per certo , tale , cor-
rispondente al quidam de’ Iatini . Bocc. La
giovane , non da ordinato disidero, ma da uno
cotal fanciullesco appetito mossa , ad andar
verso il diserto di Tebaida nascosamente tut-
ta sola si mise. Gio. Vill. Per una cotal mez-
zanità, e per contentare il popolo , elessono due
Cavalieri Frati Godenti per Podestà di Fi-
renze.
ALTRETTALE vale talora lo stesso , che
tale , e si regola allo stesso modo , ma si usa
solo nel plurale . Bocc. I cotali son morti, e
gli altrettali son per morire. Lib. Sagr. Dove-
te guardare verso li vostri sergenti, che voi
siate altrettali verso loro , chente voi volete
che sieno verso voi.
ALTRETTANTO pronome correlativo ,
che
/ BEGIN PAGE 83 /
che dinota uguaglianza di numero , o di mi-
sura, e corrisponde all’ alterum tantum , tan-
tumdem , totidem &c. de’ Latini. Nel femmi-
nino fa altrettanta , e nel plurale altrettan-
ti , e altrettante. Si declina col segnacaso ,
e si usa addiettivo, e sustantivo. Bocc. La
mattina appresso si vuole andare alla Chiesa,
e quivi udire almeno tre messe , e dir cin-
quanta pater nostri , e altrettante avemarie .
Gio. Vill. Mandaronvi i Fiorentini cento ca-
valieri , e cinquecento pedoni , tutti soprasse-
gnati a gigli, e di Bologna altrettanti . Pe-
trar. Così avess’ io del bel velo altrettanto =
Una donna più bella assai, che ’l Sole, E più
lucente, e d’ altrettanta etade.
Pronomi , che dinotano diversità .
TRe sono questi pronomi , altri, che si-
gnifica un’ altro uomo , una diversa per-
sona , e corrisponde al Latino alter : altrui,
ch’ è lo stesso , che altri ne’ casi obbliqui : e
altro , che addiettivamente si dice di perso-
na , e sustantivamente vale altra cosa .
ALTRI si declina così . Singulare . Altri,
di altro, ad altro , altro , da altro. Plurale.
Altri , d’ altri, ad altri, altri , da altri. Am-
mette l’ articolo, fuorchè nel nominativo sin-
gulare. Bocc. Nè voi, nè altri con ragione mi
potrà più dire, ch’ io non l’ abbia veduta = Il
Duca, e Costantino, e gli altri tutti.
F 2 Tro-
/ BEGIN PAGE 84 /
Trovansi alcuni esempj, addotti dal Voca-
bolario, ne’ quali altri pare usato ne’ casi ob-
bliqui , ma per tutto ciò non è da lasciarsi
una regola confermata , e dall’ autorità , e
dall’ uso. Adduce altresì il Cinonio uno esem-
pio del Boccaccio sul fine della novella 8. ,
in cui altro è usato in nominativo , parlan-
dosi di persona , e così trovasi nel Decame-
rone del 27., ma non faccendone motto il
Vocabolario, ci atterremo, senza pensar più
oltre, alla regola.
Altri si adopera alcuna volta per io. Bocc.
Voi potreste dir vero , ma tuttavia non sap-
piendo chi questo si sia, altri non si rivolge-
rebbe così di leggiero.
Talvolta si adopera in significato di uno,
qualcuno, e simili. Bocc. Egli si vuole innac-
quare , quando altri il bee = Tanto sa altri,
quanto altri . E queste due usurpazioni d’altri
sono veramente figure , ma l’ uso famigliare
fa , che si prendano per proprietà di lin-
guaggio .
ALTRUI manca del nominativo, e si de-
clina a questo modo : Di altrui , ad altrui,
altrui , da altrui, e queste voci servono ad
amendue i numeri, e giovano mirabilmente
alla brevità del parlare. Questo pronome può
lasciare il segnacaso nel genitivo, e nel da-
tivo, ma non già nell’ ablativo. Si trova non
di rado coll’ articolo, ma non è suo. Bocc.
Che
/ BEGIN PAGE 85 /
Che io da altrui , che da lei udito non sia =
Ciò per l’altrui case faccendo, solamente che
cose vi sentissero , che a loro venißero a gra-
do = Io estimo , ch’ egli sia gran senno a pi-
gliarsi del bene , quando Domeneddio ne man-
da altrui.
Ha talora forza di sustantivo , e vale ciò,
che non è proprio, ma d’ altri . Bocc. Per
potere quello da casa risparmiare , si dispose
di gittarsi alla strada , e di voler logorar del-
lo altrui .
Si leggono esempj del Boccaccio , e del
Passavanti , ne’ quali altrui sembra usata in
caso retto , ma i testi a penna, e le buone
edizioni , anche da me riscontrate , hanno
altri.
ALTRO addiettivo fa in femminino altra,
e nel plurale altri, e altre, e si declina in
amendue i numeri col segnacaso , coll’arti-
colo , e con altre preposizioni. Bocc. Quasi
altro bel giovane , che egli , non si trovasse
allora in Napoli = La cosa tocca da un’ altro
animale fuori della spezie dell’ uomo = Qui so-
no giardini, qui sono pratelli , qui altri luo-
ghi dilettevoli assai. Petrar. Una dolcezza inu-
sitata , e nuova, La quale ogni altra salma Di
nojosi pensier disgombra allora. Bocc.Tindaro al
servigio di Filostrato, e degli altri due atten-
da nelle camere loro.
ALTRO sustantivo è voce neutra, che ha
F 3 il
/ BEGIN PAGE 86 /
il solo singulare, nel quale si declina col se-
gnacaso, o coll’ articolo, e vale altra cosa,
aliud. Bocc. Niuna cosa altro, che nuvoli, e
mare vedea = Temendo non fosse altro, così al
bujo levatasi, com’ era, se n’andò là = Ric-
co, e savio, e avveduto per altro, ma ava-
rissimo = La quale, peravventura non fia al-
tro che utile , avere udita . E nel Labir. Va
via , tu non se’ da altro , che da lavare sco-
delle = Non seppe sì parlare oscuro, che le
avvedute donne non ne ridessono, sembiante
faccendo di rider d’altro. Petrar. Sopra gli
omeri avea sol due grand’ ali Di color mille,
e tutto l’altro ignudo = Purchè gli occhi non
miri, L’ altro puossi veder securamente
Altro talvolta significa accrescimento di
pregio, e fa intendere più di quel , che di-
ce . Bocc. g. 8. n. 9. Altro avresti detto , se
tu m’ avessi veduto a Bologna, dove non era
niuno , nè grande , nè piccolo , nè Dottore, nè
scolare , che non mi volesse il meglio del Mon-
do. Petrar. E d’ altro ornata, che di perle,
e d’ostro.
CAP. XXIV.
Del Verbo.
IL Verbo può considerarsi in due maniere,
e quanto alla sua natura , e quanto alla
sua significazione.
Quan-
/ BEGIN PAGE 87 /
Quanto alla natura, il Verbo si divide in
personale , e in impersonale. Verbo perso-
nale è quello , che si varia in tre distinte
persone , come io amo , tu ami , colui ama.
Impersonale è quello , che non ha varietà di
persone , come sono per esempio tonare , ba-
lenare, nevicare , ne’ quali si dice in voce di
terza persona : e’ tuona , nevica , balena , e
non già io tuono , nevico, baleno , tu tuoni,
nevichi , baleni. Ci sono anche i Verbi mez-
zi impersonali , i quali si usano e personal-
mente, e impersonalmente, come appartenere,
convenire , disdire , e simili . Anzi molti altri
Verbi , di lor natura personali, coll’aggiunta
della particella si, impersonalmente si adope-
rano, come : si dice , si crede, si corre.
Il Verbo personale è di tre sorte , sustan-
tivo, transitivo , e assoluto . Il sustantivo è
quello , che accenna con tempo la sustanza
della cosa , cioè quello, che la cosa ha in
se stessa , non quello , ch’ella fa , o patisce ;
e tale è il solo Verbo essere . Il transitivo è
quello , che riceve accusativo dopo di se , e
significa azione , che passa in un termine di-
verso dal suo principio , come : il maestro
batte i discepoli; la Madre ama i figliuoli . Ci
sono ancora de’ transitivi imperfetti , che non
ricevono accusativo dopo di se , che signifi-
chi vero termine di azione , come : io entro
in casa ; tu duri fatica , colui dorme un sonno.
F 4 L’ asso-
/ BEGIN PAGE 88 /
L’assoluto, o sia intransitivo, è quello, che
non ha caso dopo di se, e significa azione,
che non si parte dal suo soggetto , come cor-
rere, morire &c.
Quanto alla significazione , il Verbo per-
sonale è di tre sorte , attivo, passivo , e neu-
tro. Il Verbo attivo è quello, che accenna
azione perfettamente transitiva o reale, o
intenzionale, e ha dopo di se accusativo pa-
ziente , e può tramutarsi , collo scambiamen-
to de’ casi di quel nome, che opera in esso,
in passivo , come io amo Pietro , potendosi di-
re : Pietro è amato da me . Verbo passivo è
quello, che nella sua persona accenna pas-
sione, come : gli scolari sono battuti dal mae-
stro. Verbo neutro è quello , che non ha si-
gnificazione attiva perfetta , nè può voltarsi
in passivo , e tali sono i transitivi imperfet-
ti sopra accennati , ne’ quali , pogniamo fi-
gura, non si può dire : la casa è entrata da
me, la fatica è durata da te &c. Tra’ ver-
bi neutri , quelli, che trasferiscono la passio-
ne nella persona operante, si chiamano neu-
tri passivi , come pentirsi , attristarsi &c.
CAP.
/ BEGIN PAGE 89 /
CAP. XXV.
Delle variazioni del Verbo .
IL Verbo si varia per modi , tempi, nu-
meri , e persone ; e questa variazione si
chiama conjugazione.
I modi del Verbo son cinque , indicativo,
imperativo , ottativo , congiuntivo, e infi-
nito.
I tempi, generalmente parlando, sono tre,
presente , preterito, e futuro ; ma questi poi,
secondo la natura di ciascun modo, si sud-
dividono in varie differenze , o sieno affe-
zioni.
L’ indicativo ha otto tempi , cioè il pre-
sente , come io amo ; il preterito imperfet-
to , che accenna azione non perfezionata ,
come io amava ; preterito determinato , che
dimostra un fatto di poco tempo ; come io ho
amato; il preterito indeterminato , che accen-
na un fatto di qualche tempo , come io amai;
il trapassato imperfetto , che indica quello ,
che già da noi si faceva , come io aveva
amato ; il trapassato perfetto dinotante ciò,
che da noi già si fece, come io ebbi amato ;
il futuro imperfetto quel , che altri promet-
te di fare, come io amerò ; e il futuro per-
fetto ciò , che ad un tal tempo sarà segui-
to, come io avrò amato.
L’im-
/ BEGIN PAGE 90 /
L’ imperativo ha due tempi ; il presente,
che comanda, esorta, o priega , come va
tu; e futuro, che comanda, esorta, o prie-
ga, che una cosa si faccia , ma non di pre-
sente, come andrai tu.
L’ ottativo ha sei tempi ; il presente per-
fetto , che dimostra desiderio efficace di fa-
re, come oh se io amassi! il presente imper-
fetto, che accenna desiderio di fare una co-
sa, ma non già al presente, come io ame-
rei ; il preterito determinato , che dimostra
desiderio di aver fatto a tal tempo , come
Dio voglia ch’ io abbia amato ; il preterito in-
determinato , che indica desiderio di aver fat-
to, se si fosse potuto , come io avrei ama-
to , ma non potei ; il trapassato, il quale di-
mostra , che altri vorrebbe aver già fatto ,
come volesse Iddio , che io avessi amato ; e fi-
nalmente il futuro , che mostra desiderio di
mettersi a fare , come Dio voglia ch’ io ami .
Il congiuntivo prende in prestanza tutti i
suoi tempi dagli altri modi , appoggiato sem-
pre ad alcuna particella di congiunzione,
come conciossiachè, quantunque , benchè, e si-
mili. Ha cinque tempi, presente, come ben-
chè io ami ; preterito imperfetto , come ben-
ch’ io amassi; preterito perfetto, come ben-
chè io abbia amato ; trapassato, come benchè
io avessi amato ; e il futuro, come quando io
avrò amato.
L’ in-
/ BEGIN PAGE 91 /
L’ infinito ha tre tempi : il presente , che
accenna azione in confuso, come amare : il
preterito , che mostra l’ opera già fatta, co-
me avere amato : e il futuro, che dimostra
disposizione a fare un’opera in avvenire , co-
me avere ad amare , o essere per amare .
I numeri del Verbo sono due , singulare ,
come io amo , e plurale , come noi amiamo.
Le persone in ciascuno de’ due numeri sono
tre ; la prima, come io amo, noi amiamo : la
seconda , come tu ami, voi amate: e la ter-
za, come colui ama, coloro amano.
CAP. XXVI.
Alcune generali osservazioni sopra le
conjugazioni de’ Verbi.
DI due sorte sono i Verbi , quanto alla
conjugazione , perchè altri sono rego-
lari, altri anomali. I Verbi regolari sono
quelli, i quali si conjugano con regola a
molti Verbi comune ; e gli anomali quelli
sono, che escono dalla regola comune degli
altri Verbi, ed hanno particolare conjuga-
zione.
Quattro sono le conjugazioni de’ Verbi,
le quali si conoscono , e prendono regola dal
presente dell’ infinito . La prima conjugazio-
ne esce in are, come amare ; la seconda in
ere
/ BEGIN PAGE 92 /
ere colla penultima lunga, come temere; la
terza in ere colla penultima breve, come leg-
gere ; e la quarta in ire, come sentire .
Intorno alla formazione delle voci di cia-
scun Verbo nelle suddette conjugazioni , i
due nostri dottissimi Gramatici, il Bembo,
e ’l Castelvetro assegnano molte regole di
ciò fare, collo scambiamento , o accresci-
mento di alcuna lettera ; e sono regole ve-
ramente sottili, e degne di que’ valenti mae-
stri. Ma io , che mi sono proposto di vo-
lere instruire i giovani con metodo facile,
e sciolto, m’ attengo al savio parere del Buom-
mattei, che stima tali cose poco necessarie
al nostro fine , o perchè senz’ esse altri può
ben conoscere le maniere de’ Verbi ; o per-
chè tali cose forse dall’uso , e dall’arbitrio
in qualche parte dipendono . E chi vorrà pro-
fondarsi di vantaggio in tali materie , potrà
soddisfarsi col leggere gli Autori suddetti , e
il Cinonio altresì nel suo Trattato de’ Verbi.
Noi adunque ci contenteremo di porre di-
stesamente le conjugazioni di tutti e quattro
i Verbi regolari sopraccennati, che servono
di norma a molti altri ; aggiugnendo a cia-
scuna conjugazione quelle osservazioni , che
giudicheremo opportune a far ben conoscere
e varie uscite, che hanno talora alcune vo-
ci de’ Verbi, e tuttociò, che alla natura de’
Verbi appartiene . Singolarmente noteremo,
quali
/ BEGIN PAGE 93 /
quali sieno le voci proprie della prosa , e
quali del verso , e insieme gli errori popo-
lareschi da fuggirli nella conjugazione de’
Verbi .
E perchè i Verbi anomali della Lingua
Toscana , da una parte , per conto del loro
infinito , si riducono alle quattro conjugazio-
ni ; e per l’ altra e’ non hanno tutte le loro
voci fuor di regola , ma solamente alcune ,
qual più , qual meno ; e nel rimanente cia-
scun Verbo anomalo siegue la sua conjuga-
zione ; perciò sotto ciascuna conjugazione
porremo anche i Verbi anomali ad ella spet-
tanti , cioè quelle voci solamente di essi,
ch’ escono dalla regola .
Ora tutte queste conjugazioni di Verbi,
che alla distesa da noi si porranno , sono trat-
te dal Buommattei , e comprendono quelle
voci solamente , che ricevute sono dal buo-
no uso vegliante de’ moderni Toscani, e pos-
sono usarsi da chi in oggi vuole, in prosa,
e in versi, parlare, e scriver toscano. Ben so,
che negli Autori del buon secolo vi sono
molte uscite delle voci de’ Verbi , le quali
erano allora in uso, o furono da’ Poeti ado-
perate per necessità della rima, e che non
son ricevute dall’uso moderno. Ma il notar
tutte queste, per altro venerabili, antichità,
farebbe andare, come suol dirsi, nell’un vi’
uno , e non toccar mai della fine . Quelle
bensì
/ BEGIN PAGE 94 /
bensì noteremo , che possono anche in oggi
adoperarsi , o che arrecano qualche lume all u-
so di ben parlare, ch’ è il nostro intendi-
mento.
Prima però, che pogniamo le quattro con-
jugazioni, stimiamo ben fatto di porre la con-
jugazione del Verbo sustantivo essere, e del
transitivo avere. Questi due Verbi sono au-
siliarj degli altri Verbi , i quali non avendo
tutte le voci pure, e semplici, che si richieggo-
no a formare i loro tempi, ne’ preteriti, ne’
trapassati, e ne’ futuri, prendono in prestanza
delle voci da essere , e da avere , e declinan-
dole per persone, e per numeri, le accompa-
gnano col proprio participio, come vedremo.
Per contrario i due Verbi essere, ed avere, per
formare i loro tempi, non hanno bisogno de-
gli altri Verbi, ma da se soli suppliscono al
difetto delle pure voci espressive de’ tempi.
Egli è adunque d’ uopo, la prima cosa, di sa-
pere la conjugazione di questi due Verbi , che
s’ intramettono fra tutti gli altri ; e tanto più,
perchè la loro conjugazione è molto differen-
te da quella degli altri Verbi.
/ BEGIN PAGE 95 /
CAP. XXVII.
Conjugazione del Verbo eßere .
INDICATIVO .
Presente. Singulare. Io sono, tu sei, se’,
o se, colui è . Plural. Noi siamo, voi sie-
te , coloro sono.
Preterito imperfetto. Singul. Io era, tu eri,
colui era . Plur. Noi eravamo , voi eravate,
coloro erano .
Preterito determinato. Singul. Io sono , tu
sei, colui, o colei è stato, o stata. Plurale. Noi
siamo , voi siete , coloro sono stati , o state .
Preterito indeterminato. Singul. Io fui, tu
fosti , colui fu. Plur. Noi fummo , voi foste ,
coloro furono.
Trapassato imperfetto. Singul. Io era, tu eri,
colui, o colei era stato , o stata. Plur. Noi era-
vamo , voi eravate , coloro erano stati , o
state.
Trapassato perfetto. Singul. Fui , fosti, fu
stato, o stata. Plur. Fummo, foste, furono sta-
ti , o state .
Futuro imperfetto. Sing. Sarò, sarai, sarà,
o fia, o fie . Plur. Saremo , sarete, saranno,
o fieno .
Futuro perfetto. Sing. Sarò , sarai , sarà
stato, o stata . Plur. Saremo , sarete, saran-
no stati, o state.
IM-
/ BEGIN PAGE 96 /
IMPERATIVO.
Presente Sing. La prima persona manca . Sii
tu, o sia tu, sia colui. Plural. siamo noi , sia-
te voi , sieno coloro .
Futuro. Sing. La prima persona manca . Sa-
rai tu , sarà colui. Plur. Saremo noi, sarete
voi , saranno coloro.
OTTATIVO.
Presente perfetto. Sing. Dio volesse che io
fossi, tu fossi, colui fosse. Plur. Noi fossimo ,
voi foste, color fossero .
Presente imperfetto. Sing. Sarei , o saria ,
o fora, saresti , sarebbe, o saria, o fora.
Plur. Saremmo, sareste, sarebbero , o sarebbo-
no , o sariano, o forano.
Preterito determinato . Singul. Dio voglia
ch’io sia, tu sii, colui, o colei sia stato, o stata .
Plur. Che noi siamo , voi siate , coloro sieno sta-
Ti , o state .
Preterito indeterminato. Sing. Sarei , sare-
sti, sarebbe stato, o stata. Plur. Saremmo ,
sareste , sarebbero , o sarebbono stati , o state.
Trapassato . Sing. Dio volesse che io fossi,
tu fossi, colui, o colei fosse stato , o stata . Plur.
Che noi fossimo, voi foste, coloro fossero stati,
o state.
Futuro . Sing. Dio voglia ch’ io sia , tu sii ,
colui sia . Plur. Che noi siamo, voi siate, co-
loro sieno.
CON-
/ BEGIN PAGE 97 /
CONGIUNTIVO.
Presente. Sing. Benchè io sia , tu sii , colui
sia. Plur. Noi siamo , voi siate , coloro sieno.
Preterito imperfetto . Sing. Benchè io fossi,
tu fossi, colui fosse . Plur. Noi fossimo , voi fo-
ste , coloro fossero.
Preterito perfetto . Sing. Benchè io sia , tu
sii , colui sia stato &c. Plur. Noi siamo , voi
siate , coloro sieno stati &c.
Trapassato . Sing. Benchè io fossi , tu fossi,
colui fosse stato &c. Plur. Noi fossimo , voi fo-
ste , coloro fossero stati &c.
Futuro. Sing. Quand’ io sarò, tu sarai, co-
lui sarà stato &c. Plur. Noi saremo, voi sa-
rete, coloro saranno stati &c.
INFINITO.
Presente . Essere .
Preterito. Essere stato, o stata.
Futuro. Esser per essere ; o avere a essere.
Osservazioni sopra il Verbo Essere.
CIrca la seconda persona singulare del pre-
sente dell’ Indicativo di questo Verbo ,
il Buommattei stima doversi dire tu se senz’
apostrofo , e questa essere l’ intera voce di tal
tempo, e dice, se non avere letto mai tu
sei in Autore antico stimato. Ma il Manni
lez. 7. dice, che ne’ buoni testi de’ primi mae-
stri della nostra lingua, oltre al tu se senz’
G apo-
/ BEGIN PAGE 98 /
apostrofo, si trova ancora più volte l’ inte-
ro tu sei , e il se’ apostrofato , e adduce l’au-
torità del Menagio annot. al sonetto 13. del
Casa, nella quale vien citato il Padre Da-
niello Bartoli nel Torto, e Diritto annot. 79.
Dal che egli conchiude, che noi possiamo
assicurarci di usar con ragione e l’ uno , e
l’altro.
Semo per siamo si trova presso gli antichi ,
e in prosa , e in verso , ma non è oggi in
uso . Siàno, coll’ accento sulla seconda, per
siamo , è in Toscana voce del popolo , co-
me lo è altresì siate per siete.
Enno per sono ha molti esempj di antichi,
ma non è più in uso in Toscana , se non se
in alcuni luoghi tra i Contadini.
Nel preterito imperfetto si dice io era , e
così trovasi sempre usato dagli antichi , e
anche da’ moderni regolati scrittori. Volgar-
mente si dice io ero , e quest’ uso tornerebbe
forse bene per distinguer la prima dalla ter-
za persona , e si ammette nel parlar fami-
gliare , ma non già nello scrivere , e nel
parlare in pubblico, perchè di troppo peso
è l’ autorità in contrario.
Noi eramo per eravamo, voi eri per era-
vate si usano , dice il Buommattei , solo in
parlando , o scrivendo famigliarmente, e al-
la dimestica.
Fusti, e fuste per fosti, e foste sono mani-
festi
/ BEGIN PAGE 99 /
festi errori. E tale è fossimo per fummo , es-
sendo scambiamento di un tempo per l’ al-
tro , perchè fossimo è primo presente dell’Ot-
tativo.
Furo per furono si adopera il più da’ Poe-
ti : non ne mancano però esempj di prosa .
Nov. ant. I. Furo allo ’mperadore , e saluta-
ronlo.
Talora si dice fia, e fie per sarà , e fieno
per saranno. Bocc. Io ognora , che a grado ti
fia, te ne posso render molte per quella una.
Dante . E fieti manifesto Lo error de’ ciechi,
che si fanno duci . Bocc. n. 6. Se per ognuna
cento ve ne fieno rendute di là , voi n’ avre-
te tanta , che voi dentro tutti vi dovrete af-
fogare.
Sii si muta in sie , singolarmente negli af-
fissi . Bocc. g.8. n.7. Sieti assai l’ esserti potu-
to vendicare .
Saria alle volte si dice per sarei, e sareb-
be, e sariano, o sarieno per sarebbono. Bocc.
g. 2. n. 6. Se pur fosse, sommamente mi sa-
ria caro . E nell’ Introd. Non si saria estima-
to , tanti avervene dentro avuti. Petrar. Non
mi sarien credute Le mie fortune , ond’ io tut-
to m’ infoco. Bocc. g. 2. n. I. I tuoni non si
sarieno potuti udire .
I Poeti dicono fora per sarebbe . Dante . E
fallo fora non fare a suo senno. Dicesi anche
nel Vocabolario, essersi usato forano per sa-
rebbono. G 2 Il
/ BEGIN PAGE 100 /
Il participio del Verbo essere, secondo la
sua analogia , dovrebbe essere essente , essu-
to , o issuto , che talvolta si truovano nelle
più antiche Scritture ; ma allora poco in
uso , e oggi niente. Il Boccaccio usò su-
to, come nella n. I. Tu mi dì , che se’ suto
mercatante. Il participio adunque , col qua-
le il Verbo essere in oggi forma i suoi pas-
sati, è quello del Verbo stare, cioè stato, il
quale oggimai è fatto proprio del Verbo
essere .
CAP. XXVIII.
Conjugazione del Verbo avere.
INDICATIVO.
PResente . Sing. Ho, hai, ha. Plur. Abbia-
mo, avete, hanno .
Preterito imperfetto. Sing. Aveva, o avea,
Avevi, Aveva , o avea. Plur. Avevamo,
Avevate, Avevano, o aveano.
Preterito determinato. Sing. Ho , hai, ha
avuto. Plur. Abbiamo , avete , hanno avuto.
Preterito indeterminato . Sing. Ebbi , ave-
sti , ebbe. Plur. Avemmo, aveste , ebbero, o
ebbono .
Trapassato imperfetto. Sing. Aveva, ave-
vi, aveva avuto. Plur. Avevamo , avevate,
avevano avuto.
Tra-
/ BEGIN PAGE 101 /
Trapassato perfetto . Sing. Ebbi , avesti,
ebbe avuto. Plur. Avemmo, aveste, ebbero
avuto.
Futuro imperfetto . Sing. Avrò , avrai ,
avrà. Plur. Avremo, avrete, avranno.
Futuro perfetto. Sing. Avrò , avrai , avrà
avuto. Plur. Avremo, avrete, avranno avu-
to.
IMPERATIVO.
Presente. Sing. Abbi tu , abbia colui. Plur.
Abbiamo , abbiate, abbiano.
Futuro. Sing. Avrai tu , avrà colui. Plur.
Avremo , avrete , avranno .
OTTATIVO.
Presente perfetto. Sing. Dio volesse ch’ io
avessi , tu avessi, colui avesse. Plur. Avessi-
mo , aveste , avessero, o avessono.
Presente imperfetto . Sing. Avrei , avre-
sti, avrebbe. Plur. Avremmo, avreste, avreb-
bero, o avrebbono.
Preterito determinato. Sing. Dio voglia che
io abbia , tu abbi , colui abbia avuto . Plur.
Abbiamo, abbiate, abbiano avuto .
Preterito indeterminato. Sing. Avrei , avre-
sti, avrebbe avuto. Plur. Avremmo, avreste ,
avrebbero avuto.
Futuro. Sing. Voglia Iddio che io abbia, tu
abbi , colui abbia. Plur. Abbiamo , abbiate ,
abbiano.
G3 CON-
/ BEGIN PAGE 102 /
CONGIUNTIVO.
Presente. Sing. Che io abbia, tu abbi, co-
lui abbia . Plur. Abbiamo , abbiate, abbiano.
Preterito imperfetto. Sing. Se io avessi , tu
avessi, colui avesse. Plur. Avessimo, aveste ,
aveßero, o avessono.
Preterito perfetto . Sing. Benchè io abbia ,
tu abbi , colui abbia avuto. Plural. Abbiamo,
abbiate , abbiano avuto.
Trapassato . Sing. Se io avessi , tu avessi,
colui aveße avuto . Plur. Avessimo , aveste,
avessero avuto .
Futuro. Sing. Quando io avrò , tu avrai ,
colui avrà avuto . Plur. Avremo , avrete,
avranno avuto.
INFINITO.
Presente. Avere.
Preterito . Avere avuto.
Futuro . Avere ad avere, o eßere per
avere.
Osservazioni sopra ’l Verbo Avere.
AVea , aveano per aveva , avevano si di-
ce, non solamente in verso, ma anco-
ra frequentemente in prosa. Boccacc. Ad un
luogo molto bello, che il detto Gianni avea in
Camerata. E g. 4. n. 10. I quali, perciocchè
molto vegghiato aveano, dormivan forte .
Avemo per abbiamo è stato detto in ver-
so,
/ BEGIN PAGE 103 /
so, e in prosa. Petrar. Ma del misero stato,
ove noi semo, Condotte dalla vita altra sere-
na , Un sol conforto, e della morte, avemo.
Bocc. g. I. in fin. E, come oggi avem fatto,
così all’ ora debita torneremo a mangiare.
I Poeti dicono ave per ha, aggio per ho,
e aggiate per abbiate . Petrar. Non vedrian
la minor parte Della beltà, che m’ ave il cor
conquiso = V’ aggio profferto il cor , ma a voi
non piace Mirar sì basso colla mente altera =
Però, Signor mio caro , aggiate cura, Che si-
milmente non avvegna a voi.
Gli errori popolareschi , da schifarsi nel-
le voci del Verbo avere , sono i seguenti.
Abbiáno per abbiamo ; io avevo per io ave-
va : avessimo , o ebbimo per avemmo : averò,
averai , averà, averemo , averete , averan-
no, averei &c. per avrò &c. avrei &c. E fi-
nalmente che io abbi, che coloro abbino per
che io abbia, che coloro abbiano.
Il participio del Verbo avere, cioè avu-
to , serve ad amendue i generi, rispettiva-
mente alla persona, che regge il Verbo ;
onde tanto un’uomo, quanto una donna di-
rà : io ho avuto, quando il caso, ch’ è dopo,
altro non richiegga. Il che non avviene del
participio di essere , perchè un’uomo dice:
io sono stato , e una donna : io sono stata.
Quindi è, che i Verbi, i quali si conjuga-
no col Verbo essere, accordano il participio
G 4 colla
/ BEGIN PAGE 104 /
colla persona del Verbo, e si dice: il padre
è amato da’ figliuoli ; i figliuoli sono amati
dal Padre : la donna è partita ; le speranze
sono cresciute . Laddove ne’ Verbi, che si con-
jugano col Verbo avere , il participio è in-
declinabile in riguardo alle persone del Ver-
bo, e si dice: L’uomo ha, gli uomini hanno
amato, temuto, sentito &c. La donna ha , le
donne hanno amato, temuto, sentito &c.
CAP. XXIX.
Uso de’ Verbi essere, e avere nella conjugazio-
ne degli altri Verbi, e quando avere
si ponga per essere.
NEl formare i preteriti de’ Verbi nasce
talvolta dubbio , se debba adoperarsi il
Verbo eßere , o il Verbo avere . Il Buom-
mattei tratt. 12. cap. 19., e il Manni Lez. 7.
stabiliscono la seguente regola.
I Verbi assoluti si servono del Verbo eße-
re, e i transitivi del Verbo avere. Ecco esem-
pj de’ Verbi assoluti . Bocc. Essi fanno ritrat-
to da quello , onde nati sono = In luogo di
quello , che morto era , il sustituì = Non ci son
vivuta in vano io, no = Io son venuta a ri-
storarti de’ danni, i quali tu hai già avuti
per me. Ecco esempj de’ transitivi . Bocc. Io
ho amato, e amo Guiscardo = Queste novelle
leg-
/ BEGIN PAGE 105 /
leggendo , hanno detto , che voi mi piacete
troppo = Sentendoti quel medesimo aver fatto,
ch’ ella fatto avea.
Si truovano però alcuni esempj, per altro
pochi, ne’ quali si vede , questa regola non
essere stata sempre dagli antichi osservata.
Correre si truova con essere, e con avere .
Bocc. g. 7. n. 8. Sentendo, Arriguccio esser
corso dietro a Ruberto. E di sotto : Avendo
corso dietro all’ amante tuo. Dormire si truo-
va assoluto col Verbo avere Boccacc. Siccome
quella, che dal dolore era vinta , e che nien-
te la notte passata aveva dormito, si addor-
mentò. E quando è accompagnato colla par-
ticella si, vuole il Verbo essere. Bocc. g. 2.
n. 3. Alessandro levatosi , senza sapere alcu-
no, ove la notte dormito si fosse, rientrò in
cammino. Starnutire assoluto con avere. Bocc.
Quegli, che starnutito avea.
Quanto all’ altro punto proposto, di quan-
do cioè avere si ponga per essere, non truo-
vo presso a’ Gramatici regola alcuna ben fer-
ma. Dice contuttociò il Bembo, che una tal
maniera la presero gli antichi Toscani dalla
lingua Provenzale: e in fatti i Franzesi me-
desimi usano molto avere per essere.
E io osservo appunto, che i Toscani, se-
condo la maniera Franzese, usano avere per
essere solamente nelle terze persone, ponen-
do ancora il singulare di avere per, lo plu-
rale
/ BEGIN PAGE 106 /
rale di essere, come da’ seguenti esempj si
farà chiaro.
Ha per è. Bocc. g. 3. n. 3. Qui non ha al-
tro da dire , se non che questo è stato troppo
grande ardire. E g. 3. n. 4. Ad una nostra,
non ha ancor lungo tempo, intervenne.
Ha per sono Bocc. g. 8. n. 3. Quante miglia
ci ha? Accene più di millanta. E g. 8. n.9.
Avvi letti , che vi parrebber più belli , che
quello del Doge di Vinegia .
Aveva per erano . Bocc. g.9. n.3. Con quanti
sensali aveva in Firenze teneva mercato = Al
mostrar del guanto rispose, che quivi non avea
falconi al presente, perchè guanto v’ avesse
luogo.
Ebbe per furono. Bocc. Ebbevi di quegli ,
che intender vollono alla Melanese.
Talvolta si trova usato avere in plurale
per essere in plurale. Bocc. g. 2. n. 10. Una
delle più belle, e delle più vaghe giovani di
quella Città ; comecchè poche ve n’ abbiano,
che lucertole non pajano.
Ancora il plurale d’ avere si truova talora
usato per lo singulare di essere. Liv. M. Tut-
ti furo battuti colle verghe, nel mezzo della
piazza, ed ebbono tagliata la testa . Cioè
fu loro ; maniera Franzese: ils eurent la tê-
te tranchée.
Per ultimo dee notarsi , che talvolta essere
sembra usato per avere, come in quel luo-
go
/ BEGIN PAGE 107 /
go del Boccaccio g. 4. n. 3. Essi godevano del
loro amore. E già buona pezza goduti n’ era-
no , quando avvenne &c.
CAP. XXX.
Conjugazione del Verbo amare, ch’ è la prima
regolare, co’ suoi anomali.
INDICATIVO.
PResente. Sing. Io amo, tu ami, colui ama.
Plural. Noi amiamo , voi amate , coloro
Amano .
Preterito imperfetto. Sing. Io amava , tu
amavi , colui amava . Plur. Amavamo, ama-
vate , amavano.
Preterito indeterminato . Sing. Amai , ama-
sti , amò . Plur. Amammo, amaste, amarono.
Passato determinato. Singul. Ho , hai , ha
amato . Plur. Abbiamo , avete , hanno amato.
Trapassato imperfetto. Sing. Aveva, ave-
vi , aveva amato. Plur. Avevamo , aveva-
te , avevano amato .
Trapassato perfetto. Sing. Ebbi , avesti,
ebbe amato. Plur. Avemmo , aveste , ebbero
amato .
Futuro imperfetto. Sing. Amerò, amerai,
amerà . Plur. Ameremo, amerete , ameranno.
Futuro perfetto. Sing. Avrò, avrai, avrà
amato. Plur. Avremo , avrete , avranno amato.
IM-
/ BEGIN PAGE 108 /
IMPERATIVO.
Presente. Sing. Ama tu, ami colui. Plur.
Amiamo , amate , amino.
Futuro. Sing. Amerai tu, amerà colui. Plur.
Ameremo , amerete , ameranno.
OTTATIVO.
Presente perfetto . Singul. Dio volesse che
io amassi , tu amassi, colui amasse. Plur. Amas-
simo , amaste, amassero.
Presente imperfetto . Sing. Amerei , amere-
sti , amerebbe. Plur. Ameremmo , amereste ,
amerebbono.
Preterito determinato . Sing. Dio voglia che
io abbia, tu abbi, colui abbia amato. Plur.
Abbiamo, abbiate, abbiano amato.
Preterito indeterminato . Sing. Avrei, avre-
sti , avrebbe amato. Plur. avremmo , avreste,
avrebbero amato.
Trapassato. Sing. Dio volesse che io avessi,
tu avessi, colui avesse amato . Plur. Avessimo,
aveste , avessero amato .
Futuro. Sing. Ch’ io ami, tu ami , colui ami.
Plur. Amiamo , amiate , amino.
CONGIUNTIVO.
Presente . Ch’ io ami &c., come nel Futu-
ro dell’ Ottativo .
Preterito imperfetto. Che io amassi &c., co-
me nel Presente perfetto dell’Ottativo.
Preterito perfetto . Sing. Quando abbia, ab-
bi , abbia amato. Plural. Abbiamo , abbiate,
abbiano amato.
Tra-
/ BEGIN PAGE 109 /
Trapassato. Sing. Quando avessi , avessi ,
aveße amato . Plur. Avessimo, aveste, aves-
sero amato.
Futuro. Sing. Se amerò, amerai, amerà.
Plur. Ameremo, amerete, ameranno.
INFINITO.
Presente. Amare.
Preterito. Avere amato .
Futuro. Avere ad, dovere, o essere per
amare.
Osservazioni sopra la prima conjugazione.
LA prima persona singulare del preterito
imperfetto dell’ indicativo non è già : io
amavo, come dice il volgo , ma io amava,
e questa terminazione in a in tal tempo,
senza ch’io l’abbia a replicar di vantaggio,
è comune a tutti i Verbi, ed è stabilita con
fermissima regola.
Parimente dee dirsi nel plurale del prete-
rito indeterminato amammo , non già amassi-
mo , che è Presente perfetto dell’Ottativo ;
ed è parimente osservazione comune a tutti
i Verbi.
Osservazione propria della prima conju-
gazione si è primieramente la mutazione ,
che si fa nella penultima sillaba nel futuro
imperfetto dell’ Indicativo , nel Futuro dell’
Imperativo , o nel Presente imperfetto dell’
Otta-
/ BEGIN PAGE 110 /
Ottativo, mettendovi l’ e in luogo dell’ a,
e dicendo : amerò &c. amerei &c. Pareva di
necessità, dice il Bembo , che si dovesse di-
re : amarò , amarei , come udiamo dir tutto
dì dal volgo , e ciò secondo l’analogia, e
l’ esempio delle altre tre conjugazioni , le
quali non ammettono in tali tempi mutazio-
ne alcuna . Ma l’ uso della lingua ha porta-
to , che si dica amerò, amerei, canterò, can-
terei , e così del restante ; ed è maniera più
graziosa , e gentile.
Ancora nella terza persona plurale del Pre-
terito indeterminato dell’ Indicativo si dice
amarono , e similmente studiarono , pensaro-
no &c. , e il dire col volgo amorono, studio-
rono, pensorono &c., è errore ben grande.
Nel Futuro dell’ Infinito abbiamo posto do-
vere amare , perchè il Verbo Dovere è ausi-
liario , che si può congiugnere con tutti i
Verbi nell’infinito, e significa essere , esser pos-
sibile , necessario, conveniente, e simili ; il che
vogliamo aver detto per sempre .
Verbi anomali della prima conjugazione.
DARE è anomalo ne’ seguenti tempi. In-
dicativo . Presente . Sing. Io do, tu dai,
colui dà. Plur. Noi diamo , voi date , coloro
danno. Preterito indeterminato. Sing. Io die-
di , o die’ , tu desti , colui diede, o diè. Plur.
Noi
/ BEGIN PAGE 111 /
Noi demmo, voi deste , coloro diedero , diedo-
no , o dierono. Futuro . Sing. Darò, darai,
darà . Plur. Daremo, darete, daranno . Impe-
rativo . Dà tu, dia, o dea colui . Diamo,
date, dieno , o deano . Ottativo . Presente
perfetto. Dessi, dessi, deße. Dessimo , deste,
deßero, o dessono. Presente imperfetto . Da-
rei, daresti, darebbe. Daremmo, dareste, da-
rebbero, o darebbono.
APPENDICE.
Dasti , daste , dessi , dasse , dassero non so-
no voci di buon calibro , perchè ne’ buoni
Autori si truova sempre desti &c., come sopra.
Lo stesso dico di diano per dieno.
STARE. Indicativo. Presente. Io sto, tu
stai , colui sta . Noi stiamo, voi state, coloro
stanno. Passato indeterminato. Stetti , stesti,
stette. Stemmo , steste , stettero . Futuro. Sta-
rò , starai, starà . Staremo, starete , staran-
no . Imperativo. Sta tu , stia , o stea colui.
Stiamo, state, stieno , o steano . Ottativo.
Presente perfetto. Stessi, stessi, stesse . Stessi-
mo , steste , stessero, o stessono . Presente im-
perfetto . Starei, staresti, starebbe . Starem-
mo , stareste , starebbono , o starebbero.
APPENDICE.
Similmente non sono buone voci stasti ,
staste , stiano , stassi , staße , staßero .
FARE. Indicativo presente. Io fo, e poe-
ticamente faccio, tu fai, colui fa, e in ver-
so
/ BEGIN PAGE 112 /
so face . Facciamo, fate, fanno. Preterito im-
perfetto. Io faceva, e poeticamente fea , tu
facevi, colui faceva. Facevamo, facevate, fa-
cevano. Preteriti. Io feci, e in verso fei, e
ho fatto, tu facesti, e hai fatto, colui fece, fe,
poeticamente feo, e ha fatto. Facemmo, fa-
ceste , fecero, e all’antica ferono, feciono , o
fenno ; e abbiamo, avete , hanno fatto . Futu-
ro. Farò, farai , farà . Faremo, farete, fa-
ranno. Imperativo . Fa tu, faccia colui. Fac-
ciamo, fate , facciano . Ottativo. Presente per-
fetto. Facessi, facessi , facesse . Facessimo , fa-
ceste, facessero. Presente imperfetto. Farei,
fareste, farebbe , o faria. Faremmo, fareste,
farebbero , farebbono , o fariano. Gerundio.
Faccendo. Participio. Fatto.
APPENDICE.
Si noti , e si fugga l’ errore di chi dice
faccino per facciano .
ANDARE. Questo Verbo è composto di
tre Verbi difettivi, andare , ire , e gire. Si
conjuga come siegue ; notando però, che le
voci appartenenti al Verbo gire sono più del
verso , che della prosa.
INDICATIVO.
Presente . Sing. Io vo, o vado, tu vai, co-
lui va. Plur. Noi andiamo , o gimo , voi an-
date , o gite, coloro vanno.
Preterito imperfetto. Sing. Io andava , o
giva , tu andavi, o givi , colui andava , o
giva.
/ BEGIN PAGE 113 /
giva . Plur. Noi andavamo , o givamo , voi
andavate, o givate, coloro andavano , o gi-
vano .
Preterito indeterminato . Sing. Io andai ,
tu andasti , o gisti , colui andò , gì , o gìo.
Plur. Noi andammo , o gimmo , voi andaste,
o giste, coloro andarono , o girono .
I tempi composti fanno : Sono , era , fui,
sarò &c. andato , ito, o gito.
Futuro imperfetto. Sing. Io andrò , tu an-
drai, colui andrà . Plur. Noi andremo , voi
andrete, coloro andranno. Sì noti , che Ande-
rò &c. anderemo &c. non sono voci troppo
buone.
IMPERATIVO.
Presente . Va tu, Vada colui. Andiamo noi,
andate , ite , o gite voi , vadano coloro .
Futuro. Andrai tu , andrà colui. Andremo
noi , andrete voi, andranno coloro.
OTTATIVO.
Presente perfetto . Dio volesse , che io an-
dassi, tu andassi , colui andasse . Andassimo,
andaste , andassero .
Presente imperfetto. Andrei, andresti, an-
drebbe. Andremmo, andreste, andrebbero.
I tempi composti fanno . Sia, sarei, fossi
andato , ito, o gito.
Futuro. Sing. Ch’ io vada, tu vadi, colui
vada. Plur. Andiamo , andiate , vadano .
Congiuntivo, come ne’ tempi , ch’ e’ pren-
de in prestanza. H IN-
/ BEGIN PAGE 114 /
INFINITO.
Presente. Andare , ire , e gire.
Preterito. Essere andato , ito , o gito.
Futuro. Eßere per , dovere , o avere ad
Andare , ire , o gire .
Gerundio. Andando, e presso qualche anti-
co si truova gendo.
CAP. XXXI.
Conjugazione del Verbo temere,
ch’ è la seconda regolare.
INDICATIVO.
PResente. Sing. Io temo , tu temi, colui te-
me. Plur. Noi temiamo , voi temete, co-
loro temono.
Preterito imperfetto. Temeva, temevi, te-
meva. Temevamo , temevate , temevano.
Preterito indeterminato. Sing. Temei , o te-
metti , temesti , temè , o temette. Tememmo,
temeste , temerono , o temettero .
Preterito determinato . Ho, hai, ha temu-
to . Abbiamo, avete, hanno temuto.
Trapassato imperfetto . Aveva , avevi,
aveva temuto. Avevamo , avevate , aveva-
no temuto.
Trapassato perfetto. Ebbi, avesti, ebbe te-
muto . Avemmo, aveste , ebbero temuto.
Futu-
/ BEGIN PAGE 115 /
Futuro imperfetto. Temerò , temerai , teme-
rà . Temeremo , temerete , temeranno.
Futuro perfetto . Avrò , avrai , avrà te-
muto . Avremo , avrete , avranno temuto.
IMPERATIVO .
Presente. Temi tu , tema colui. Temiamo,
temete , temano .
Futuro. Temerai tu, temerà colui . Teme-
remo , temerete , temeranno.
OTTATIVO.
Presente perfetto. Dio volesse ch’ io temessi,
tu temessi, colui temesse. Temessimo , temeste ,
temessero .
Presente imperfetto. Temerei, temeresti,
temerebbe . Temeremmo , temereste , temereb-
bero .
Preterito determinato . Dio voglia ch’ io ab-
bia, tu abbi , colui abbia temuto. Abbiamo,
abbiate, abbiano temuto.
Preterito indeterminato . Avrei , avresti,
avrebbe temuto . Avremmo, avreste , avreb-
bero temuto.
Trapassato . Dio volesse ch’ io avessi , tu
avessi , colui aveße temuto. Avessimo , aveste,
avessero temuto.
Futuro . Ch’ io tema, tu temi, colui tema.
Temiamo , temiate, temano.
CONGIUNTIVO.
Presente . Che io tema &c., come nel Fu-
turo dell’Ottativo.
H 2 Pre-
/ BEGIN PAGE 116 /
Preterito imperfetto. Ch’ io temessi &c., co-
me nel Presente perfetto dell’ Ottativo .
Preterito perfetto. Quando io abbia &c.,
come nel Preterito determinato dell’ Ottativo.
Trapassato . Se io avessi temuto &c., come
nel Trapassato dell’ Ottativo .
Futuro . Se io temerò &c., come nel Futu-
ro imperfetto dell’ Indicativo.
INFINITO.
Presente . Temere.
Preterito. Aver temuto .
Futuro. Avere a , dovere , o eßere per
temere.
Osservazioni sopra la seconda
Conjugazione .
I Verbi di questa conjugazione o tutti , o
quasi tutti, si trovano presso gli antichi
nel Preterito indeterminato dell’ Indicativo
terminati indifferentemente in ei, e in etti,
come temere. La terminazione in ei porta la
terza persona singolare in è accentato, e la
terza plurale in erono, come temè, temerono.
La terminazione in etti nella terza persona
singolare esce in ette, e nella plurale in et-
tero, come temette, temettero.
Ma presso i primi maestri , e nell’uso de’
migliori Scrittori si truova molta varietà nel-
la formazione di questi preteriti , la quale non
s’in-
/ BEGIN PAGE 117 /
s’ incontra nel formare i preteriti indetermi-
nati de’ Verbi regolari della prima conjuga-
zione , i quali da quello del Verbo amare ,
senza varietà , si formano. Chi amasse di ve-
dere questa materia sottilmente trattata , leg-
ga il Bembo lib. 3., il Castelvetro nella Giun-
ta partic. 23., e il Cinonio nel Tratt. de’ Ver-
bi cap. 8. 9. e 10. Noi ci contenteremo delle se-
guenti osservazioni .
I Verbi , che hanno la c per loro natural
consonante, come tacere, giacere, piacere , e
i loro composti , nella prima , e nella terza
persona del singulare , e nella terza persona
del plurale prendono il q , e hanno una lo-
ro particolare uscita, e si dice: tacqui, giac-
qui , piacqui ; tacque, giacque, piacque ; tac-
quero, giacquero, piacquero .
Ne’ Verbi, che hanno per consonante la l,
come sono valere, dolere , e i loro compo-
sti , si forma il preterito , detrattone ere , con
aggiugnervi si, o se in singulare, e sero in plura-
le , e si dice : valsi , dolsi ; valse , dolse ; val-
sero, dolsero . Lo stesso può dirsi del Verbo
volere , di cui si truova presso a buoni auto-
ri volsi, volse, volsero, benchè non sieno in
ciò da volersi imitare : e altresì del Ver-
bo difettivo calere, di cui truovasi calse ter-
za persona singulare.
Avere , cadere, tenere, sapere, volere for-
mano il preterito col raddoppiare la loro
H 3 con-
/ BEGIN PAGE 118 /
consonante, e aggiugnervi l’i, o e in singulare,
ed ero in plurale , e si dice : ebbi , caddi , ten-
ni, seppi, volli : ebbe , cadde , tenne , seppe,
volle : Ebbero, caddero, tennero, seppero, vol-
lero. E si noti, che avere, per miglior suono,
muta la prima vocale. Parimente il Verbo ve-
dere, secondo l’ uso Toscano, fa veddi, vedde,
veddero ; benchè negli antichi si truovi vidi,
vide , videro , e così ne’ composti.
Alcuni Verbi sembrano in ciò fuor d’ ogni
regola ; come parere, che fa parvi , parve,
parvero ; e rimanere , che fa rimasi, rimase,
rimasero .
Gli altri Verbi hanno la desinenza in ei,
è, erono, o pure in etti , ette , ettero ; e que-
sta seconda desinenza sembra la più famiglia-
re a’ Toscani.
CAP. XXXII.
De’ Verbi anomali della seconda
Conjugazione .
CADERE anomalo in tre tempi dell’ In-
dicativo. Presente . Sing. Io cado , tu ca-
di , colui cade . Plur. Noi cadiamo, usato di
rado , voi cadete, coloro cadono. Preterito in-
determinato. Caddi , cadesti, cadde . Cadem-
mo , cadeste , caddero , caddono , e anche ca-
derono , ma di rado. Futuro. Cadrò, o cade-
rò, cadrai , o caderai, cadrà , o caderà . Ca-
dremo,
/ BEGIN PAGE 119 /
dremo, o caderemo, cadrete, o caderete , ca-
dranno , o caderanno. Similmente nell’ Otta-
tivo fa cadrei , o caderei &c.
PARERE anomalo in quattro tempi . In-
dicativo. Presente . Io pajo , tu pari , colui
pare. Noi pajamo , voi parete, coloro pajo-
no . Preterito . Parvi, paresti, parve . Parem-
mo, pareste , parvero . Futuro . Parrò, par-
rai, parrà . Parremo , parrete , parranno . E
così nell’ Ottativo. Parrei , parresti , parreb-
be &c. Il dir parerò , parerai, parerà , pare-
rei &c. senza la sincope dal buono uso in-
trodotta, è reputato errore. Imperativo. Pre-
sente . Pari tu, paja colui. Pajamo , parete ,
pajano. Il participio , con cui si formano i
tempi composti , è paruto, benchè si truovi
talvolta parso , singolarmente ne’ Poeti . In
luogo di parvi , parve , parvero il dire parsi,
parse, parsero è uso men che buono.
SAPERE anomalo in due tempi dell’ Indi-
cativo. Presente . Io so , tu sai , colui sa .
Sappiamo, sapete, sanno . Preterito . Seppi, sa-
pesti , seppe. Sapemmo , sapeste , seppero. In
questo Verbo dee dirsi : saprò &c. saprei &c.,
e il dir , senza sincopa , saperò &c. saperei &c.
son modi contadineschi.
SEDERE anomalo in due tempi . Indica-
tivo . Io seggo , tu siedi, colui siede . Noi seg-
giamo , o sediamo , voi sedete , coloro seggo-
no , o seggiono. Imperativo. Presente . Siedi
H 4 tu,
/ BEGIN PAGE 120 /
tu, segga colui. Sediamo, o seggiamo noi, se-
dete voi, seggano coloro .
TENERE anomalo in sei tempi . Indicati-
vo. Presente. Tengo , tieni , tiene. Tenghia-
mo , tenete, tengono. Preterito . Tenni, tene-
sti , tenne. Tenemmo , teneste, tennero. Futu-
ro. Terrò , terrai, terrà. Terremo , terrete ,
terranno. Imperativo . Presente. Tieni tu,
tenga colui . Tenghiamo, tenete , tengano . Il
Futuro va come quello dell’ Indicativo . Ot-
tativo. Presente imperfetto. Terrei, terresti,
terrebbe. Terremmo , terreste, terrebbero, o
terrebbono. Futuro . Che io tenga, tu tenghi,
colui tenga. Che noi tenghiamo , voi tenghia-
te , coloro tengano.
DOVERE anomalo in sei tempi, e con
mutazione della sua propria vocale. Indica-
tivo. Presente. Io debbo, o deggio, tu dei,
o debbi, colui dee, o debbe . Noi dobbiamo,
voi dovete, coloro debbono , deggiono, o deono .
Preterito . Dovetti , dovesti , dovette . Do-
vemmo, doveste , dovettero. Futuro . Dovrò ,
dovrai, dovrà . Dovremo , dovrete, dovranno.
Imperativo. Presente . Debbi tu , debba, o
deggia colui. Dobbiamo, dobbiate, debbano , o
deggiano. Ottativo . Presente imperfetto. Do-
vrei, dovresti, dovrebbe . Dovremmo, dovre-
ste, dovrebbero , o dovrebbono . Futuro . Ch’ io
debba , debbia, o deggia , tu debbi , o dei,
colui debba, debbia, o deggia . Che noi dobbia-
mo,
/ BEGIN PAGE 121 /
mo , voi dobbiate, coloro debbano , debbiamo,
deggiano , o deano .
POTERE anomalo in quattro tempi. In-
dicativo. Presente . Io posso , tu puoi, colui
può, e in verso puote . Noi possiamo ( e non
mai potiamo, ch’ è voce barbara ) voi potete,
coloro possono. Futuro. Potrò , potrai , potrà.
Potremo, potrete , potranno. Ottativo. Presen-
te imperfetto. Potrei, potresti, potrebbe. Po-
tremmo, potreste , potrebbero , o potrebbono .
Futuro. Ch’ io possa, tu possi, colui poßa. Pos-
siamo , possiate , possano . E si noti , che il di-
re : poterò, poterai &c. per potrò, potrai &c.,
e poterei , poteresti &c. per potrei, potresti &c.
VOLERE anomalo in sei tempi. Indica-
tivo. Presente. Io voglio, o pure , io vo’,
tu vuogli, oggi vuoi , colui vuole . Vogliamo,
volete , vogliono . Preterito . Io volli, tu vo-
lesti , colui volle. Volemmo , voleste , vollero,
o vollono. Futuro . Vorrò, vorrai, vorrà. Vor-
remo , vorrete, vorranno . Imperativo. Pre-
sente. Vuogli , o vogli tu, voglia colui. Vo-
gliamo noi, vogliate voi, vogliano coloro.
Ottativo. Presente imperfetto. Vorrei, vor-
resti, vorrebbe. Vorremmo, vorreste , vorreb-
bero , o vorrebbono . Futuro. Ch’ io voglia, tu
vuogli , o vogli , colui voglia. Vogliamo , vo-
gliate , vogliano .
Si noti , che , volsi , e volse per volli , e
volle
/ BEGIN PAGE 122 /
volle appartengono propriamente al Verbo
volgere, e non già al Verbo volere. E’ ve-
ro , che si truovano negli Scrittori del buon
secolo , ma perchè vi si truovano usati di
rado , e talvolta da’ Poeti per necessità del-
la rima , non vogliono usarli . Volsero per
vollero è di lega ancora peggiore.
VEDERE in cinque tempi anomalo . In-
dicativo. Presente . Io vedo, veggo , o veg-
gio, tu vedi , colui vede. Veggiamo , vedete,
veggono . Preterito. Io veddi, o vidi, tu ve-
desti, colui vedde, o vide. Vedemmo, vede-
ste, veddero, o videro. Futuro. Vedrò , ve-
drai, vedrà. Vedremo , vedrete , vedranno.
E così nell’ Imperfetto dell’ Ottativo si dice :
vedrei &c., e il dire : vederò &c., vederei &c.
non è di uso buono . Imperativo . Presente .
Vedi tu, vegga colui. Veggiamo noi, vedete
voi , veggano coloro. Ottativo . Futuro . Ch’ io
vegga , tu vegghi, colui vegga . Veggiano,
veggiate, veggano.
/ BEGIN PAGE 123 /
CAP. XXXIII.
Conjugazione del Verbo leggere,
ch’ è la terza regolare.
INDICATIVO.
Presente . Io leggo , tu leggi , colui legge .
Noi leggiamo , voi leggete , coloro leg-
gono .
Preterito imperfetto. Io leggeva, tu legge-
vi , colui leggeva . Leggevamo , leggevate ,
leggevano.
Preterito indeterminato . Lessi , leggesti ,
lesse. Leggemmo, leggeste, lessero.
Preterito determinato . Ho, hai, ha letto.
Abbiamo, avete, hanno letto.
Trapassato imperfetto. Io aveva, tu ave-
vi, colui aveva letto. Avevamo , avevate,
avevano letto.
Trapassato perfetto . Ebbi, avesti , ebbe
letto . Avemmo, aveste, ebbero letto.
Futuro imperfetto. Leggerò, leggerai, leg-
gerà . Leggeremo , leggerete, leggeranno.
Futuro perfetto. Avrò, avrai, avrà let-
to. Avremo , avrete, avranno letto.
IMPERATIVO.
Presente. Leggi tu, legga colui. Leggia-
mo, leggete, leggano.
Futu-
/ BEGIN PAGE 124 /
Futuro. Leggerai tu, leggerà colui . Leg-
geremo, leggerete, leggeranno.
OTTATIVO.
Presente perfetto . Dio voleße ch’ io leg-
gessi, tu leggessi, colui leggesse . Leggessimo,
leggeste, leggessero.
Presente imperfetto . Leggerei, leggeresti,
leggerebbe. Leggeremmo, leggereste, leggereb-
bero.
Preterito determinato . Dio voglia ch’ io
abbia , tu abbi, colui abbia letto . Che noi ab-
biamo , voi abbiate , coloro abbiano letto.
Preterito indeterminato . Avrei , avresti ,
avrebbe letto. Avremmo, avreste, avrebbero
letto.
Trapassato . Dio volesse ch’ io avessi, tu
avessi , colui avesse letto. Che noi avessimo,
voi aveste , coloro avessero letto.
Futuro. Ch’ io legga, tu legghi, colui leg-
ga . Che noi leggiamo, voi leggiate , coloro
leggano.
CONGIUNTIVO.
Presente. Ch’ io legga &c., come nel Fu-
turo dell’Ottativo .
Preterito imperfetto. Ch’ io leggessi &c., co-
me nel Presente perfetto dell’Ottativo.
Preterito perfetto . Quando io abbia let-
to &c., come nel Preterito determinato dell’
Ottativo.
Tra-
/ BEGIN PAGE 125 /
Trapassato. Se io avessi letto &c., come
nel Trapassato dell’Ottativo .
Futuro . Se io leggerò &c. , come nel Fu-
turo imperfetto dell’Indicativo.
INFINITO.
Presente . Leggere .
Preterito . Aver letto.
Futuro . Avere a, dovere, o esser per leg-
gere.
Osservazioni sopra la terza
Conjugazione .
S’ Incontra grandissima varietà nella for-
mazione de’ preteriti di questa conjuga-
zione, come può vedersi ne’ sopraccitati Gra-
matici , da’ quali abbiamo tratte le seguenti
osservazioni.
I Verbi, che nella prima persona singula-
re dell’ Indicativo presente escono in go col-
la g doppia , come fa il conjugato Verbo
leggere , sono anche simili ad esso nel pre-
terito in ssi, salva a ciascun Verbo la penul-
tima vocale sua propria . Così traggo fa trassi ;
eleggo elessi ; reggo ressi ; affliggo , affiggo,
configgo, trafiggo fanno afflissi, affissi, con-
fissi, trafissi ; struggo, distruggo fanno strussi,
distrussi, e così degli altri.
Altri Verbi ancora della terza, i quali
nella prima lor voce non hanno, come i pre-
cedenti, l’ultima consonante doppia, pure
hanno
/ BEGIN PAGE 126 /
hanno terminazione regolare nel preterito ,
e questi sarà più utile addurli , che il porli
sotto regola . Dico ha dissi ; scrivo scrissi,
vivo vissi ; muovo mossi ; cuoco cossi ; condu-
co, induco, introduco, riduco, e simili, hanno
condussi, indussi, introdussi, ridussi. Impri-
mo, esprimo, opprimo , reprimo, e sì fatti
hanno impressi , espressi, oppressi, ripressi,
alla Latina, con mutazione della loro vocale.
Scuoto , riscuoto , percuoto , e simili hanno
scossi, riscossi, percossi. Concedo , cedo , pro-
cedo, succedo, e simili si truovano presso ad
antichi scrittori , e presso ancora a’ Poeti ,
coll’ uscita regolare nel preterito, concessi &c.,
e col participio concesso &c., ma ne’ miglio-
ri scrittori, e nel miglior uso hanno la ter-
minazione come i Verbi della seconda, cioè
concedetti, procedetti, succedetti &c., e il par-
ticipio conceduto, proceduto, succeduto &c.
Que’ Verbi, i quali nella prima loro vo-
ce finiscono in do seguente a vocale, nel
preterito escono in si, a cui precede la vo-
cale propria del Verbo . Così chiedo fa chiesi;
assido assisi, conquido conquisi, divido divisi;
recido recisi; rido risi ; uccido uccisi ; rodo rosi;
chiudo chiusi ; e così i loro composti.
I Verbi terminati nella prima voce in en-
do, ondo , nel preterito escono in si, a cui
precede la vocale propria del Verbo . Così
accendo ha accesi ; ascendo ascesi ; apprendo
appresi;
/ BEGIN PAGE 127 /
appresi; attendo attesi; contendo contesi; spen-
do spesi ; difendo difesi ; intendo intesi ; offen-
do offesi ; prendo presi; riprendo ripresi ; so-
spendo sospesi; tendo tesi ; stendo stesi ; e co-
sì i loro composti. Parimente nascondo ha na-
scosi; rispondo risposi : ma si noti , che fondo,
rifondo, profondo, confondo mutano la propria
vocale in u, e fanno fusi, rifusi, profusi,
confusi. A tali Verbi si aggiungono, pongo,
che ha posi, e metto, prometto, e loro com-
posti, che hanno misi, e promisi.
I Verbi , i quali nella loro prima voce
hanno innanzi l’ ultima vocale due diverse
consonanti , la prima delle quali sia una del-
le tre liquide LNR , colla medesima lettera ,
aggiugnendovi si, formano il preterito. Così
primieramente scelgo ha scelsi ; divelgo di-
velsi ; colgo colsi ; dolgo dolsi ; sciolgo sciolsi ;
tolgo tolsi ; volgo volsi ; e così i loro compo-
sti . E a questi possono aggiugnersi cale , e
vaglio , che fanno calse, e valsi, benchè non
abbia il secondo la l prima dell’altra con-
sonante. In secondo luogo vinco ha vinsi ;
frango fransi ; piango piansi ; spengo spensi;
cingo cinsi; dipingo dipinsi; fingo finsi; sospin-
go sospinsi; stringo strinsi; tingo tinsi ; distin-
guo distinsi ; estinguo estinsi ; giungo giunsi;
ungo unsi; mungo munsi; pungo punsi, e simi-
li, co’ loro composti . E a questi si possono
aggiugnere consumo, e presumo, i quali non
aven-
/ BEGIN PAGE 128 /
avendo la terminazione simile a questi Ver-
bi, hanno talvolta simile il preterito , e fan-
no consunsi , presunsi ; benchè il primo più
frequentemente si adoperi della prima con-
jugazione , e faccia consumai ; e il secondo
faccia spesso presumetti alla maniera della
seconda . In terzo luogo finalmente torco fa
torsi; ardo arsi ; mordo morsi ; spargo sparsi ;
aspergo aspersi; accorgo accorsi ; scorgo scorsi;
porgo porsi ; sorgo , o surgo sorsi , o sursi ;
scerno scersi ; corro corsi ; ricorro ricorsi ; e si-
mili, co’ loro composti. Perdo presso a’ Poe-
ti ha persi, e nel participio perso, ma l’uso
migliore si è perdei, e perduto.
Non pochi Verbi della terza hanno il pre-
terito terminato in ei, o in etti, ch’è pro-
prio della seconda conjugazione. Così empie-
re fa empiei (e parimente i suoi composti) batte-
re battei; perdere perdei; premere premei, e
premetti; vendere vendei, e vendetti; tonde-
re tondei; splendere , e composti , splendei ;
rendere rendei , e rendetti ; ricevere ricevetti,
e anche ricevei; credere credetti ( che alcu-
no antico disse cresi ) pascere pascei ; pende-
re , e dipendere pendei , dipendei. A questi si
aggiungano concedo , cedo, e gli altri simili
eccettuati di sopra . Fendere ha fendei, ma
talvolta anche fessi. Discernere, benchè pres-
so a Dante , citato dal Cinonio, abbia di-
scernei, non è però in uso, e può dirsi man-
cante del preterito. Fuor
/ BEGIN PAGE 129 /
Fuor d’ogni regola sembrano i seguenti
Verbi nel preterito, cioè essere, che ha fui,
conoscere conobbi, rompere ruppi ; nascere nac-
qui ; nuocere nocqui ; e piovere, che ha piov-
vi, e anche piovei.
CAP. XXXIV.
Verbi anomali della terza Conjugazione.
LA maggior parte de’ seguenti anomali han-
no la prima voce sincopata, ma perchè
la voce intera ( benchè il più non debba usarsi,
per essere antica, e dismessa ) è della terza
conjugazione ; perciò l’analogia , e l’ano-
malia di questi Verbi si considera per rap-
porto alla terza , e non già a quella conju-
gazione, alla quale la voce sincopata appar-
tiene.
DIRE, anticamente dicere, anomalo in sei
tempi , e con esso ridire, disdire, e gli al-
tri composti . Indicativo. Presente. Io dico,
tu dici, o dì, colui dice. Diciamo, dite, di-
cono . Preterito. Dissi, dicesti, disse. Dicem-
mo , diceste, dissero. Futuro. Dirò, dirai,
dirà . Diremo, direte, diranno. Imperativo.
Presente. Dì tu, dica colui. Diciamo, dite,
dicano. Ottativo . Presente imperfetto. Di-
rei, diresti, direbbe. Diremmo, direste, di-
rebbero, o direbbono . Futuro. Ch’ io dica,
I tu
/ BEGIN PAGE 130 /
tu dichi, colui dica. Diciamo, diciate, dica-
no.
PORRE, anticamente ponere, anomalo in
sei tempi, e con esso comporre, proporre , ed
altri composti. Indicativo. Presente. Io pon-
go, tu poni , colui pone . Noi poniamo , o pon-
ghiamo , voi ponete , coloro pongono. Preteri-
to. Posi, ponesti, pose . Ponemmo , poneste ,
posero, posono, o puosono. Futuro . Porrò,
porrai, porrà. Porremo, porrete, porranno.
Imperativo. Presente. Poni tu , ponga colui.
Poniamo , pognamo , o ponghiamo noi , ponete
voi , pongano coloro. Ottativo. Presente im-
perfetto. Porrei, porresti , porrebbe. Porrem-
mo , porreste, porrebbero, o porrebbono. Futu-
ro. Ch’ io ponga, tu ponghi, colui ponga. Pon-
ghiamo, ponghiate, pongano.
SCIOGLIERE, comunemente sciorre, ano-
malo in cinque tempi, e con esso proscior-
re, disciorre, ed altri composti , e ancora
altri Verbi di simile desinenza, come coglie-
re ; ricogliere &c. Indicativo . Presente. Io
scioglio, o sciolgo , tu sciogli , colui scioglie.
Noi sciogliamo, voi sciogliete , coloro sciolgo-
no , o sciogliono. Preterito . Sciolsi, sciogliesti,
sciolse. Sciogliemmo , scioglieste , sciolsero . Fu-
turo . Sciorrò, sciorrai , sciorrà . Sciorremo,
sciorrete, sciorranno . Imperativo. Sciogli tu,
sciolga colui . Sciogliamo , sciogliete , sciolga-
no. Ottativo. Futuro. Ch’ io sciolga, tu scio-
gli,
/ BEGIN PAGE 131 /
gli, colui sciolga. Noi sciogliamo, o sciolghia-
mo , voi sciogliate , coloro sciolgano.
TOGLIERE , comunemente torre, e con
esso distorre, e altri composti . Indicativo.
Presente. Io tolgo , o toglio, tu togli , colui
toglie, tolle, o toe. Noi tolghiamo, voi to-
gliete , coloro tolgono, o tollono . Preterito im-
perfetto. Io toglieva &c. Preterito perfetto.
Tolsi, togliesti , tolse. Togliemmo , toglieste,
tolsero. Futuro . Torrò , torrai, torrà. Torre-
mo, torrete, torranno. Imperativo. Presente.
Togli, o toi tu, tolga colui. Tolghiamo noi ,
togliete voi, tolgano coloro. Ottativo . Pre-
sente perfetto. Togliessi &c. Presente imper-
fetto . Torrei. Futuro . Ch’ io tolga , tu tol-
ga, colui tolga. Che noi tolghiamo, voi tolghia-
te , coloro tolgano.
SCEGLIERE. Indicativo. Presente. Io scel-
go , tu scegli, colui sceglie . Noi scegliamo,
voi scegliete, coloro scelgono. Preterito. Scelsi,
scegliesti, scelse . Scegliemmo, sceglieste, scel-
sero. Futuro. Sceglierò &c. Imperativo. Pre-
sente. Scegli tu, scelga colui. Scegliamo noi,
scegliete voi, scelgano coloro. Ottativo. Pre-
sente perfetto. Scegliessi &c. Presente imper-
fetto . Sceglierei &c. Infinito. Scegliere , o
scerre, e avere scelto.
VOLGERE, e con esso rivolgere, ed al-
tri composti. Indicativo. Presente. Io volgo,
tu volgi, colui volge . Noi volgiamo, voi vol-
I 2 gete,
/ BEGIN PAGE 132 /
gete, coloro volgono. Preterito. Volsi , volge-
sti, volse . Volgemmo , volgeste, volsero . Fu-
turo. Volgerò &c. Imperativo . Presente . Vol-
gi tu, volga egli. Volgiamo , volgete , volga-
no. Ottativo. Presente. Volgessi &c. Volgerei &c.
Futuro. Ch’ io volga , tu volga, colui volga.
Che noi volgiamo, che voi volgiate, che co-
loro volgano .
ADDURRE, già adducere, con ridurre,
condurre, produrre, e simili . Indicativo . Pre-
sente. Io adduco, tu adduci, colui adduce. Addu-
ciamo, adducete, adducono. Preterito . Addussi,
adducesti , addusse. Adducemmo , adduceste , ad-
dussero . Futuro. Addurrò , addurrai , addur-
rà. Addurremo , addurrete , addurranno . Im-
perativo. Presente . Adduci tu, adduca colui.
Adduciamo , adducete, adducano. Ottativo.
Presente. Adducessi &c. Addurrei &c. Futuro.
Ch’ io adduca, tu adduchi , colui adduca. Ad-
duciamo, adduciate, adducano.
SPEGNERE, e con esso spignere, dipi-
gnere, tignere, cignere, strignere, e simi-
li , mutando l’ e in i. Indicativo . Presen-
te . Io spengo, tu spegni , colui spegne . Spen-
ghiamo , spegnete, spengono. Preterito. Spensi,
spegnesti , spense . Spegnemmo, spegneste,
spensero . Futuro . Spegnerò &c. Imperati-
vo . Presente . Spegni tu, spenga colui.
Spenghiamo, spegnete, spengano. Ottativo.
Presente. Spegnessi &c. Spegnerei. Futuro. Ch’
io
/ BEGIN PAGE 133 /
io spenga, tu spenghi, egli spenga . Spenghia-
mo , spenghiate, spengano.
CONOSCERE. Indicativo . Presente . Co-
nosco, conosci , conosce. Conosciamo, conoscete,
conoscono . Preterito. Conobbi , conoscesti, co-
nobbe . Conoscemmo, conosceste, conobbero. Ot-
tativo . Futuro. Ch’ io conosca, tu conoschi,
colui conosca . Conosciamo , conosciate , cono-
scano .
BERE ( che da alcuni sì dice , bevere, e
si conjuga regolarmente ) nel migliore uso
de’ Toscani, è anomalo come siegue . Indica-
tivo . Presente . Io beo , tu bei, egli bee. Noi
bejamo, voi beete, coloro beono. Preterito im-
perfetto. Io beeva , tu beevi , egli beeva.
Beevamo, beevate, beevano. Preterito deter-
minato . Ho beuto &c. Preterito indetermina-
to. Io bevvi, tu beesti, colui bevve. Beemmo,
beeste, bevvero. Futuro. Berò, berai, berà.
Beremo, berete, beranno. Imperativo. Pre-
sente. Bei tu, bea colui. Bejamo, beete, bea-
no. Futuro. Berai tu, berà egli. Beremo , be-
rete , beranno. Ottativo. Presente. Beessi &c.
Berei &c. Futuro . Ch’ io bea , tu bei , egli
bea. Bejamo, bejate, beano. Infinito. Bere,
e aver beuto. Gerundio beendo.
I 3 CAP.
/ BEGIN PAGE 134 /
CAP. XXXV.
Conjugatione del Verbo sentire,
ch’ è la quarta regolare.
INDICATIVO.
PResente. Io sento, tu senti , colui sente.
Sentiamo, sentite, sentono.
Preterito imperfetto. Io sentiva , tu senti-
vi , colui sentiva. Sentivamo , sentivate, sen-
tivano.
Preterito indeterminato. Io sentj, tu senti-
sti, egli sentì . Sentimmo, sentiste, sentirono.
Preterito determinato. Ho , hai, ha senti-
to . Abbiamo , avete, hanno sentito .
Trapassato imperfetto. Aveva, avevi, ave-
va sentito. Avevamo, avevate , avevano sen-
tito.
Trapassato perfetto. Ebbi, avesti, ebbe sen-
tito . Avemmo, aveste, ebbero sentito.
Futuro imperfetto. Sentirò , sentirai, senti-
rà. Sentiremo, sentirete , sentiranno.
Futuro perfetto. Avrò, avrai, avrà sen-
tito. Avremo, avrete, avranno sentito .
IMPERATIVO.
Presente. Senti tu , senta egli. Sentiamo,
sentite , sentano.
Futuro. Sentirai tu, sentirà egli. Sentire-
mo, sentirete, sentiranno.
OTTA-
/ BEGIN PAGE 135 /
OTTATIVO.
Presente perfetto. Dio volesse ch’ io sen-
tissi, tu sentissi, colui sentisse. Che noi sentis-
simo , voi sentiste, eglino sentissero .
Presente imperfetto. Sentirei , sentiresti,
sentirebbe . Sentiremmo , sentireste, sentireb-
bero.
Preterito determinato. Ch’ io abbia , tu ab-
bi , egli abbia sentito . Che abbiamo, abbia-
te , abbiano sentito .
Preterito indeterminato . Avrei, avresti,
avrebbe sentito. Avremmo , avreste, avreb-
bero sentito.
Trapassato . Dio voleße ch’ io avessi, tu
avessi , egli avesse sentito. Che avessimo, ave-
ste, aveßero sentito.
Futuro . Dio voglia ch’ io senta , tu senti,
egli senta . Che noi sentiamo , voi sentiate ,
coloro sentano.
CONGIUNTIVO.
Presente. Ch’ io senta &c. come nel Futu-
ro dell’ Ottativo.
Preterito imperfetto. Ch’ io sentissi. &c., co-
me nel Presente perfetto dell’ Ottativo.
Preterito perfetto . Quando io abbia senti-
to &c. come nel Preterito determinato dell’
Ottativo .
Trapassato . Quando io avessi sentito &c.,
come nel Trapassato dell’Ottativo.
I 4 Fu-
/ BEGIN PAGE 136 /
Futuro. Se io sentirò &c. come nel Futuro
imperfetto dell’ Indicativo.
INFINITO.
Presente . Sentire .
Preterito. Avere sentito.
Futuro. Avere a, dovere, o essere per sen-
tire.
CAP. XXXVI.
Anomali della quarta Conjugazione.
DAgl’ infrascritti anomali si scorgeranno
alcune eccezioni dalla formazion rego-
lare de’ preteriti, senza che qui facciamo os-
servazione alcuna.
APRIRE, COPRIRE, RICOPRIRE,
SCOPRIRE, regolati in tutti i tempi, fuor-
chè nel Preterito indeterminato dell’ Indica-
tivo, che fa così : Io aprj , o apersi, tu apri-
sti , colui aprì , o aperse. Noi aprimmo , voi
apriste , essi aprirono, apersero , o apersono.
SALIRE. Indicativo. Presente. Io salgo, o
saglio , tu sali, egli sale . Salghiamo, salite,
salgono, o sagliono. Preterito indeterminato .
Salj, salisti, salì . Salimmo, saliste , saliro-
no . Futuro. Salirò &c., e talvolta si dice :
sarrò &c. Imperativo. Presente . Sali tu, sal-
ga, o saglia colui. Salghiamo, salite, salga-
no, o sagliano. Ottativo . Presente secondo.
Sali-
/ BEGIN PAGE 137 /
Salirei, saliresti &c., e talvolta sarrei, sar-
resti &c. Futuro . Che io salga, o saglia , tu
salghi , egli salga, o saglia. Che noi salghia-
mo, o sagliamo, voi salghiate, o sagliate,
coloro salgano, o sagliano.
VENIRE. Indicativo. Presente. Io ven-
go, o vegno , tu vieni , egli viene . Noi ve-
niamo, venghiamo, o vegnamo, voi venite,
essi vengono . Preterito imperfetto . Io veni-
va &c. Preterito indeterminato. Venni , ve-
nisti , venne. Venimmo, veniste, vennero. Fu-
turo. Verrò, verrai &c. Imperativo. Presen-
te. Vieni tu, venga egli. Venghiamo , o ve-
gnamo noi, venite voi, vengano essi. Ottati-
vo. Presente. Venissi &c.
Imperf. Verrei &c. Futuro . Ch’ io venga ,
tu venghi , egli venga. Venghiamo, venghia-
te, vengano.
MORIRE. Indicativo. Presente. Io muo-
jo, e poeticamente moro , tu muori, egli muo-
re . Muojamo , morite, muojono . Preterito in-
determinato. Io morj , e non mai morsi, tu
moristi, egli morì, e non già morse. Morim-
mo , moriste , morirono, e non morsero, per-
chè tali voci appartengono al Verbo morde-
re . Futuro. Morirò, e meglio morrò &c. Im-
perativo . Presente . Muori tu, muoja , e in
verso mora , colui. Muojamo , morite, muoja-
no, e poeticamente morano. Ottativo. Pre-
sente perfetto. Ch’ io morissi, tu morissi, egli
moris-
/ BEGIN PAGE 138 /
morisse. Morissimo, moriste, morissero, o mo-
rißono. Presente imperfetto. Morrei, morre-
sti, morrebbe. Morremmo, morreste, morreb-
bono, o morriano . Futuro. Che io muoja, tu
muoi, o muoja, egli muoja. Muojamo , muo-
jate, muojano.
UDIRE anomalo con mutazione della pri-
ma vocale . Indicativo . Presente. Io odo, tu
odi, colui ode. Udiamo, udite, odono. Impe-
rativo. Presente. Odi tu, oda egli. Udiamo,
udite, odano. Ottativo. Futuro. Ch’ io oda,
tu oda, colui oda. Udiamo , udiate , odano.
Negli altri tempi è regolare colla prima vo-
cale u.
USCIRE anomalo colla suddetta mutazio-
ne. Indicativo . Presente. Io esco , tu esci,
egli esce. Usciamo, uscite, escono. Imperati-
vo presente . Esci tu, esca egli . Usciamo,
uscite, escano . Ottativo . Futuro . Ch’ io esca,
tu esca, egli esca . Usciamo, usciate, esca-
no . Negli altri tempi, cominciando in u,
è regolare ,
Verbi terminati in isco .
NOn hanno tali Verbi se non tre tem-
pi, e in questi non tutte le voci, man-
cando della prima, e della seconda persona del
plur. Per esempio nutrisco ha le seguenti voci.
Indicat. Presente. Sing. Io nutrisco, tu nutrisci,
egli nutrisce . Plur. Coloro nutriscono. Impe-
rati-
/ BEGIN PAGE 139 /
rativo . Presente. Nutrisci tu, nutrisca egli.
Plur. Nutriscano coloro . Ottativo . Futuro.
Sing. Ch’ io nutrisca, tu nutrischi, egli nutri-
sca. Plur. Coloro nutriscano.
In due classi si dividono questi Verbi. La
prima classe è di quelli, de’ quali si truova
altro Verbo equivalente della stessa voce,
che non termina in isco, come nutrisco ha
nutro ; offerisco offro ; profferisco proffero ; fe-
risco fero ; inghiottisco inghiotto, e così de-
gli altri . La seconda classe è di quelli, che
non hanno altro Verbo della stessa voce equi-
valente, come ambisco, gioisco, fiorisco, im-
pallidisco, e altri molti. La regola adunque
si è, che i Verbi della prima classe prendo-
no in prestanza le voci, delle quali manca-
no, da’ loro Verbi equivalenti ; onde si di-
ce , a cagion d’ esempio : nutriamo , offeria-
mo , ferite , inghiottite &c.; ma i Verbi del-
la seconda classe non hanno con che suppli-
re al lor mancamento, onde non si dice, per
esempio : ambiamo, fioriamo &c., ma convien
ricorrere ad altro Verbo equivalente di vo-
ce diversa, o esprimere con più parole il
sentimento.
Si noti, che tutti questi Verbi hanno l’ in-
finito in ire, come nutrire, fiorire , e il par-
ticipio passato in ito, come nutrito , fiorito,
e perciò appartengono a questa conjuga-
zione.
CAP.
/ BEGIN PAGE 140 /
CAP. XXXVII.
De’ Verbi difettivi.
HA la lingua Toscana molti Verbi difet-
tivi, cioè che non hanno tutte le vo-
ci. Ne addurremo alcuni, non già arrogan-
doci di determinare con aria decisiva, ch’ e’
non abbiano altre voci, che quelle, le qua-
li saranno da noi qui notate, ma producen-
do quelle voci, che da noi sono state osser-
vate negli Scrittori autorevoli, e che sono
dal miglior uso ricevute.
GIRE ha queste voci: gite, giva, o gia,
givi, giva, o gìa, givamo, givano , o gìa-
no, gj, gisti, gì, o gìo, gimmo, giste, girò,
girai, girà , giremo, girete, giranno , gissi,
gisse, gissimo , giste, gissero , girei , giresti,
girebbe, giremmo , gireste, girebbono. Ne’ pre-
teriti ha : io son gito, o gita &c. , nell’ infi-
nito gire, esser gito, e avere a gire. Le al-
tre voci si sogliono supplire co’ Verbi ire, e
andare, come si è veduto di sopra. In qual-
che antico si truova giamo, e gendo, ma non
vogliono adoperarsi. E‵ Verbo anzi poetico,
che no.
IRE ha queste voci : ite indicativo, e im-
perativo , iva , ivano, iremo, irete, ire, es-
sere ito. Fuorchè in queste voci, dicesi nel Vo-
cabo-
/ BEGIN PAGE 141 /
cabolario, non suole usarsi; e alla mancan-
za delle sue voci si supplisce col Verbo an-
dare. Notisi, che il participio ito è più in
uso fra’ Toscani, che andato, e ha più gra-
zia.
REDIRE Verbo antico, di cui oggi si usa-
no in verso le voci riedi, e riede, e di ra-
do redirono.
ARROGERE , benchè il Buommattei nol
voglia difettivo , tale contuttociò è giudica-
to dagli Accademici nel Vocabolario. La pri-
ma voce arrogo non la truovo usata. Il pre-
terito indeterminato dell’ Indicativo ha ar-
rosi . L’infinito arrogere e molto in uso ; e
così il gerundio arrogendo, ma il participio
presente non l’ ho potuto rinvenire, bensì il
passato nel seguente esempio Lib. mott. Co-
mandò, che gli fosse arroto un pane per dì.
Con questo participio formandosi i preteriti,
non sarebbe questo Verbo difettivo gran fat-
to , il che forse volle intendere il Buom-
mattei.
OLIRE, che val rendere odore, ha oliva,
olivi, olivano , e forse niun’ altra voce.
CALERE è Verbo difettivo, perchè è sem-
pre impersonale, e non ha altro , che le ter-
ze persone singulari . Fa cale , caleva, calse,
è caluto, calerà, o carrà, calesse, calereb-
be, o carrebbe.
CAGGERE Verbo antico, di cui son ri-
mase
/ BEGIN PAGE 142 /
mase alcune voci, che si usano da’ Poeti, e
talvolta ancora da’ Prosatori, e vale lo stes-
so , che cadere. Il Vocabolario adduce esem-
pj della voce caggia, e del gerundio cag-
gendo.
SOLERE ha queste voci . Presente dell’ In-
dicativo. Io soglio , tu suogli, oggi suoli ,
egli suole. Sogliamo, solete, sogliono. Prete-
rito imperfetto. Io soleva, o solea, tu sole-
vi, egli soleva, o solea. Solevamo, soleva-
te, solevano, o soleano . Futuro dell’ Ottati-
vo. Ch’ io soglia, tu suogli, o sogli, egli so-
glia. Che noi sogliamo, voi sogliate, essi so-
gliano.
CAP. XXXVIII.
De’ Verbi passivi, e degl’ impersonali.
LA lingua toscana non ha Verbo alcuno
di voce passiva, onde per dare a un Ver-
bo significazione passiva, s’ aggiugne al suo
participio passato il Verbo essere . Per esem-
pio, se vogliamo voltare in passivo questa
proposizione: io amo Pietro, non avendo noi
un Verbo, che colla sua sola voce signifi-
chi, come il Verbo amor de’ Latini, diciamo:
Pietro è amato da me ; e così conjugando il
Verbo sustantivo per tutti i tempi col detto
participio, in amendue i generi, venghiamo
a rile-
/ BEGIN PAGE 143 /
a rilevare la significazione del Verbo pas-
sivo .
Quanto a’ Verbi impersonali, quelli della
prima sorta, cioè gl’ impersonali di lor na-
tura, come tuona , nevica , piove &c. si con-
jugano per le terze persone singulari , cia-
scuno secondo la sua propria maniera ; on-
de si dice: tonava, nevicava, pioveva: to-
nò, nevicò, piovve: è tonato, nevicato, pio-
vuto &c. I mezzi impersonali, come appar-
tiene, conviene, disdice &c. si conjugano si-
milmente per le terze persone singulari, co-
me i sopraddetti ; ma talvolta vi si pone la
particella si, o spiccata innanzi, o affissa al
fine, per proprietà di linguaggio, e si di-
ce: si appartiene, si conviene , si disdice &c.,
ovvero appartiensi, conviensi &c. Gl’ imper-
sonali della terza sorta si conjugano come i
precedenti, e si aggiugne loro la particella
si, spiccata, o affissa, non già per puro ri-
pieno, ma con qualche senso passivo, dicen-
do per cagion d’ esempio: si dice, o dicesi ;
si ama, o amasi ; si corre, o corresi &c., e
questi corrispondono agl’ impersonali di voce
passiva de’ Latini : amatur, curritur &c.
CAP.
/ BEGIN PAGE 144 /
CAP. XXXIX.
Del participio.
IL participio è così detto, perchè parteci-
pa del nome, e del Verbo, in quanto
che essendo formato da un Verbo, e decli-
nandosi a guisa di nome , accenna con bre-
vità qualche significato del medesimo Verbo,
come amante, amato, amabile.
Tre generi ha il participio ; mascolino,
come amato, riverito, stupendo &c., femmi-
nino, come amata, riverita, stupenda &c.,
e comune, come amante, dolente, amabile &c.,
che possono ad amendue i generi addattarsi.
La declinazione del participio si fa come del
nome , per numeri , e casi, o coll’ articolo,
o col segnacaso.
Quanto alla significazione i participj sono
di tre sorte, attivi, passivi , e comuni. Atti-
vi sono quelli, che significano operazione,
come amante, vegnente &c., passivi quelli,
che accennano passione : come amabile, re-
verendo &c., comuni quelli, che possono ado-
perarsi e in attiva , e in passiva significazio-
ne , come trovato, sentito &c., perchè se,
per esempio dirò : Egli, trovato un cavallo,
andossene ; o: sentito il romore, s’ affacciò, la
significazione è attiva ; ma se dicessi : Egli,
trova-
/ BEGIN PAGE 145 /
trovato con quella persona, o sentito mentre
andava, fu preso, la significazione sarebbe
passiva .
Quanto al tempo, il Bembo, e ’l Buom-
mattei dicono concordemente , che i partici-
pj l’ hanno bensì, comecchè formati da Ver-
bo, ma non però proprio loro, o del loro Ver-
bo, ma quello del Verbo, che regge il sen-
timento . Così posso dire: Pietro è dolente,
fu dolente, sarà dolente : fu amato, è amato,
sarà amato ; dove uno stesso invariato parti-
cipio serve a tutti e tre i tempi, per cagion
del Verbo, che regge la sentenza . E‵ vero
contuttociò, che i participj amato, temuto,
e simili, perchè servono il più al tempo
passato, perciò si chiamano passati, o pre-
teriti . Ancora ci sono participj di lor natu-
ra ristretti al tempo avvenire, come futuro,
venturo &c., ma questi più Latini sono, che
Toscani.
Per ciò, che appartiene alla formazione
de’ participj, noi accenneremo, conjugazione
per conjugazione, tutto ciò, che stimeremo
opportuno a stabilir qualche regola, benchè
non sempre al medesimo modo, perchè la
materia nol sostiene, in cui, come in quel-
la de’ preteriti, s’ incontra molta varietà .
Nella prima conjugazione il participio si
forma dall’infinito, che termina in are, to-
gliendo via l’ ultima sillaba re, e surrogan-
dovi
/ BEGIN PAGE 146 /
dovi nte, to, ta, bile, ovvero ndo. Così da
amare si forma amante, amato, amata, ama-
bile : e da ammirare, e venerare i passivi
ammirando, venerando, e simili.
Nella seconda conjugazione i participj di
tempo indifferente si formano dall’ infinito
ere, levandone l’ ultima sillaba re, e sosti-
tuendovi nte, come godere, godente, sedere,
sedente &c.; ma ne’ participj preteriti, si tol-
gon via tutte e tre le lettere ere , e vi si
mette in vece uto, o uta , come godere, go-
duto, goduta ; temere, temuto, temuta &c. Si
eccettua il Verbo rimanere, il quale ha per
participio preterito rimaso, o rimasto.
Nella terza conjugazione s’ incontra mol-
ta varietà di participj, sicchè il Buommattei
non istabilisce regola alcuna , ma fa una li-
sta ben lunga delle varie terminazioni di ta-
li participj. Noi c’ingegneremo di prendere
qualche lume sopra ciò da’ preteriti indeter-
minati dell’ Indicativo, che a suo luogo ad-
ducemmo, colle seguenti brievi osservazioni.
Que’ Verbi, che nella prima voce escono
in go con g doppia , e nel preterito in ssi,
come leggo lessi, formano il loro participio
dal preterito, togliendo via ssi, e ponendo-
vi tto, come lessi letto, ressi retto, trassi trat-
to, afflissi afflitto, distrussi distrutto , e così
discorrendo.
I Verbi , ch’ escono nel preterito in si se-
guen-
/ BEGIN PAGE 147 /
guente a vocale formano il preterito col mu-
tare il si in so ; come rasi raso ; assisi assiso ;
divisi diviso ; risi riso ; uccisi ucciso; rosi ro-
so ; chiusi chiuso ; e così discorrendo . Si ec-
cettuano chiesi co’ suoi composti, che muta-
no il si in sto , e fanno chiesto ; e anche ri-
sposi, posi, e composti, che hanno risposto,
posto &c., e misi co’ suoi composti, ne’ quali
si muta la prima vocale in e, e si raddop-
pia la s, dicendo : messo &c.
I preteriti terminati in lsi formano il par-
ticipio, gettando via si, e surrogandovi to :
scelsi scelto ; divelsi divelto ; colsi colto ; sciolsi
sciolto ; tolsi tolto &c. Si eccettuano calse , e
valse , che hanno per participio caluto , e
valuto.
I preteriti terminati in nsi , dettrattone si,
e sostituendovi to, rendono il participio:
fransi franto ; piani pianto ; spensi spento ;
finsi finto ; dipinsi dipinto ; giunsi giunto ; punsi
punto, e così degli altri.
I preteriti terminati in rsi rendono il par-
ticipio surrogando al si, alcuni so, altri to.
De’ primi sono arsi arso ; sparsi sparso ; di-
spersi disperso ; morsi morso ; corsi corso &c.
De’ secondi sono sparsi sparto ; accorsi accor-
to ; scorsi scorto ; risursi risurto ; sursi surto,
e via discorrendo.
I Verbi, che hanno il preterito terminato
in ei, o in etti alla guisa della seconda con-
K 2 juga-
/ BEGIN PAGE 148 /
jugazione rendono il participio, togliendo
via la detta terminazione, e in vece metten-
dovi uto, o uta : perdei, perduto, perduta ;
ricevei, ricevuto, ricevuta, e così degli al-
tri.
Que’ Verbi poi , che adducemmo nelle os-
servazioni sopra la terza conjugazione, varj
nella loro prima voce, e nel preterito ter-
minati concordemente in ssi , rendono varia-
mente il participio , anche colla mutazione
della loro vocale. E perchè sopra ciò non
si può stabilire alcuna regola, meglio sarà
annoverare i più usitati. Alcuni escono in
etto, come detto, astretto &c.; altri in otto,
come addotto , condotto , ridotto , cotto, rot-
to &c.; altri in esso, isso, osso, ußo, come
concesso, permesso, infisso, crocefisso, mosso,
percosso, scusso, discusso &c. A questi si ag-
giunga il Verbo nascere, che ha per parti-
cipio nato, e il Verbo fare , trarre, e com-
posti, i quali si possono ridurre nell’ infinito
alla terza conjugazione, dicendo facere, trae-
re, e hanno per participio fatto, tratto &c., i
quali, siccome nato, sono portati dal Latino.
Nella quarta conjugazione i participj di
tempo indifferente si formano dall’infinito,
dettratte le ultime tre lettere ire, e postovi
in vece nte, ndo, o nda. Così da offerire
viene offerente , da languire languente &c., e
da riverire i passivi reverendo, e reverenda.
I par-
/ BEGIN PAGE 149 /
I participj preteriti si formano col detrarre
dalla voce dell’ infinito solamente re, e coll’
aggiugnervi to, e ta, e così da sentire vie-
ne sentito, e sentita. Si eccettuano compari-
re, che ha comparso , aprire aperto, concepi-
re conceputo, e concetto, morire morto, offeri-
re offerto, profferire profferto.
CAP. XL.
Del Gerundio.
GErundio, come presso a’ Latini, così an-
cora nella Lingua Toscana , altro non
è che una significazione del Verbo, la qua-
le non riceve gli accidenti del nome.
De’ tre gerundj de’ Latini , di, do, dum,
uno solo ne hanno i Toscani, cioè in do,
il quale ne’ Verbi della prima conjugazione
termina in ando, come amando, e in que’
delle altre in endo, come temendo, leggendo,
sentendo . A questi gerundj talvolta si mette
avanti la particella in, con dire in amando,
in temendo, in leggendo, in sentendo ; e allo-
ra sembra, che abbiano forza d’ infiniti, e che
voglian dire : nell’ amare , nel temere , nel
leggere , nel sentire.
A questa scarsezza di gerundj si supplisce
coll’ adoperare l’ infinito de’ Verbi , con al-
cune particelle , come in questi esempj. Bocc.
K 3 n. ult..
/ BEGIN PAGE 150 /
n. ult Metti in ordine quello, che da fare ci
è = Tempo parve alla Reina d’ andare a dor-
mire = Calandrino, veggendo che ’l Prete non
lasciava pagare, si diede in sul bere.
I gerundj non hanno il tempo proprio dal
loro Verbo, ma, come i participj, si rego-
lano col tempo del Verbo, che regge il sen-
timento.
CAP. XLI.
Della preposizione.
LA preposizione, di cui già demmo l’ idea,
quando trattammo delle parti della ora-
zione, si chiama così, perchè ordinariamen-
te si mette avanti a quella parte dell’ ora-
zione, sopra cui cade ; e nel fare la costru-
zione sempre si dee mettere avanti , perchè
induce varietà di caso, e di significazione
in tal parte , che non avrebbe , se non si
premettesse la preposizione . Così dicendo :
Vado a Roma, quella preposizione a fa che
Roma sia accusativo, e termine di moto, che
non sarebbe senza ciò. Ci sono però alcu-
ne preposizioni , le quali si mettono affisse
alla loro parte , come in meco, teco, seco ,
nosco , vosto .
Semplici possono essere le preposizioni,
o composte , e di queste altre sono sepa-
rabili, altre inseparabili. Separabili si dico-
no
/ BEGIN PAGE 151 /
no quelle, che si possono scrivere, e proffe-
rir da se stesse con qualche significazione : co-
sì, per esempio, nelle parole addosso, frat-
tanto ; a, e fra , si possono pronunziare, e
scrivere separatamente con senso di vere pre-
posizioni, dicendo : a dosso, fra tanto . Inse-
parabili sono quelle, che da se nulla signifi-
cano, benchè attaccate a una parte dell’ ora-
zione, ne varjno il significato: così , per ca-
gion d’ esempio , in disgrazia, misfatto, ri-
prendere, quelle particelle dis , mis , ri da
se stesse non vengono a dir nulla, e pure at-
taccate al principio delle dette parole, ne va-
riano più che molto la significazione . E simili
particelle talvolta significano contrario , co-
me in disgrazia, misfatto ; talvolta accresci-
mento, come in strafare ; talora diminuzio-
ne , come in sorridere ; o replicazione, come
in rifatto ; o pure ordine, come in antipor-
re o prosporre ; o finalmente negazione, co-
me in infelice , ingiusto , improprio .
Varj possono essere i significati delle pre-
posizioni, ma i più frequenti son quelli , che
sieguono.
STATO IN LUOGO. Accanto, allato,
presso, vicino, addosso, appiè, dentro , in,
nel, sopra, dirimpetto , a fronte, di sotto, e
simili.
MOTO DA LUOGO. Da, di, indi, fuo-
ri, e simili. E le preposizioni composte, co-
K 4 me
/ BEGIN PAGE 152 /
me da canto , da lato , di là, d’ in su, e sì
fatte.
MOTO PER LUOGO . Per, lungo, rasen-
te, su per &c. E si adoperano anche delle
preposizioni appartenenti a stato in luogo, o
a moto da luogo, come quando si dice : pas-
sai accanto al palagio, vicino alla chiesa , so-
pra le rovine , di là &c.
MOTO A LUOGO . A, ad, infino , ver-
so &c. E anche servono le preposizioni di
stato, e degli altri moti, come quando si di-
ce: andai vicino a Roma , sopra le rovine &c.
CAGIONE. A, con, da, di, mediante,
per &c.
MODO. Di nascoso del padre ; secondo sua
pari ; secondo donna ; secondo Uom di villa ;
secondo il costume di là ; cosa da ridere; qui-
stione da te ; e altre maniere di dire dinotan-
ti alcun modo.
TEMPO. Da, di, dietro, circa, dopo, fi-
no, sino, innanzi, infra, verso, vicino &c.
NUMERO . Circa, da, intorno, presso,
oltre, sopra, vicino &c.
PRIVAZIONE. Senza , fuori, lungi, da,
di &c.
COMPARAZIONE. Appetto , a paragone,
in comparazione , e simili.
ACCRESCIMENTO. Oltre a, più di,
assai più, molto più &c.
Molti altri sono i significati delle preposi-
zioni ;
/ BEGIN PAGE 153 /
zioni ; ma e di esse, e de’ loro significati si
tratterà più pienamente nel libro secondo.
Ma non si dee tralasciar qui la differenza,
che passa tra la preposizione, e il segnaca-
so , perchè ben si conosca la natura della
preposizione.
I segnacasi, come accennammo, sono ve-
ramente preposizioni, che si adoperano per
conoscere i casi de’ nomi , e de’ pronomi. Ora
due effetti fanno le preposizioni , come ab-
biamo detto , cioè dimostrare il caso del no-
me , o del pronome, e variarne , o, per dir
meglio, determinarne la significazione. Quan-
do la preposizione dimostra unicamente il ca-
so , e non varia la significazione, si chiama
segnacaso ; e ciò succede quando la prepo-
sizione si mette avanti un nome , o pronome,
il quale in Latino avrebbe il puro caso sen-
za preposizione, e a noi convien mettere il
segno perchè non abbiamo voci variate per
casi. Ma quando la preposizione , oltre al se-
gnare il caso , varia la significazione, allo,
ra si chiama più propriamente preposizione.
Così quando il Boccaccio dice : Parmeno fa-
migliare di Dioneo, quel di è segnacaso , per-
chè il Latino direbbe : servus Dionæi. E così
ancora quando dice : Se d’ altrui fosse stata piut-
tosto , che mia ; perchè in Latino si direbbe:
si alterius fuisset. Ma quando dice : Che noi
di questa terra uscissimo , e Maestri lavora-
te
/ BEGIN PAGE 154 /
te di forza, quel di è preposizione , perchè
significa nel primo esempio moto da luogo,
e nel secondo istrumento , o modo , e in La-
tino si direbbe : De hac regione exiremus :
operamini cum vi .
CAP. XLII.
Del Ripieno.
ALla preposizione si può in qualche modo
ridurre il ripieno , il quale consiste in
alcune particelle proprie della lingua Tosca-
na , le quali non sono assolutamente neces-
sarie alla tela gramaticale, che potrebbe sta-
re senz’esse ; ma pure sembra che aggiun-
gano all’orazione forza, grazia, ornamento,
o, se non altro, una certa nativa proprietà
di linguaggio.
Si possono i ripieni dividere in quattro
classi. La prima classe è di quelli , che ag-
giungono al parlare quell’ energia , la quale
da’ professori si chiama evidenza , in quanto
fa meglio sentire una cosa , e la mette , in
certo modo, sotto agli occhi . La seconda è
di quelli, che aggiungono ornamento al di-
scorso, e fiancheggiandolo , il rendono pie-
no, e robusto. La terza classe è degli accom-
pagnanomi, e la quarta degli accompagna-
verbi, che sono alcune particelle accompa-
gnate
/ BEGIN PAGE 155 /
gnate co’ nomi, e co’ Verbi , le quali trala-
sciar si potrebbono , ma lo usarle è proprio
della lingua nostra .
Particelle , che si adoperano
per evidenza.
ECCO . Questa particella si suole adopera-
re in principio di clausola, e dà forza al
parlare , mostrando talora prontezza all’ ope-
razione , ed affetto . Bocc. Ecco io non so ora
dir di no , per tal donna me n’ hai pregato =
Ecco, Giannotto , a te piace , ch’ io divenga
Cristiano, ed io son disposto a farlo. Talvolta
dinota irrisione. Bocc. Ecco bello innamorato:
or non ti conosci tu tristo ? non ti conosci tu do-
lente ?
BENE. Questa particella accresce forza
d’ espressione al discorso . Usasi in principio
di clausola avanti l’ interrogativo . Bocc. Be-
ne, Belcolore , demi tu far sempre morire a
questo modo ?
O in risposta affermativa. Bocc. g. 9. n.7.
E ancora da capo te ne consiglio, che tu oggi
ti stea in casa , o almeno ti guardi d’ andare
nel nostro bosco. La donna diße: bene, io il
farò.
E con aggiugnervi in principio la particel-
la sì. Bocc. Daratti egli il cuore di toccarla
con un brieve, ch’ io ti darò? Disse Calandrino ;
sì bene . E
/ BEGIN PAGE 156 /
E coll’ antiporgli la particella ora, o po-
sporgli la particella sta . Bocc. Or bene, co-
me faremo ? E g. 7. n. I. La donna disse al ma-
rito : bene sta, tu dì tue parole tu ; io per me
non mi terrò mai salva , nè sicura, se noi non
la ’ncantiamo.
Per entro il discorso bene si aggiugne a’ no-
mi , a’ pronomi, a’ Verbi, o avverbj. Bocc.
g. 7. n. 2. Egli ci sono de’ ben leggiadri, che
mi amano = Egli è qua un malvagio uomo,
che m’ ha tagliata la borsa con ben cento fio-
rini d’oro = Ma se vi piace, io ve ne inse-
gnerò bene una. E g. 4. n. 10. Voi sapete bene
il legnajuolo, dirimpetto al quale era l’ arca .
E g. 7. n. 3. Questi son vermini , ch’ egli ha in
corpo , i quali gli s’ appressano al cuore, e uc-
ciderebbonlo troppo bene, ma non abbiate pau-
ra, ch’ io gl’ incanterò, e farogli morir tutti.
BELLO si adopera addiettivamente come ri-
pieno di forza . Bocc. g. 2. n. 9. Per belle scrit-
te di lor mano s’ obbligarono l’ uno all’ altro. E
g. 8. n. 10. Le portò cinquecento be’ fiorin d’oro.
E ivi n. 3. Chi facesse le macini bell’ e fatte
legare in anella, e portaßele al Soldano, n’ a-
vrebbe ciò , che volesse.
PURE aggiugne evidenza, ed equivale al
quidem, e al sanè de’ Latini. Bocc. g. 5. n. 10.
Fa pure , che tu mi mostri qual ti piace, e
lascia poi fare a me = La cosa andò pur così =
Ella n’ è divenuta femmina di Mondo , pur per
ciò.
Pre-
/ BEGIN PAGE 157 /
Preposta questa particella ad avverbio di
tempo aggiugne forza , e vale appunto . Bocc.
g. 5. n. 2. La quale ( perciocchè pure allora
smontati n’ erano i signori di quella ) d’ albero,
e di remi la trovò fornita.
GIA’ ha forza talora del quidem sanè de’
Latini . Bocc. Ora fossero essi pur già disposti
a venire . E g. 10. n. 5. Il Nigromante disse :
già Dio non voglia, poichè io ho veduto Gil-
berto liberale del suo onore , e voi del vostro
amore , ch’ io similmente non sia liberale del
mio guiderdone. Passav. pag. 200. Non si tie-
ne polvere, e cenere colui , che si veste di drap-
pi di seta, e di scarlatto : che chi farebbe co-
tali sacca alla cenere, se non fosse già matto?
Si pospone al non per un certo raddolci-
mento di pronunzia. Bocc. Le quali , non già
da alcuno proponimento tirate , ma per caso in
una delle parti della chiesa adunatesi, comin-
ciarono a ragionare.
Gli si affigge la particella mai, e allora va-
le l’ unquam de’ Latini. Bocc. A Chiesa non
usava giammai.
MAI posposto, o preposto al sempre, gli
dà forza. Bocc. Se voi mi prestate cinque li-
re , io sempre mai poscia farò ciò, che voi
vorrete. Petrar. Una parte del Mondo è, che si
giace Mai sempre in ghiaccio , ed in gelate
nevi.
Gli si affigge il sì, o il no, il che si usa
nel
/ BEGIN PAGE 158 /
nel rispondere ad alcuna interrogazione, e
aggiugne forza. Bocc. g. 3. n. 8. Come, disse
Ferondo , dunque sono io morto ? Disse il Mo-
naco : maisì . Passav. pag.67. Cominciò a pen-
sare, se i dannati dello ’nferno dovessono do-
po mille anni essere liberati : e rispose al pen-
sier suo di no . Appresso gli dicea il pensiere :
o dopo centomilia anni? e rispondea, che mai-
nò. Poi pensò, se dopo mille migliaja d’ anni
fosse possibile la loro diliberazione, e diceva
di no. Or dopo tante migliaja d’ anni , quante
gocciole hae nel mare d’ acqua , potrebbe esse-
re , che n’ uscissono ? E rispuose a se medesi-
mo , che ma ’no.
Talvolta , sciolto l’ affisso , vi si intramet-
te altra parola . Bocc. Mai Messer sì, rispo-
se Ser Ciappelletto, ch’ io ho detto male d’ al-
trui .
MICA , e PUNTO aggiungono efficacia
alla negazione . Bocc. Una ne dirò, non mi-
ca d’uomo di poco affare = Madonna, Tedaldo
non è punto morto , ma è vivo , e sano.
TUTTO aggiugne energia . Bocc. Il fami-
glio trovò la gentil giovane tutta timida star
nascosa = Tutto rassicurato estimò, il suo av-
viso dovere avere effetto = La donna udendo
costui parlare , il quale ella teneva mutolo,
tutta stordì = Senz’ aspettare d’ essere solleci-
tata da’ suoi, così tutta vaga cominciò a par-
lare = Dimorando il giovane tutto solo nella
corte
/ BEGIN PAGE 159 /
corte del suo palagio, una femminella gli do-
mandò limosina = Tutto a piè fattosi loro in-
contro , ridendo disse = Il letto, con tutto Mes-
ser Torello , fu tolto via.
VIA congiunto co’ Verbi accresce loro for-
za , o ne varia in qualche parte il significa-
to. Bocc. Via a casa del Prete nel portarono =
E così questa seccaggine tor via = Se spacciar
volle le cose sue, gliele convenne gittar via.
Particelle , che si adoperano
per ornamento .
EGLI si adopera per ornamento, e pienez-
za di stile , sempre invariato , senza ri-
guardo a genere, nè a numero, e in princi-
pio, e per entro, e nel fine della clausola .
Bocc. Egli è il vero , ch’ io ho amato, ed amo
Guiscardo = Egli non sono ancora molti anni
passati, che in Firenze fu una giovane = A me
par egli esser certo , ch’ egli è ora a casa a
desinare. E g. 5. n. 4. O figliuola mia , che
caldo fa egli ?
ESSO si adopera indeclinabile in amendue
i generi, e numeri , dopo la particella con,
avanti alcuni pronomi , e anche senza i pro-
nomi. Bocc. g. 3. n. 4. Ella voleva con esso
lui digiunare = Ritrovandosi colla donna, mol-
to di questa incantazione rise con esso lei. E
g. 7. in princ. Cominciarono a cantare , e la
valle
/ BEGIN PAGE 160 /
valle insieme con esso loro. E g. 8. n. 8. Fat-
ti alla finestra, e chiamala, e dì, che venga
a desinare con esso noi = E Madama Fiorda-
liso disse ad Andreuccio : Di vero tu cenerai
con esso meco = Non ti dare malinconia, fi-
gliuola , no, ch’ egli servirà bene con esso te-
co Domeneddio. Gio. Vill. La disavventura era
tanta, e con esso la discordia de’ Fiorentini,
che non l’ ardirono a soccorrere .
ORA si adopera per ripigliare, o conti-
nuare il discorso. Bocc. Come non sapete voi
quello, che questo voglia dire? Ora io ve l’ ho
udito dire mille volte : chi la sera non cena,
tutta notte si dimena = Ora le parole furono
aßai , ed il rammaricchio della donna grande .
Talvolta pare che esprima desiderio Bocc.
g. 8. n. 9. Deh or t’ avessono essi affogato, come
essi ti gittaron là , dove tu eri degno d’ esser
gittato.
Talora imprime nell’ interrogazione un non
so che di energia. Bocc. g. 7. n. 8. Monna Si-
smonda disse : chi è là ? Alla quale l’ un de’
frategli rispose : tu ’l saprai bene , rea fem-
mina, chi è. Disse allora Monna Sismonda : ora
che vorrà dir questo ? Domine ajutaci.
SI‵ adoperasi per ornamento, e ha un non
so che di grazia toscana . Bocc. Oltre a quel-
lo , ch’ egli fu ottimo filosofo naturale , sì fu
egli leggiadrissimo , e costumato = Se ti piace,
sì ti piaccia, se non, sì te ne sta = Conforta-
ti,
/ BEGIN PAGE 161 /
ti, che fermamente, se tu fossi stato un di que-
gli, che il puosero in croce, avendo la contri-
zione , ch’ io ti veggio , sì ti perdonerebbe egli =
La prima cosa , ch’ io farò domattina, io andrò
per esso, e sì il ti recherò .
DI si adopera per una certa maniera affat-
to propria della nostra lingua. Bocc. g. 5. n. 3.
Per queste contrade , e di dì , e di notte , e
d’amici , e di nemici vanno di male brigate
assai , le quali molte volte ne fanno di gran
dispiaceri, e di gran danni.
NON si pone talora dove nulla opera , per
proprietà non solamente della lingua Tosca-
na, ma di quasi tutti i dialetti d’ Italia, e
ciò dee notarsi da’ forestieri. Bocc. g. 2. n.6.
Diragli da mia parte, che si guardi di non
aver troppo creduto, o di non credere alle
favole di Giannotto. E g. 7. n. 9. Io temo for-
te, che Lidia con consiglio , e voler di lui que-
sto non faccia per dovermi tentare. E g. 4. n.
8. Questo nostro fanciullo , il quale appena an-
cora non ha quattordici anni.
ALTRIMENTI si usa talvolta per pura pro-
prietà di lingua . Bocc. g. 2. n. 5. Le sue co-
se, e se parimente, senza sapere altrimenti
chi egli si fosse, rimise nelle sue mani.
L Accom-
/ BEGIN PAGE 162 /
Accompagnanomi.
Usa la lingua Toscana di mettere avanti
i nomi, e i pronomi le voci uno, e
una, non già come nomi numerali, ma per una
certa accompagnatura propria sua, che non
ebbero la lingua Greca, nè la Latina, e per-
ciò si chiamano accompagnanomi. Bocc. Io
credo, che gran noja sia ad una bella, e di-
licata donna, come voi siete , aver per marito
un mentecatto = Era Arriguccio , contuttochè
fosse mercatante, un fiero uomo, ed un forte .
Talvolta vale il quidam de’ Latini . Bocc.
Un dì nella camera chiamatala , interamente
come il fatto stava le dimostrarono = Gli ven-
ne a memoria un Ser Ciapperello da Prato .
Talora è accompagnanome numerale, e
vale il circiter de’ Latini. Bocc. Senza che
quando non vogliamo un mille, o un dumilia
fiorini da loro, noi non gli abbiamo prestamente.
In vece di uno accompagnanome si usa ta-
lora alcuno . Vit. Crist. Che gli menassero l’asi-
na, e ’l poltruccio , ch’erano legati in alcun
luogo in pubblico . Mirac. M. Alcuna donna li-
sciava la faccia sua di varj colori.
A uno si aggiugne qualche volta certo, ed
esprime il quidam de’ Latini. Stor. Eur. Più
per un certo che di riputazione, che perchè
e’ ne sperasse, o temesse molto. E si tralascia
talora
/ BEGIN PAGE 163 /
talora l’ uno. Bocc. Nascevano nell’ anguina-
ja, o sotto le ditella certe enfiature .
Si aggiugne uno a’ pronomi questo, e quel-
lo , per accennare con maggior evidenza , e
precisione . Bocc. Fiamm. l. 4. n. 32. Desti tu
a tutte , o a questa una quella fede , che a
me donasti ? E l. 7. n. 59. Se i miei argomen-
ti frivoli già tenete , questo uno solo , ed ul-
timo a tutti gli altri dia supplimento . Petrar.
canz. 41. Quell’ uno è rotto, e ’n libertà non
godo . E son. 201. E caramente accolse a se
quell’ una.
Tutt’ uno vale l’ idem de’ Latini. Dante con-
viv. f. 93. Cortesia, e onestade è tutt uno .
Accompagnaverbi.
COsì chiamansi alcune particelle, che si
accompagnano co’ Verbi, o ad essi si
affiggono , senza necessità , ma per sola pro-
prietà di linguaggio, e sono mi, e ci per
le prime persone, ti, e vi per le seconde ,
si per le terze, e ne, che da se sola, e con
le altre suddette particelle si mette avanti i
Verbi, o loro si affigge .
MI. Bocc. Io mi credo , che le Suore sien
tutte a dormire = Perduta ho la fatica, la
quale ottimamente mi parea avere impiegata,
credendomi costui aver convertito.
Le si aggiugne la particella ne, ma allora
L 2 si di-
/ BEGIN PAGE 164 /
si dice me, non mi . Bocc. Non vi volli star
più , e sommene venuto ; anzi mi pregò il Ca-
staldo loro, quand’ io me ne venni , che se io
n’ avessi alcuno alle mani , ch’ io gliele man-
dessi .
CI . Bocc. La donna, e Pirro dicevano :
noi ci seggiamo . Coll’ articolo pronominale
fa ce. Bocc. E poscia cel godremo qui col Do-
mine . E similmente colla particella ne. Bocc.
Io giudicherei ottimamente fatto , che noi a’ no-
stri luoghi in contado ce ne andassimo a sta-
re . E g. 9. n. 4. Vogliancene noi andare an-
cora ?
TI. Bocc. Che tu con noi ti rimanga per
questa sera, n’ è caro = Io vi ti porrò cheta-
mente una coltricetta, e dormiraviti. Avanti
il pronome relativo si dice te, ma dopo di
esso negli affissi si dice ti . Bocc. Tu te la
griferai = E poscia manicarlati tutta quanta.
Col ne si dice te . Bocc. Tu te ne se’ così to-
sto tornata in casa ? E g. 2. n. 10. Vientene
meco.
VI. Bocc. Io non so se voi vi conosceste Ta-
lano di Molese . Col ne si dice ve . Bocc. Voi
ve ne potrete scendere al luogo, dove i vo-
stri panni avrete lasciati, e rivestirvi, e tor-
narvene a casa.
SI. Bocc. Del palagio s’ uscì, e fuggissi a
casa sua. E così dopo il pronome relativo,
e le particelle suddette . Bocc. Noi ti fare-
mo
/ BEGIN PAGE 165 /
mo quella risposta , che ti si conviene = Essi il
corpo di colui non vogliono per doverlosi te-
nere in braccio.
Ma avanti il pronome relativo , e col ne
fa se. Bocc. Comperati i capponi, insieme col
medico, e co’ compagni suoi, se gli mangiò . Fi-
renzuola. Fece vista di bersela. Bocc. I tre
giovani alle lor camere , da quelle delle don-
ne separate, se n’ andarono = A Nostra Dama
di Parigi con lui insieme andatosene, richie-
se i cherici di là entro , che ad Abraam do-
vessero dare il battesimo.
NE. Bocc. g. 2. n. 7. Chetamente n’ andò
per la camera infino alla finestra = E n.5. An-
dianne là, e laverenlo spacciatamente.
CAP. XLIII.
Dell’ Avverbio .
L’Avverbio opera col Verbo ciò, che l’ad-
diettivo opera col sustantivo , cioè spie-
ga , e fa conoscere gli accidenti, e le cir-
costanze dell’ azione del Verbo.
Degli avverbj altri sono primitivi, come
forte , subito &c., altri derivati , come forte-
mente, subitamente &c., altri semplici, come
appresso, più, meno &c. , altri composti , co-
me in disparte , poco appresso, rade volte &c.,
altri proprj , che hanno voce , e desinenza
L 3 av-
/ BEGIN PAGE 166 /
avverbiale, come fortemente &c., altri, che
non hanno voce, e desinenza di avverbio,
ma ne hanno la significazione , benchè sie-
no anche nomi, come di buona voglia , da
galantuomo &c., e di questi modi avverbiali
spiegantissimi è sopra modo abbondevole la
lingua toscana .
Parimente negli avverbj ci sono i positivi,
i comparativi, e i superlativi. Bene, meglio,
ottimamente: male, peggio, pessimamente hanno le
voci proprie. Gli altri, non avendo voce pro-
pria, formano il comparativo con aggiugne-
re più, come più forte, e il superlativo coll’
aggiugnere issimamente , come fortissimamen-
te . Ci sono anche de’ diminutivi, che si usa-
no avverbialmente coll’ accompagnanome, co-
me pochetto, e pocolino. Bocc. g. 8. nel fin. Emi-
lia un pochetto si vergognò. E g. 4. n. 10. Rivol-
ta a lui, un cotal pocolin sorridendo disse.
E ancora ben bene, che vale interamente. Bocc.
g. 7. nel princ. Nè ancora spuntavano i raggi
del Sole ben bene .
Molti sono gli avverbj, e più che molti i
modi avverbiali della lingua toscana, nè sa-
rebbe senza noja l’ annoverargli qui tutti .
Contuttociò addurremo i più usitati , riducen-
doli sotto i capi delle più frequenti signifi-
cazioni degli avverbj.
TEMPO . Ora , adesso, jeri, domani , og-
gi, oggidì , oggimai , oramai, omai, dianzi,
ap-
/ BEGIN PAGE 167 /
appresso, prima, di poi, un pezzo fa, ratto,
subito, talora, talvolta, alcuna volta, e presso
a’ moderni alle volte , presto , ratto, adagio ,
a bell’ agio, quando , continuamente , infino &c.
LUOGO. Qui , quivi , ivi, là, colà , co-
lassù, colaggiù, costì , costà, qua, quassù ,
quaggiù, quinci, quindi, indi, onde &c.
QUALITA‵ . Dottamente , avvedutamente ,
piacevolmente , parcamente , diligentemente , in
pruova, a bello studio , alla dimestica, da ga-
lantuomo, e altri senza fine.
QUANTITA‵. Aßai , molto, più, troppo ,
meno , abbastanza &c.
AFFERMAZIONE, E NEGAZIONE. Sì,
sì bene , volentieri &c. No , non, non già , non
mai , per nulla &c.
CONCESSIONE. Volentieri, di buona vo-
Glia , a tua posta &c.
ORDINE. A vicenda, gradatamente, suc-
cessivamente, l’ un dopo l’ altro, primieramen-
te , finalmente , ultimamente , quindi , dipoi ,
al tutto &c.
ELEZIONE . Anzi , meglio , piuttosto , più
Presto , più &c.
ESORTAZIONE . Orsù, alto, su via, o
bene , di grazia &c.
FORTUNA. Per buona ventura, per tri-
sta sorte &c.
Talvolta si può confonder l’ avverbio col-
la preposizione, come nelle voci appresso,
L 4 avan-
/ BEGIN PAGE 168 /
avanti , allato, e simili , che possono essere
l’ uno, e l’ altro. La regola si è, che quan-
do queste particelle hanno caso, sono pre-
posizioni , e quando no, sono avverbj . Ec-
cone un’esempio . Bocc. g. 2. n. 5. Or via met-
titi avanti , io ti verrò appreßo . Quivi ap-
presso è preposizione, perchè congiunta col
ti, ha caso. Bocce. g. 2. n. 6. Dalla madre del-
la giovane prima , e appreßo da Currado so-
prappresi furono Quivi appresso è avverbio,
perchè non dipende da caso , ma cade in sul
Verbo.
Ancora può scambiarsi l’ avverbio col no-
me addiettivo , come in poco , molto, forte ,
presto, tosto, e simili. La regola è, che ta-
li voci di per se sono avverbj, e accompa-
gnate col nome sustantivo sono addiettivi .
Ecco uno esempio. Dante. S’ i’ meritai di voi
assai , o poco , Quando nel Mondo gli alti versi
scrissi . Quivi poco è avverbio, perchè non
s’ appoggia a sustantivo, ma cade sul Ver-
bo. Bocc. n. I. Segno manifesto di poco sen-
no. E g. 8. n. 9. E per poco, se tu mi dicessi ,
che io andassi di qui a Peretola, io credo,
ch’ io v’ andrei. In questi due esempj poco è
nome , perchè nel primo s’ appoggia al su-
stantivo senno , e nel secondo sta a maniera
di sustantivo, e vi si sottintende cosa.
Parimente può nascer dubbio, se una vo-
ce sia avverbio, interjezione, o ripieno , co-
me
/ BEGIN PAGE 169 /
me può avvenire nella voce bene, la quale
può fare tutte e tre queste figure, come si
vede in questi esempj. Bocc. Vennegli sì ben
fatto, che avanti l’ora di mangiare pervenne
là. Quivi bene è avverbio , perchè cade sul
participio. Bocc. g. 5. n. 3. Vide in sul primo
sonno venire ben venti lupi. Quivi bene è ri-
pieno d’ evidenza, che aggiugne asseveran-
za. Firenz. Trinuz. Orsù dunque la mia Pu-
rella, dì su, alto , bene, escine. Quivi bene è
interjezione , ce vale l’ eja de’ Latini.
Può ancora talvolta l’ avverbio equivocare
colla congiunzione, come nella voce poi.
Bocc. Pregollo, che poi verso Toscana anda-
va, gli piacesse d’ essere in sua compagnia.
Quivi poi è congiunzione dinotante cagione ,
e vale quoniam. Bocc. n. I. Che noi l’ avessi-
mo ricevuto prima, e poi fatto servire. Qui-
vi poi è avverbio di tempo, e vale postea.
CAP. XLIV.
Della interjezione .
MOlte sono le interjezioni , ch’ esprimo-
no gli affetti dell’animo, ma le più
usate sono le seguenti.
ALLEGREZZA . Oh, viva, bene, buono.
DOLORE. Ah, ahi, aimè, oimè.
IRA. Doh, oh, guarda, puh, via via.
/ BEGIN PAGE 170 /
TIMORE. Oh Dio , oimè, sta, oh .
VOGLIA . Deh, pure, oh se, purchè, dì
grazia , così.
MARAVIGLIA. Oh, o, come può esser que-
sto ?
DISPREZZO . Oh , deh, puh , andate an-
date, oibò.
APPROVAZIONE . Sì, così, bene, buono,
bene sta, mi piace.
NEGAZIONE. No, non, non già, appunto,
Dio mi guardi, guarda, pensate, come ?
DI PREGARE. Deh, mercè, non più.
DI GRIDARE. Eja, olà, piano, oh oh.
DI DARE IN SULLA VOCE . Zi, zit-
to, sta, piano, cheto.
CAP. XLV.
Della Congiunzione.
DI varie sorte, e molte sono le congiun-
zioni, le quali si adoperano, e nel prin-
cipio, e per entro il periodo. Le principali
sono le seguenti .
DI CAGIONE. Perchè, imperciocchè, con-
ciossiacosachè , acciocchè, affine, a cagione,
per, poscia che.
SOSPENSIVE. Se, purchè, si veramente
che , ogni volta che, ancorchè, dato che, con
questo però, se mai.
NE-
/ BEGIN PAGE 171 /
NEGATIVE. No , non , non già , anzi ,
niuno, né .
ECCETTUATIVE. Fuori, in fuori, fuor-
chè, in poi, se non, eccetto, eccettuato .
DICHIARATIVE . Cioè , ben sai, ben sa-
pete.
COPULATIVE. E, ancora , anche , simil-
mente , eziandio, altresì.
AGGIUNTIVE . In oltre, oltrecchè , ol-
tracciò , appresso , ancora , altresì, di più .
DISGIUNTIVE. O, ovvero, se, nè.
AVVERSATIVE . Pure, nondimeno , non
per tanto, benchè , ancorchè, comecchè , quan-
tunque , perchè, se non, per questo.
ELETTIVE. Anzi , innanzi, prima , piut-
tosto, meglio , più che , più volentieri , anzi
che no .
DIMINUTIVE. Pure, almeno, solamente,
solo , non che , tanto, non meno .
CONCHIUSIVE . Dunque, adunque , per-
tanto, perciò , per la qual cosa, onde , laon-
de, tantochè , in somma .
Talora si può dubitare , se una particella
sia avverbio , pronome, preposizione , o con-
giunzione, e ciò da questi esempj si mostre-
rà. Boccacc. g. 6. n. 9. Cominciarono a di-
re , che quello , ch’ egli aveva risposto , non
veniva a dir nulla . Quivi il primo che è
congiunzione , perchè unisce , e il secondo
è pronome relativo . Boccacc. Iddio mi ha
fatta
/ BEGIN PAGE 172 /
fatta tanta grazia, che io anzi la mia mor-
te ho veduto alcuno de’ miei fratelli . Quivi
anzi è preposizione, perchè ha caso . Boc-
caccio. Attempatetta era, e anzi superba,
che no . Quivi anzi è avverbio , perchè mo-
difica il Verbo. Boccacc. g. 3. n. I. Io era
ben così , ma non per natura , anzi per una
infermità. In questo esempio anzi è congiun-
zione , perchè precisamente unisce.
Fine del primo Libro.
RE-
/ BEGIN PAGE 173 /
REGOLE
ED OSSERVAZIONI
Della Lingua Toscana .
LIBRO SECONDO
Della Costruzione toscana.
CAP. I.
Idea generale della costruzione toscana.
LA costruzione , con Greco vocabolo chia-
mata sintassi , è quella conveniente dispo-
sizione , la quale debbono avere fra se le par-
ti dell’ orazione .
Di due sorte può essere la costruzione,
semplice , e figurata . La costruzion sempli-
ce, o sia regolare , è quella , che siegue l’or-
dine naturale, e le regole della Gramatica,
com’è questa del Boccaccio g. 4. n. I. Io ho
amato , e amo Guiscardo. La figurata è quel-
la, che si allontana dall’ordine naturale , e
dalle comuni regole della Gramatica , e per-
ciò chiamasi ancora irregolare ; com’ è que-
sta dello stesso Boccaccio g. 7. n. 6. Sempre
non
/ BEGIN PAGE 174 /
non può l’ uomo un cibo , ma disidera di va-
riare. Della figurata costruzione parleremo
al suo luogo ; ora tratteremo della sempli-
ce , e regolare .
Tre cose voglion considerarsi nella sempli-
ce costruzione , cioè l’ ordinata collocazione
delle parti ; la dipendenza di una parte dall’
altra : e la concordanza di una parte coll’al-
tra . Spiegheremo partitamente queste tre co-
se , e con ciò verremo a dare l’ idea gene-
rale della toscana costruzione .
Ordinata collocazione delle parti
dell’ orazione.
LE parti dell’orazione nella semplice co-
struzione si debbono collocare ciascuna
nel suo luogo, secondo la loro natura, e le
regole della Gramatica . Sopra ciò si notino
le seguenti regole.
Regola prima.
Nel primo luogo si mette sempre il no-
minativo , a cui si attribuisce l’azione del
Verbo ; ed è ordinariamente un nome, un
pronome, o un’ infinito usato in forza di no-
me, come Pietro legge ; il maestro insegna ;
io scrivo ; il dormire giova.
Regola seconda .
Quando l’azione del Verbo si attribuisce a
più persone, o cose, queste appartengono
tutte
/ BEGIN PAGE 175 /
tutte al nominativo, e si mettono in primo
luogo , unite colla loro congiunzione, come
Pietro, e Paolo leggono : i fiori, e l’ erbe lan-
guiscono.
Regola terza.
Al nominativo parimente appartengono gli
addiettivi aderenti al sustantivo , di cui è
l’ azione del Verbo, e perciò si pongono do-
po di esso innanzi al Verbo ; come gli sco-
lari morigerati, e diligenti studiano . E lo stesso
dee dirsi di qualunque proposizione inciden-
te , la quale per mezzo del relativo sia uni-
ta al nominativo , come Pietro , il quale voi
molto ben conoscete , è morto.
Regola quarta.
Se il nominativo ha l’articolo, questo si
mette sempre avanti, che ivi è la sua natu-
ral sede : onde que’ tramezzi fra ’l nome, e
l’ articolo, che si leggono sì spesso nel Boc-
caccio, come : il male amato giovane ; nella
materiale, e grossa mente, e simili , sono iper-
bati , e non appartengono alla semplice co-
struzione.
Regola quinta.
Talvolta fa le parti di nominativo un Ver-
bo col suo caso. Bocc. Umana cosa è avere
compassione degli afflitti : e talora anche una
intera proposizione . Bocc. g. 5. n. 3. Che tu
con noi ti rimanga per questa sera , n’ è caro.
Rego-
/ BEGIN PAGE 176 /
Regola sesta.
Il nominativo talora si sottintende . Ciò
può accadere primieramente in virtù del Ver-
bo , il quale contiene i pronomi primitivi ,
onde a dire amo, vi s’ intende il pronome io,
ch’ è il nominativo, e così del resto ; benchè
il Boccaccio le più volte esprima tali pro-
nomi , per rendere più pieno lo stile. Acca-
de ancora , che il nominativo si debba sup-
plire dal contesto , per non ripetere tante
volte un nome.
Regola settima.
Dopo il nominativo si pone il Verbo. Se
il Verbo ha l’ accompagnatura di particella
sua propria , questa gli si mette avanti , per-
chè l’ affisso non è della semplice, ma del-
la figurata costruzione . Se ci è avverbio, si
dee porre immediatamente dopo il Verbo,
di cui spiega gli accidenti, e le circostan-
ze , come Pietro ama ardentemente la glo-
ria.
Regola ottava.
Il gerundio, essendo significazione del Ver-
bo, si mette nella sua clausola al luogo del
Verbo, benchè il senso perfetto della sen-
tenza, e anche il tempo del gerundio da al-
tro Verbo dipenda. E se il nominativo del
gerundio è lo stesso con quello del Verbo
principale, si mette avanti al gerundio, ma
se è diverso , gli si mette dopo. Eccone gli
esem-
/ BEGIN PAGE 177 /
esempj del Boccaccio. g. 8. n. 6. Calandrino,
veggendo , che il Prete non lasciava pagare ,
si diede in sul bere. E g. 3. n. 5. Prese nuo-
vo consiglio, e cominciò in forma della donna,
udendolo ella, a rispondere a se medesimo.
Regola nona.
Dopo il Verbo , e ’l suo corredo, si pon-
gono i suoi casi , che possono essere uno , o
più , secondo la natura dell’ azione, come: io
amo Pietro : io dono un libro a Paolo. Quali
casi abbia , o possa avere ciascun Verbo , si
potrà conoscere dalle regole, e appendici,
che si daranno intorno alla particolare, e al-
la comune costruzione de’ Verbi. Intanto si
avverta , che il caso del Verbo , come dicem-
mo del nominativo , può avere più voci uni-
te con copula, o qualche proposizione inci-
dente , o un Verbo col suo caso , o una pro-
posizione intera , e queste cose similmente,
e col suddetto ordine, appartengono al caso
del Verbo. Gli esempj possono esser questi :
Io amo Pietro, e Paolo, e Giovanni . Tu curi po-
co , sia detto con tua pace, il tuo onore . Pie-
tro ama di bere il cioccolatte. Il maestro proc-
cura , che gli scolari sappiano le buone re-
gole della Gramatica .
Regola decima.
Se il caso del Verbo ha segnacaso, que-
sto si mette sempre immediatamente avanti il
suo caso . Chi adunque dicesse : di bella, e
M gen-
/ BEGIN PAGE 178 /
gentil forma: a grande , e molto crudel fuo-
co &c., sarebbono iperbati .
Regola undicesima .
Quando il caso del Verbo consiste in uno
infinito co’ suoi casi ; se l’ infinito ha l’ accu-
sativo , gli si mette avanti , e se ha il no-
minativo , gli si mette dopo. Bocc. g. 9.n. 4.
A Siena se ne tornò, per tutto dicendo , se il
palafreno, e i panni aver vinto all’ Angiulie-
ri . E g. 5. n. 9. Seco dispose di non mandare,
ma d’ andare ella medesima per esso.
Regola dodicesima .
In vece dell’ infinito fa talvolta il gerun-
dio le parti di caso del Verbo, ma ha for-
za d’ infinito . Bocc. g. 4. n. 4. Al Re Guigliel-
mo mandò significando ciò, che fare intende-
va . Cioè: mandò a significare.
Regola tredicesima.
Il participio presente , come amante &c.,
comecchè nome , può appartenere al nomi-
nativo , o al caso del Verbo . Talvolta pare
ablativo assoluto , e ha forza di gerundio , e
si premette alla clausola, col suo caso avan-
ti , o dopo. Bocc. g. 2. n. 8. Avvenne, duran-
te la guerra, che la Reina infermò grave-
mente . Più frequentemente si adopera assolu-
to il participio preterito. Bocc. g. 2. n. 8. Nè
prima nella camera entrò, che il battimento
del polso ritornò al giovane , e, lei partita,
cessò.
Re-
/ BEGIN PAGE 179 /
Regola decimaquarta .
La preposizione va sempre avanti al suo
caso, come vicino a casa. Il relativo sempre
si pone dopo l’antecedente , come : Pietro,
il quale studia . La congiunzione si dee met-
tere fra quelle parti , ch’ ella unisce, come
Pietro, e Paolo : Alessandro , benchè sia pove-
ro , fa limosina . Ma l’ interjezione non ha
luogo fisso, perchè non ha relazione intrin-
seca alle altre parti : si suole contuttociò por-
re al principio della clausola . Bocc. g. 3. n 8.
Oh mangiano i morti? E g. 5. n. 5. Ahi tra-
ditori voi siete morti. E g. 3. n. I. Oimè, che
è quello, che tu dì ?
Dipendenza delle parti dell’ orazione ,
l’ una dall’ altra.
Regola prima .
IL nominativo è la base , e il fondamento
del discorso , e da lui dipende il Verbo,
siccome dal Verbo dipendono gli altri casi .
L’addiettivo dipende dal sustantivo, a cui si
appoggia , e l’ avverbio dal Verbo , di cui
spiega gli accidenti .
Regola seconda .
Il genitivo dipende da un sustantivo espres-
so, tacito, o equivalente, che lo regga.
Regola terza .
L’ accusativo dipende, o da un Verbo at-
M 2 tivo,
/ BEGIN PAGE 180 /
tivo, di cui sia caso paziente, come io amo
la virtù: o da un’infinito, come : disse , se
avere in ciò errato : o da una preposizione ,
come : vado verso la chiesa .
Regola quarta.
L’ ablativo dipende da una preposizione ,
che lo regga, come : parto da Roma : esco
di casa.
Regola quinta .
Il dativo, e il vocativo non hanno rigo-
rosamente dipendenza dalle altre parti . Il
dativo è caso di relazione, ed è comune a
quasi tutti i nomi, e Verbi. Il vocativo non
accenna altro che la persona, con cui altri
parla.
Concordanza delle parti dell’ orazione
fra se .
Regola prima.
GLi addiettivi concordano co’ loro sustan-
tivi in genere, numero, e caso, come
uomo virtuoso ; tutta la casa ; Iddio lodato .
Eccezione prima .
Per tutto usato con sustantivi femminini,
non si rende femminino , nè si accorda con
essi, ma è come avverbio, e ciò è pura pro-
prietà di linguaggio . Quindi si dice: io sono
stato per tutto Roma : ho guardato per tutto
la strada : ho cerco per tutto la casa ; e simi-
li.
/ BEGIN PAGE 181 /
li. Salviati avvertim. vol. I. lib. 3. partic. I.
Lo stesso succede di salvo, cioè eccettuato .
Gio. Vill. l 3. c. 5 n I. Rendégli la signoria
di Lombardia , salvo la Marca Trivigiana .
Eccezione seconda .
Ogni cosa, benchè di voce femminina , ha
senso neutro, ed equivale all’ omne de’ Lati-
ni, e perciò si accorda coll’ addiettivo ma-
scolino , come gli altri neutri nella nostra
lingua . Bocc. Veggendo ogni cosa così disor-
revole, e così disparuto , cominciò a ridere.
Talvolta riceve addiettivo femminino. Bocc.
E ogni cosa di fiori, quali nella stagione si
potevano avere, piena, e di giunchi giunca-
ta la vegnente brigata trovò .
Eccezione terza.
Mezzo in senso di metà non si accorda col
nome femminino, di cui accenna metà . Gio.
Vill. Essendo montato in Firenze l’ ariento della
lega di once undici , e mezzo per libbra in lib-
bre 12., e soldi 15. Burchiell. 2. p. son. I.
Togli una libbra, e mezzo di castrone.
Eccezione quarta .
I soprannomi femminini dati a maschio si
truovano coll’ addiettivo mascolino. Bocc. g.
7. n. 4. Gli prieghi non giovavano alcuna co-
sa , perchè quella bestia , ( cioè Tofano ) era
pur disposto a volere, che tutti gli Aretini
sapessero la lor vergogna .
M 3 Re-
/ BEGIN PAGE 182 /
Regola seconda .
Quando vi sono più sustantivi singulari uni-
ti, l’ addiettivo, o preterito, o participio ,
che loro si aggiugne, dee essere plurale.
Bocc. g. 10. n. 7. Perdicone, e ’l padre, e la
madre della Lisa , ed ella altresì contenti ,
grandissima festa fecero.
Regola terza.
Se i sustantivi saranno , l’uno singulare,
l’altro plurale , l’ aggiunto potrà accordarsi
liberamente , o coll’uno, o coll’altro. Bocc.
g. 6. nel fin. Eßendosi Dioneo con pli altri gio-
vani messo a giucare a tavole. E g. 10. n. 6.
Il Re co’ suoi compagni rimontati a cavallo ,
al reale ostiere se ne tornarono.
Regola quarta .
Il Verbo personale finito concorda col suo
nominativo espresso , o sottinteso, nel nume-
ro , e nella persona. Bocc. Io ti consolerò di
così lungo disio. E canz.g.4 che per minor martir
la morte bramo . Il Verbo impersonale , che
da’ Latini si chiama finito, concorda col suo
nominativo, o con una proposizione , che ne
faccia le veci. Bocc. Viensene dentro, e stassi
con meco , e questo non falla mai = Bucina-
vasi, ch’ egli era degli scopatori.
Il Verbo infinito o è retto da un Verbo,
o da uno accusativo. Bocc. Essendo Salabaet-
to da lei andato una sera , costei incominciò
a cianciare = Niuna laude da te data gli fu,
ch’ io lui operarla non vedessi. Ec-
/ BEGIN PAGE 183 /
Eccezione .
Se il nominativo è nome collettivo, gli si
dà talvolta il Verbo plurale , e non si valu-
ta la parola , ma la significazione . Bocc. g. 2.
n. 6. Il popolo a furore corso alla prigione, e
uccise le guardie , lui n’ avevan tratto fuori .
E n. 60. Come ogni Uomo destinato ebbero ,
tanti uomini , e tante femmine concorsono nel ca-
stello , che appena vi capeano . Dante . Io non
lo ’ntesi, nè quaggiù si canta L’ inno, che quel-
la gente allor cantaro . Nov. ant. 83. La sua
famiglia avevano un dì preso un pentolajo per
malleveria, e menandolo a giudice , Messere
Azzolino era nella sala , e disse : chi è co-
stui ? Uno rispose : Messere , è uno olaro . An-
dàlo ad impendere.
Regola quinta .
Quando vi sono due nominativi , uno sin-
gulare , l’ altro plurale , il Verbo si accor-
da , o coll’ uno , o coll’ altro, come dagli
esempj addotti nella regola terza . E se in
tal caso vi fossero due Verbi , potrebbono
darsi, l’ uno al singulare, l’altro al plurale.
Bocc. g. 5. n. 7. La donna con la sua compa-
gnia , acciocchè il malvagio tempo non la co-
gliesse quivi , si misero in via per tornare in
Trapani , e andavanne ratti , quanto pote-
vano.
Regola sesta.
Quando di due nominativi l’uno è masco-
M 4 lino,
/ BEGIN PAGE 184 /
lino, l’altro femminino , il preterito, e il
participio del Verbo si accorda col mascoli-
no , se si tratta di persone , ma se si tratta
di altre cose , si può accordare col femmini-
no . Bocc. g. 2. n. 6. Convitati le donne, e
gli Uomini alle tavole , ancora alla prima vi-
vanda, sopraggiunse colui, il quale andato era
in Cicilia. E g. 5. n. 10. Essendosi la donna
col giovane posti a tavola per cenare, ed ec-
co Pietro chiamò all’ uscio, che aperto gli fosse .
E g. 6. n. 4. Se così gridato aveste, ella ( la gru )
avrebbe così l’ altra coscia, e l’altro piè fuor
mandata , come hanno fatto queste .
Regola settima.
Il relativo quale coll’articolo concorda in
tutto coll’ antecedente ; ma senz’articolo , e
dinotante qualità assoluta, o somiglianza con-
corda con ciò, che gli siegue appresso . Bocc.
Quel cuore , il quale la lieta fortuna di Giro-
lamo non avea potuto aprire , la misera l’aper-
se = Seco pensando, quali infra piccol termi-
ne dovean divenire = Videsi di tal moneta pa-
gato , quali erano state le derrate vendute.
Eccezione .
Persona , o altro nome femminino dato a
maschio, riceve il relativo mascolino. Bocc.
g. 8. n. 10. Egli ci è alcuna persona , il quale
l’altr’jeri mi servì de’ cinquecento, che mi man-
cavano, ma grossa usura ne vuole . Nov. ant.
92. Io sono acconcio di mostrare a quella bestia,
lo
/ BEGIN PAGE 185 /
lo quale si mostra sì rigoglioso, che io sono
nato di quella schiatta, che gittò la schiera
de’ Galli giù della Rocca del Campidoglio .
Regola ottava .
L’interrogazione, e la risposta concordano
in tutto . Nov. ant. 35. Cavaliere , a qual don-
na se’ tu ? Ed egli rispose : sono alla Reina del
Re di Castello.
CAP. II.
Della costruzione de’ Verbi attivi.
TUtti Verbi attivi hanno dopo di se uno
accusativo significante il termine della
loro azione , e oltre a questo possono avere
altri casi , secondo il carattere, e l’ estensio-
ne della loro azione , come da’ seguenti ordi-
ni si vedrà.
PRIMO ORDINE DEGLI ATTIVI.
TUtti i Verbi perfettamente transitivi, a’
quali si dà un sol termine di azione con
uno accusativo paziente , sono di quest’ ordi-
ne ; e perciò quasi tutti i Verbi attivi, sic-
come possono essere senza casi ulteriori all’ac-
cusativo , così possono appartenere a quest’
ordine ; e molti ancora di quelli, che da’ La-
tini sono riposti fra’ neutri . Basteranno adun-
que
/ BEGIN PAGE 186 /
que pochi esempj , de’ tanti , che si potreb-
bono addurre. Bocc. Allato alle lor case tut-
ti le lor biade battevano = E Amet. Lui più
degno a cultivare i campi , che a mirare gli
occhi miei , il reputai = Io ho amato, e amo
Guiscardo. Petrar. Ma ferma son d’odiarli
tutti quanti.
Appendice prima .
Hanno talvolta i Verbi , in vece dell’ accu-
sativo paziente, un Verbo col suo caso, o un’
infinito col segno del genitivo , o anche sen-
za. Bocc. g. 4. n. 6. Vorre’ io , che noi pren-
dessimo modo convenevole a servare il mio ono-
re. E g. 8. n. 2. II prete appostò , quando Ben-
tivegna del Mazzo, e la Belcolor manicasse-
ro = Le armi similmente la salute difendono di
coloro , che di viver disiderano = Vuoi tu mu-
rare, che noi veggiam qui tante pietre ?
Appendice seconda .
Innanzi all’accusativo paziente si pone non
di rado la particella di, per proprietà di lin-
guaggio . Bocc. g. 3. n. 8. Io ho di belli giojel-
li, e di cari. E g.4. n. 4. Fece due galee sot-
tili armare, e messivi su di valenti uomini,
con esse sopra la Sardigna n’andò .
Appendice terza .
Alcuni Verbi, i quali ordinariamente sono
assoluti , o costruiti neutralmente , si fanno
talora attivi di quest’ ordine . Eccone alcuni
esempj.
Cena-
/ BEGIN PAGE 187 /
Cenare . Bocc. g. 7. n. I. Cenarono un poco di
carne salata.
Abitare . Bocc. Quantunque amore i lieti
palagj, e le morbide camere più volentieri ,
che le povere capanne, abiti .
Correre. Bocc. g. 9. n. I. Assai m’ aggrada
d’ esser colei , che corra il primo aringo.
Crescere . Gio. Vill. E crebbono assai la Cit-
tà di Pisa.
Servire. Bocc. Quivi serviva certi pescato-
ri Cristiani .
Consentire, acconsentire, contraddire, con-
trastare . Boccacc. Prima sofferrebbe di eßere
squartato, che tal cosa contro l’ onor del suo
signore, nè in se, nè in altrui consentisse . E
g. 4. n. 8. Egli acconsentì di dovervi andare a
stare uno anno = Uccidendo chiunque ciò contra-
star presumesse . Passav. f. 94. Possono poi udi-
re le confessioni, senz’ altra licenzia de’ preti
parrocchiali, eziandio s’ essi il contradicessono.
Sapere . Bocc. n. 4. Egli nol saprà persona
mai. Si truova passivo. Passav. f. 235. Sono al-
cuni altri , che vogliono sapere per esser sapu-
ti, cioè per essere cognosciuti .
Sapere a mente vale aver nella memoria .
Bocc. g. 7. n. 10. Sì fu uno , il qual pareva,
che tutti i miei peccati sapesse a mente .
Sapere per lo senno a mente vale avere in-
tera notizia . Galil. sist. f. 27. Ci son molti, che
sanno per lo senno a mente tutta la Poetica, e
sono
/ BEGIN PAGE 188 /
sono poi infelici nel comporre quattro versi .
Soddisfare . Bocc. Pensò , avendolo a cia-
scun promesso , di volergli tutti e tre soddis-
fare .
Supplire . Bocc. Acciocchè io poßa quel di-
fetto supplire , che ora , per la vostra fretta ,
mi convien commettere.
Appendice quarta .
Ci sono de’ Verbi di quest’ ordine , de’ qua-
li fanno i Toscani un’ uso diverso da quel-
lo, che se ne fa volgarmente . Eccone al-
cuni esempj .
Domandare presso a’ Toscani non val sola-
mente chiedere , ma anche interrogare, o ri-
chiedere di alcuna persona, ed è di quest’ or-
dine. Bocc. g. 2. n. 3. Alessandro domandò l’o-
ste là dove esso potesse dormire. E g. I. n. I
Se ne andarono ad una Religione di Frati, e
domandarono alcuno santo , e savio uomo .
Ricordare si usa per nominare . Bocc. Per-
chè ricordavate voi o Dio, o’ Santi ?
Crescere si adopera per allevare . Boccacc.
Come figliuola cresciuta m’ avete .
Rubare si usa per ispogliare. Bocc. Molto
ben sapeva la cui casa stata fosse quella , che
Guidotto avea rubata.
Fuggire si usa per trafugare. Gio. Vill. Chi
avea cose rare, o mercatanzie, le fuggia in
chiese, e in luoghi di Religiosi sicuri.
Sentire si usa per conoscere. Bocc. g. 5. n. 2.
La
/ BEGIN PAGE 189 /
La mando a sentire quello , che di Martuccio
trovar potesse. Petrar. canz. 41. Quel, che tu
vali , e puoi, Credo, che ’l senta ogni gentil
persona .
Sostenere si usa per comportare . Bocc. Que-
sti Lombardi cani non ci si vogliono più sostene-
re. E in significato di permettere . Boccacc.
Vollele fare la debita reverenza , ma ella nol
sostenne . E più singolarmente per arrestare un
reo in corte, senza incarcerarlo . Nov. ant. 3
Fece sostenere lo Cavaliere ; cioè nella corte
del Re Alessandro.
Usare in quest’ ordine si adopera per fre-
quentare. Bocc. Usava molto la Chiesa.
Valere si usa per meritare . Bocc. g. I. n. 10.
Ch’ io ami, questo non dee eßer maraviglia ad
alcuno savio , e spezialmente voi , perciocchè
voi il valete .
Tenere si usa per pigliare , ma solo nel pre-
sente dell’imperativo, nel singulare del qua-
le si dice te in vece di tieni . Bocc. Te que-
sto lume buono uomo , e guata, s’ egli è netto
a tuo modo = Madonna , tenete questi danari ,
e daretegli a vostro marito .
Lasciare stare fa figura quasi di un sol Ver-
bo, e vale il Latino præterire . Petrar. Perchè
morte fura Prima i migliori, e lascia stare i
rei.
Togliere, e torre per prendere è molto fa-
migliare a’ Toscani. Bocc. Togli quel morta-
jo,
/BEGIN PAGE 190 /
jo, e riportalo alla Belcolore = Il famigliare ,
forse sdegnato , tolse un gran fiasco = Voi sa-
pete quello , che voi mi prometteste , cioè di
essere contenti, e di onorar come donna, qua-
lunque quella fosse , ch’io togliessi.
Togliere , e torre via per levare . Bocc. Co-
sì questa seccagine torrò via = Tolga via Id-
dio , ch’ io mai colei , la quale egli ; siccome a
più degno, ha a te donata , ch’ io da te la ri-
ceva per mia .
Toccare per commuovere . Bocc. Questo ra-
gionamento con gran piacere toccò l’ animo del-
lo abate .
Morire si usa ne’ preteriti per uccidere .
Bocc. Disse Bruno pianamente : vedestila ? Ri-
spose Calandrino : oimè, sì ; ella m’ ha morto .
Secondo Ordine degli Attivi.
I Verbi di quest’ ordine, oltre l’ accusativo
paziente , ammettono un genitivo espri-
mente la materia , o quasi materia dell’ azio-
ne del Verbo . Ne addurremo alquanti, da’
quali si potrà agevolmente argomentare la
costruzione degli altri .
Empiere. Bocc. Vedendo carboni in un canto
della camera , di quelli la cassetta empierono .
Caricare. Bocc. Comperò un grandissimo le-
gno, e quello tutto di suo’ danari caricò di va-
rie mercatanzie .
Pasce-
/ BEGIN PAGE 191 /
Pascere. Bocc. Filoc. Egli pascè di cinque
pani, e di due pesci cinque mila uomini.
Premiare. Bocc. Per premiare il cavaliere
dell’ onore ricevuto da lui .
Onorare . Boccacc. Seco stesso si dolea, che di
compagni, e di più solenne convito quella sera
non gli poteva onorare .
Ornare, adornare . Petrar. Che di verde lau-
ro, Tre volte trionfando , ornò la chioma . Le
rive , e i colli di fioretti adorna .
Avvisare . Matt. Vill. Avvisarono Meßer
Loderigo del fatto.
Riprendere . Bocc. Cominciarono a riprender
tutti Tofano, e a dirgli villania di ciò, che
contro alla donna diceva .
Minacciare . Bocc. Minacciolli forte di bat-
terli .
Incolpare . Petrar. p. I. 169. Nè di ciò lei ,
ma mia ventura incolpo .
Offendere . Bocc. Me non avete offeso di al-
cuna cosa.
Motteggiare. Bocc. Si proposero di motteg-
giarlo di questo suo innamoramento .
Esaminare . Bocc. Partitamente d’ ogni sua
paßata vita l’ esaminò.
Ringraziare . Bocc. Ringraziolla adunque
della sua buona volontà ,
Pregare. Bocc. Ch’ io faccia quello , di che
tu m’ hai cotanto pregato.
Appen-
/ BEGIN PAGE 192 /
Appendice prima.
Menare smanie, menare orgoglio, modi To-
scani , appartengono a quest’ ordine. Boccacc.
Ne ’nvaghì sì forte, ch’egli ne menava sma-
nie . Carlo Dati Prose Fiorent. p. I. vol. 4.
orat. 9. Desiderabile è la nobiltà , ancorchè di
lei sola alcun non debba menare orgoglio .
Appendice seconda .
Anche in quest’ordine ci sono Verbi di par-
ticolare osservazione. Eccone alcuni.
Servire significa prestare, o dare. Boccacc.
n. 3. Il Giudeo liberamente d’ ogni quantità, che
al Saladino il richiese, il servì .
Diservire si usa per nuocere . Bocc. Si dee
credere , che essi ne vogliano fare qualche stra-
zio , siccome di colui, che forse già d’ alcuna
cosa gli diservì .
Fornire si usa per provvedere . Gio. Vill. Il
Re fece fornire la terra di vittuaglia . E così
rifornire . Passav. Accendeva le lampane , e ri-
fornivale d’ olio .
Adagiare vale somministrare altrui le sue co-
modità. Bocc. Gli ebbe di tutto ciò, che biso-
gnò loro , e di piacere era, fatti adagiare.
Gravare si usa per affaticare . Bocc. Non
volle più la gentildonna gravare di tal servi-
gio.
Sperare si usa per aspettare . Boccacc. Del
quale non sapeva , che si doveße sperare altro ,
che male.
Rim-
/ BEGIN PAGE 193 /
Rimprocciare vale biasimare con ischerno.
Gio. Vill. Fecionsene beffe, rimprocciando i Fio-
rentini di lor viltade.
Ripigliare vale riprendere . Bocc. A voi sta
bene di così fatte cose , non che gli amici, ma
gli strani ripigliare .
Pagare si usa per gastigare . Bocc. g. 7. n. 8.
Guarda , che per la vita tua da quinci innan-
zi simili novelle noi non sentiamo più , che per
certo se più nulla ce ne viene agli orecchi ,
noi ti pagheremo di questa , e di quella.
Terzo Ordine degli Attivi.
I Verbi di quest’ ordine, dopo l’accusativo
paziente , ammettono un dativo, ch’ espri-
ma il termine , il quale riceva l’ azione del
Verbo . Eccone alquanti.
Dare . Bocc. Poßessioni , e case ci ha date.
Promettere . Bocc. n. I. Io ti prometto di pre-
gare Iddio per te .
Minacciare si truova usato di quest’ ordi-
ne , col mettere la pena in accusativo , e la
persona minacciata in dativo . Bocc. g. 2.
n. 9. Con viso troppo più turbato gli minaccia-
va gravissimi tormenti, se nol dicesse .
Vendere . Bocc. g. 4. n. 10. Io non la vende’
loro , ma essi questa notte paßata me l’ avran-
no imbolata .
Chiedere . Bocc. Mi chiese mercè per Dio ,
N e per
/ BEGIN PAGE 194 /
e per voi. Si truova usato ancora coll’ abla-
tivo . Passav. f. 96. Se si volesse confessare ad
altri preti, chieggia la licenzia dal Vescovo ,
o dal suo Vicario , o dal Prete medesimo .
Commettere . Bocc. Ad Emilia commise il ra-
gionare.
Credere . Bocc. Mogliema nol mi crederà .
Insegnare . Bocc. Insegnamegli, e io andrò
per essi.
Raccontare . Bocc. La Fante promise larga-
mente , e alla sua donna il raccontò .
Perdonare . Bocc. Vi prometto , se questa mi
perdonate , di mai più in ciò non peccare .
Aßomigliare. Bocc. Domandollo , perchè lui
alla sua mula avesse assomigliato .
Attendere . Bocc. Son buona , e non atten-
do a così fatte novelle .
Attribuire . Passav. f. 157. Non dee adunque
la persona attribuire a’ suoi meriti qualunque
bene abbia, ma alla grazia, e alla misericor-
dia di Dio .
Apparecchiare . Bocc. g. 2. n. 2. S. Giuliano,
avendo a lui riguardo, senza troppo indugio gli
apparecchiò buono albergo.
Appendice prima.
Ci sono gl’ infrascritti Verbi di particolare
osservazione .
Attenere vale osservar la promessa. Bocc.
g. 8. n. 2. Tutti siete così gran promettitori , e
poscia non attenete altrui nulla .
Disdi-
/ BEGIN PAGE 199 /
Disdire val proibire . Bocc. Ninf. Fiesol. E
se non che paura mel disdice Di Diana, l’a-
vrei per forza presa.
Apporre si usa per incolpare a torto . Bocc.
Il marito poteva per altra cagione essere cruc-
ciato con lei, e ora apporle questo per iscusa
di se.
Aprire si usa per manifestare . Bocc. n. 3.
Dispose d’ aprirgli il suo bisogno .
Recare si adopera per riferire . Bocc. Nè
guari dopo queste novelle gli recarono i dipin-
tori, ch’ egli era per ricevuto .
Apprestare vale apparecchiare . Bocc. La don-
na gli fece apprestar panni stati del marito di
lei .
Annoverare val numerare . Bocc. E di pre-
sente gli annoverò i danari .
Servire si usa per restituire . Bocc. Perchè,
non mi vuo’ tu migliorare qui tre soldi? Non
credi tu, ch’io te gli possa ancor servire?
Appendice seconda .
Appartengono a quest’ ordine molti modi
di dire eleganti, e proprj della lingua Tosca-
na. Eccone alquanti .
Contendere una cosa vale impedirne il con-
seguimento. Gio. Vill Contesero loro il passo.
Petrar. Tu vedrai Italia, e l’onorata riva ,
Canzon , ch’ agli occhi miei cela , e contende
Non mar , non poggio, o fiume , Ma solo Amor.
Far vedere vale dare ad intendere. Bocc.
N 2 g. 7.
/ BEGIN PAGE 196 /
g. 7. n. 9. Fattigli chiamare amenduni , fece
lor vedere, che la bocca putiva loro.
Tenere si adopera per vietar l’ ingresso,
come in questi esempj . Bocc. E quale uscio
ti fu mai in casa tua tenuto? Franc. Sacc.
Comandò a tutti gli altri , che quando Ser
Mazzeo volesse venire a lui , giammai porta
non gli fosse tenuta . Buti Purg. Lo malo amore
delle cose mondane , che ci tiene la ’ntrata del-
la penitenzia .
Tener favella vale restar di parlare ad alcu-
no per isdegno . Bocc. La Belcolore venne in
iscrezio col Sere, e tennegli favella infino a
vendemmia .
Tener credenza vale tener segreto. Bocc.
Se io credessi , che tu mi tenessi credenza , io
ti direi un pensiero , che io ho avuto più volte .
Cogliere, o porre cagione vale accusare,
incolpare . Nov. ant. 72. Il Soldano avendo me-
stiere di moneta , fu consigliato, che cogliesse
cagione a un ricco Giudeo , e poi gli togliesse il
mobile suo . Gio. Vill. Puosegli cagione , ch’ egli
ordinava congiura .
Torre il capo , o la testa a uno vale infasti-
dirlo . Firenz. Deh di grazia non mi torre la
testa = Che casa, o non casa , che ci avete
oramai tolto il capo ?
Rendere la grazia vale perdonare . Bocc.
Tanto col Re adoperarono, ch’egli le rendè la
grazia sua .
Quar-
/ BEGIN PAGE 197 /
Quarto Ordine degli Attivi .
I Verbi di quest’ordine , oltre all’ accusa-
tivo paziente , ne ammettono un’ altro,
che esprima alcuna qualità del suggetto dell’
azione del Verbo. Eccone alquanti .
Giudicare . Bocc. I quali non che altri, ma
Galieno , Ipocrate , o Esculapio avrieno giudi-
cati sanissimi .
Riputare. Bocc. n. ult. Savissimo riputarono
Gualtieri.
Credere. Bocc. g. 3. n. 7. Noi piagnemmo co-
lui, che noi credevamo Tedaldo .
Conoscere . Bocc. La Reina , la quale lui , e
festevole Uomo, e solazzevole conoscea .
Chiamare. Bocc. Non Cappello , ma Ciap-
pelletto il chiamavano .
Nominare . Bocc. Giannotto il levò dal sa-
gro fonte , e nominollo Giovanni .
Pronunziare , e dichiarare . Matt. Vill. Lo
pronunciarono , e dichiararono Gonfaloniere di
Santa Chiesa .
Costituire . Bocc. Costituisco Parmeno , fa-
migliar di Dioneo , mio siniscalco .
Eleggere . Bocc. g. I. Ad una voce lei prima
( Reina ) del primo giorno elessero .
Rendere. Bocc. Surgendo l’ aurora , ed al-
quanto rendendo il cielo più chiaro.
N 3 Appen-
/ BEGIN PAGE 198 /
Appendice prima .
Sonci gl’ infrascritti Verbi di particolare
osservazione.
Sentire si usa per credere. Bocc. Della prov-
videnza degl’ Iddii niente mi pare che voi sen-
tiate . E g. 2. n. 9. Non ti sento di sì grosso
ingegno , che &c. Si sottintende l’accusativo
uomo .
Trovare si usa per sentire. Bocc. Toccan-
dolo il trovò, come ghiaccio , freddo .
Tenere per giudicare . Bocc. Currado aven-
do costui udito, si maravigliò , e di grand’ ani-
mo il tenne . Supplisci uomo .
Fare per dar taccia. Bocc. Dunque hai tu
fatto lui bevitore , e vago de’ vini solenni . E
anche per riputare , giudicare . Dante Inf.
cant. 10. Suo cimitero da questa parte hanno
Con Epicuro tutti i suoi seguaci, Che l’ anima
col corpo morta fanno .
Appendice seconda .
Eleggere presso Giovanni Villani si truova
col dativo : Per lo comune bene della Repubbli-
ca elessero a Re , e loro signore Numa Pompi-
lio .
Lasciare, instituire , e sostituire erede, for-
me di parlare legali , appartengono a quest’
ordine ; con quest’ avvertenza , che erede ,
benchè si tratti di femmina , si fa mascoli-
no. Bocc. g. 5. n. 9. Fece testamento , ed essen-
do ricchissimo , in quello lasciò suo erede un suo
figliuo-
/ BEGIN PAGE 199 /
figliuolo già grandicello, e appresso questo, aven-
do molto amata Monna Giovanna , lei ( se av-
venisse , che il figliuolo senza erede legittimo
morisse ) suo erede sustituì .
Quinto Ordine degli Attivi.
I Verbi di quest’ordine, dopo l’accusativo
paziente , ne ammettono un’ altro colle
preposizioni ad, o in, che accennino movi-
mento ad alcun termine , o fine. Eccone al-
quanti .
Introdurre . Bocc. Al suo convito, il quale
ancora al mezzo non era, gli introdusse .
Trasportare . Bocc. Eßendo lo ’mperio di Ro-
ma da’ Franceschi ne’ Tedeschi trasportato.
Costrignere. Bocc. Amore mi costrigne a
così fare .
Eccitare . Cavalc. med. spir. Sostenendo noi
valorosamente le tribolazioni, poichè elle ci
purgano, e pruovano , e ci tolgono al male ,
ed eccitano al bene.
Gittare . Bocc. Gittò la sua lancia nel fie-
no .
Elevare . Bocc. g. 2. n. 4. Vedere uno d’ in-
fima miseria a stato reale elevare .
Convertire. Bocc. Fu presso a convertire in
rabbia la sua grande ira.
Ammaestrare . Bocc. La quale essa assai be-
ne a così fatti servigi avea ammaestrata .
N 4 Acco-
/ BEGIN PAGE 200 /
Accostare . Bocc. E al suo cuore accostò quel-
lo del morto .
Appoggiare . Bocc. Una tavola molto larga
ordinata in guisa , che stando tu in piè , vi possi
le reni appoggiare .
Legare. Bocc. g. 4. n. 2. Legò il suo uomo sal-
vatico ad una colonna .
Invitare . Bocc. Fece un magnifico convito ,
al quale invitò una parte de’ più onorevoli cit-
tadini .
Condannare . Bocc. I quali l’ autorità delle
pubbliche leggi già condannò ad esilio .
Appendice prima .
I Verbi di quest’ ordine di particolare os-
servazione sono i seguenti.
Convitare vale chiamare a convito. Gio.
Vill. Convitò a mangiare gli ambasciadori di
Firenze .
Condurre si usa per indurre. Boccacc. Colla
maggior fatica del mondo a prendergli, ed a
mangiare la condusse .
Scorgere si adopera per guidare. Petrar.
Scorgimi al miglior guado , E prendi in grado
i cangiati desiri .
Raccomandare si usa per legare . Boccacc.
Amet. f. 7. Rivolta a’ cani , quelli cogli usati
legami attaccati alla presente quercia racco-
mandò .
Accomandare vale lo stesso . Bocc. g. 4. n.
5. Accomandato bene l’ un de’ capi della fune
a un
/ BEGIN PAGE 201 /
a un forte bronco , per quella si collò nella
grotta .
Recare si usa per indurre . Bocc. Io mi cre-
derei in brieve spazio di tempo recarla a quel-
lo , che io ho già dell’ altre recate .
Appendice seconda .
Appartengono parimente a quest’ ordine i
seguenti modi di dire .
Rimettere in arbitrio . Bocc. Nel suo arbi-
trio rimise l’ andare , e lo stare .
Sposare a moglie . Gio. Vill. Lasciò la cheri-
cheria , e sposò la Contessa Margherita a moglie .
Sesto Ordine degli Attivi .
I Verbi di quest’ ordine , dopo l’accusativo
paziente , ammettono uno ablativo , che
accenni prezzo, istromento, modo , e simi-
li , o senza preposizione , o colle preposizio-
ni per , con , in , a , di . Eccone alquanti .
Vendere , pagare , apprezzare , stimare , e
simili ricevono nell’ uso il prezzo in ablati-
vo senza preposizione , e si dice : io ho sti-
mato , pagato , venduto un cavallo venti scudi .
Cercare . Passav. Gli uomini la vanno cer-
cando per vie distorte .
Conferire . Passav. f. 231. N’ andò in Geru-
salem a S. Piero, e a S. Jacopo a ragionare,
e conferire con loro tutto ciò , che gli era in-
tervenuto .
Ricom-
/ BEGIN PAGE 202 /
Ricompensare . Passav. f. 69. Ricompensi le
delizie passate , colle quali offese Iddio, coll’
asprezza dell’ austera vita .
Percuotere . Bocc. Presa una gran pietra ,
con troppo maggior colpi, che prima, fieramen-
te cominciò a percuotere la porta .
Rompere per infragnere con percosse . Bocc.
g. 7. n.7. Credendo eßo , ch’ io fossi te, m’ ha
con un bastone tutto rotto .
Avanzare . Bocc. Pietro , che giovane era ,
e la fanciulla similmente , avanzavano nello
andare la madre di lei .
Ricreare . Bocc. Con molte buone , e sante
parolozze la Domenica a piè dell’ olmo ricrea-
va i suoi popolani .
Comperare , e vendere . Bocc. Le Divine
cose a danari e vendevano , e comperavano =
Non per vendere poi la sua scienza a minu-
to , come molti fanno = Schiacciava noci , e
vendeva i gusci a ritaglio . Sen. de’ ben. Var-
ch. Non desiderò egli di vendere a molti , ma
di vender caro , e di comperare a buon mer-
cato .
Appendice prima .
Ci sono i seguenti Verbi di particolare
osservazione .
Ordinare si usa per restar d’ accordo . Bocc.
Con lui ordinò quello , che a fare , o a dire
avesse.
Prendere si usa per fare innamorare. Bocc.
g. 8.
/ BEGIN PAGE 203 /
g. 8. n. 10. Con la piacevolezza sua avea sì
la sua donna presa , ch’ ella non trovava
luogo.
Tornare per riporre . Bocc. Tacitamente il
tornarono nell’ avello .
Racconciare per rappacificare . Gio. Vill. Lo
Re parlamentò con lui con belle parole , per
racconciarlo con Messer Carlo di Valos .
Appendice seconda .
A quest’ ordine appartengono i modi di di-
re , che sieguono .
Battere , e ferire ricevono il caso dell’ ar-
me colla preposizione di, per proprietà di
linguaggio. Gio. Vill. Allora un Barone del
Re lo batteo forte d’ un bastone . Passav. f. 39.
Il coltello , di che io la ferisco , tutto è fuoco .
Morire nel participio, per ammazzare, riceve
il caso colla preposizione di . Petrar. Che
questo è ’l colpo , di che Amor m’ ha morto .
Porre pena in una cosa , modo franzese,
vale impiegarvi cura , e fatica . Bocc. g. 8.
n. 7. Seco diliberò del tutto di porre ogni pe-
na , ed ogni sollicitudine in piacere a costei.
Settimo Ordine degli Attivi .
I Verbi di quest’ ordine, dopo l’accusativo
paziente , ammettono uno ablativo dino-
tante separazione, colla preposizione da , o al-
tra particella equivalente . Eccone alquanti.
Aßol-
/ BEGIN PAGE 204 /
Assolvere . Bocc. Omai da ogni promessa fat-
tami io v’ assolvo.
Disciorre . Bocc. Ninf. Fies. Tu se’ colei , la
Qual , se tu vorrai, Me da misera morte puoi
disciorre .
Disviare . Gio. Vill. T’ hanno disviata dal
tuo buono, e umile , e povero, e santo comin-
ciamento .
Esiliare . Bocc. Filoc. Immaginò di far sì,
che le nuove creature da quella abitazione fa-
cesse esiliare.
Cacciare . Bocc. Cacciata aveva il sole del
Cielo già ogni stella .
Guerire. Boccacc. g. 3. n. 9. tit. Giletta di
Nerbona guerisce il Re di Francia d’ una fi-
stola .
Levare . Bocc. Colà la riportò, onde leva-
ta l’ aveva .
Attendere . Bocc. Senza riprensione attende-
re da voi.
Difendere . Bocc. Vestito d’ un cuojo, che da’
pruni il difendesse .
Nettare . Bocc. Dicendo , che la salvia mol-
to bene gli nettava d’ ogni cosa .
Distinguere. Bocc. Come vogliono le leggi
Sacre, e le civili , le quali hanno i dì delle fa-
tiche distinti da quegli del riposo.
Cogliere . Petrar. Poggi, e onde passando , e
l’ onorate Cose cercando , il più bel fior ne
colse .
Appen-
/ BEGIN PAGE 205 /
Appendice prima .
Ci sono i seguenti Verbi di particolare
osservazione .
Accattare usato assoluto val mendicare ;
ma col caso ulteriore di quest’ ordine usato
attivo vale prendere in prestanza . Bocc. g. 8.
n. 2. nel tit. Accattato da lei un mortajo , il
rimanda . Tesor. Brun. Provano i savj , che la
Luna accatta dal Sole lo risplendente lume .
Riconoscere una cosa da uno vale confessare
d’ averla ricevuta per sua grazia , ch’ è l’ ac-
ceptum referre de’ Latini . Dante. Dal tuo po-
dere , e dalla tua bontate Riconosco la grazia,
e la virtute .
Mutare si usa per toglier via alcuna cosa
da un luogo . Bocc. g. 8. n. 6. Vogliangli noi
imbolare stanotte quel porco ? Disse Buffalmac-
co : O come potremmo noi ? Disse Bruno : il co-
me ho io ben veduto , se egli nol muta di là,
ove egli era testè .
Partire si usa per allontanare . Bocc. Egli
avea l’ anello caro, ne mai da se il partiva .
Divellere vale lo stesso che in Latino .
Bocc. Lui per un picciolo lucignoletto preso del-
la sua barba, e ridendo , sì forte il tirò, che
tutto del mento gliele divelse .
Sceverare val separare . Albertan. Lo co-
minciamento della superbia dell’ uomo fa sce-
verare l’uomo da Dio .
Distornare vale svolgere , distorre . Liv. M.
Voi
/ BEGIN PAGE 206 /
Voi vi travagliate di spaventar la plebe , e
di distornarla dallo ’ntendimento della novella
legge .
Ritrarre vale lo stesso . Petrar. Da mille at-
ti inonesti l’ ho ritratto .
Prosciogliere vale assolvere . Passav. Non
ogni Prete puote prosciogliere da ogni peccato .
Appendice seconda .
A quest’ Ordine appartengono i modi di
dire , che sieguono .
Levare dal sagro fonte vale tenere a bat-
tesimo. Bocc. Giannotto il levò dal sacro fon-
te , e nominollo Giovanni .
Accattar parola vale impetrare . Nov. ant.
57. Pregandolo per amore , che accattasse pa-
rola dal Re , che un solo torneamento si fa-
ceße con sua licenzia .
Toglier di vita , di terra , o del mondo va-
le ammazzare . Bocc. Oltre a centomilia crea-
ture umane si crede per certo essere stati di
vita tolti . = Acciocchè una medesima ora to-
gliesse di terra i due amanti , ed il lor figli-
uolo . E nel Labir. Meco immaginai di costri-
gnerla a tormi del Mondo .
CAP.
/ BEGIN PAGE 207 /
CAP. III.
Della costruzione de’ Verbi passivi .
LA costruzione de’ Verbi passivi si fa in que-
sto modo . L’ accusativo paziente si fa
nominativo , e il nominativo si fa ablativo
colla preposizione da , e i casi ulteriori si la-
sciano come stanno . Esempli di tutti gli or-
dini degli Attivi .
I Io amo Pietro . Pietro è amato da me .
2 Io vi ringrazio di questo. Voi siete rin-
graziato di questo da me .
3 Tu doni un libro a me. Un libro è dona-
to da te a me .
4 Iddio ti renda felice. Tu sij renduto da
Dio felice .
5 Io invito Pietro a cena. Pietro è invita-
to da me a cena .
6 Pietro percosse Paolo con una pietra. Pao-
lo fu percosso da Pietro con una pietra .
7 Il Confessore mi assolve da’ peccati . Io so-
no assoluto dal Confessore da’ peccati .
Si noti però , che il Verbo può farsi passi-
vo , aggiugnendogli la particella si , purchè
l’ agente si metta in ablativo colla preposi-
zione da , come se dicessimo : Il cielo, secon-
do Aristotile , dalle intelligenze si muove . No-
te all’ Ercol. del Varchi f. 239.
CAP.
/ BEGIN PAGE 208 /
CAP. IV.
De’ Verbi assoluti .
VErbi assoluti si chiamano quelli, che non
hanno caso alcuno, e tali sono d’ or-
dinario gl’ intransitivi , e molti ancora de’
transitivi imperfetti. Anzi talvolta anche i
Verbi transitivi perfetti si adoperano a guisa
di assoluti, e si dice : io amo , io leggo &c.
senza esprimere alcun caso. Ora di que’ Ver-
bi, che si adoperano assoluti , addurremo
quelli solamente , che sono degni di partico-
lare osservazione .
Rompere assolutamente vale far naufragio.
Dante conviv. O miseri , e vili , che colle
vele alte correte a questo porto , e laddove do-
vreste riposare, per lo impeto del vento rom-
pete, e perdete voi medesimi . Quando il di-
scorso non è di naufragio , e si vuol usare
la simiglianza del naufragio , si dice rompe-
re in mare . Passav. Parla il Santo Dottore
della penitenzia , per simiglianza di coloro ,
che rompono in mare .
Sedere si usa per regnare , dominare , pre-
sedere . Boccaccio Vit. Dant. Con volontà , e
mandato di Clemente Papa Quinto, il quale
allora sedea , fu eletto in Re de’ Romani .
Parere si usa per apparire. Vit. Crist. Ora
si par-
/ BEGIN PAGE 209 /
si parranno i tuo’ maleficj , ora si parrà la
sapienza tua.
Sentire avanti vale penetrar molto colla
cognizione. Bocc. n. 3. Tu se’ savissimo, e nel-
le cose d’ Iddio senti molto avanti.
Trapassare si usa per morire , ed è voce
di origine Franzese . Bocc. Il quale non istet-
te guari, che trapassò .
Trarre parlando di cavalli , muli &c. va-
le tirar calci. Nov. ant Il mulo trasse, e die-
gli un calcio nel capo tale , che l’ uccise .
Trasandare si usa per eccedere i termini
del convenevole. Bocc. Quantunque in alcu-
ne cose , siccome i giovani amanti molto spesso
fanno , trasandasse , nondimeno Aristippo pa-
zientemente il sosteneva .
Andarsene si usa in significato di cosa, che
sia tolta via . Bocc. g. 3. n. 4. I peccati , che
tu hai infino all’ ora della penitenzia fatti ,
tutti si purgheranno, e sarannoti per quella
perdonati , e quegli , che tu farai poi, non sa-
ranno scritti a tua dannazione , anzi se n’an-
dranno coll’ acqua benedetta . Passav. f. 85. Se-
condochè procedeva nella confessione , così a po-
co a poco il dolore, e il color nero del fuoco
se n’andava .
Trasognare val farneticare , essere come
fuor di se . Fran. Sacch. Andossene al mulino
tutto tristo, trasognando , senz’ aver mangia-
to delle uova . Quindi trasognato, cioè stupi-
do.
/ BEGIN PAGE 210 /
do. Bocc. Arriguccio stava come trasognato ,
e voleva pur dire .
Volgere per correre di tempo . Petrar . Or
volge, Signor mio, l’ undecim’ anno , Ch’ i’ fui
sommesso al dispietato giogo .
Usare per bazzicare . Bocc. Vennesene do-
ve usavano gli altri mercatanti .
Trarre presso a’ Toscani si usa per accor-
rere, e concorrere . Fran. Sacch. Uno Piova-
no giucando a scacchi, vincendo il compagno,
suona a martello , per mostrare a chi trae, co-
me ha dato scaccomatto, e’ quando gli arde la
casa, niuno vi trae.
Muovere si usa per andare. Petrar. canz. 5.
Or muovi, non smarrir l’ altre compagne.
CAP. V.
Della costruzione de’ Verbi neutri .
I Verbi neutri convengono in ciò cogli at-
tivi , che non significano passione alcuna,
anzi accennano azione : ma sono in ciò dif-
ferenti , che non significano, come gli atti-
vi, azione perfettamente transitiva , ma in-
transitiva, o transitiva imperfetta .
/ BEGIN PAGE 211 /
PRIMO ORDINE DE’ NEUTRI .
I Verbi di quest’ordine ricevono due no-
minativi , uno avanti esprimente il sug-
getto della azione, l’ altro dopo, che ac-
cenni l’ essere, il nome, o alcuna qualità del
suggetto medesimo . Eccone alquanti.
Essere . Bocc. g. 3. n. 8. Io sono uomo, co-
me gli altri, e , come voi vedete , io non so-
no ancor vecchio.
Parere . Bocc. S’ abbattè in alcuni, i quali
mercatanti parevano.
Comparire . Bocc. Acciocchè voi per la pri-
ma volta compariate orrevole dinanzi alla bri-
gata .
Nascere. Boccaccio g. 4. n. I. Tutti nascem-
mo , e nasciamo iguali .
Rimanere. Bocc. n. 2. Dove così non fos-
se, io mi rimarrò Giudeo, com’ io mi sono .
Diventare . Bocc. O consolazion sopravvie-
ne, o diventa la noja minore .
Ritornare . Bocc. n. 2. S’ egli fosse Cristiano
fatto, senza fallo Giudeo si ritornerebbe .
Vivere. Bocc. Parendogli che costoro meno,
che alcuni altri, del Mondo curassero, e più
lieti vivessono .
Appendice prima .
Essere si truova coll’ accusativo dopo. Boc-
caccio. La donna domandò , se Anichin fosse
O 2 al
/ BEGIN PAGE 212 /
al giardino venuto. Egano disse : così non fosse
egli , perciocchè credendo esso , ch’ io fossi te,
m’ ha con un bastone tutto rotto .
Si truova parimente la terza persona sin-
gulare del presente dell’ Indicativo di essere
accordata col plurale. Boccaccio g. 8. n. 2.
E non è ancora quindici dì, che mi costò da
Lotto rigattiere delle lire ben sette. E n. 9.
Poche volte è mai , ch’ io mi lievi la notte.
Appendice seconda .
I Verbi di particolare osservazione sono i
seguenti.
Stare si usa per essere. Bocc. n. 2. Io ri-
gido , e duro stava a’ tuoi conforti.
Tornare si usa per esser di nuovo ciò, che
altri era innanzi . Bocc. Ravvediti oggimai,
e torna uomo , come tu eßer solevi.
Venire si usa per divenire . Boccacc. Ninf.
Fiesol. E crescendo Pruneo venne sì bello
Della persona , che se la natura L’ avesse fat-
to in prova col pennello , Non potea dargli più
bella figura .
Secondo Ordine de’ Neutri .
I Verbi di quest’ordine hanno dopo di se
un genitivo esprimente materia , o fine,
ovvero uno infinito col segno del genitivo ,
o colla preposizione a, o ancora senza segno
alcu-
/ BEGIN PAGE 213 /
alcuno. Non pochi de’ Verbi di quest’ ordine
potrebbono, se altri il volesse , ridursi alla
prima degli attivi, prendendo il genitivo in
forza di accusativo, per proprietà di lin-
guaggio: ma perchè finalmente tali Verbi
hanno la figura di neutri , potranno ridursi
a quest’ ordine. Eccone non pochi esempj .
Prima però si noti, che alcuni di questi Ver-
bi hanno avanti , o affissa la particella pro-
pria de’ neutri passivi , ma non perciò son
tali, non avendo alcun senso passivo , e la par-
ticella si appone loro come accompagnaver-
bo , e per proprietà di lingua .
Curare . Bocc. Di che la donna poco curò .
E g. 9. n. 6. Tornandosene , senza della culla
curarsi, nel letto se n’ entrò,
Abbisognare. Albertan. c. 12. Quegli abbi-
sogna di poco, che poco desidera. Qui vale
aver bisogno .
Ardire, e colla particella, e senza . Nov.
ant. 40. Un giuocolare stava a questa tavola,
e non s’ ardiva di chiedere di quel vino . Boc-
caccio g. 10. n. 9. Furono de’ sì presuntuosi,
che ardirono di dire , se averlo veduto mor-
to .
Credere , e colla particella , e senza, quan-
do si tratta di cosa appartenente a chi par-
la, è di quest’ ordine, e talvolta si tace il
segno del genitivo. Passav. f. 116. E così
faccia di ciascuno vizio, e peccato, dove pos-
O 3 sa
/ BEGIN PAGE 214 /
sa credere d’ avere più offeso. Boccacc. n. 2.
Credendomi aver costui convertito.
Trattare . Passav. Di questo parleremo più
distesamente, quando tratteremo della contri-
zione .
Disputare . Maestruzz. Commette sacrilegio
item chi disputa del giudizio del Principe .
Dubitare . Bocc. Potete comprendere, cia-
scuna di noi di se medesima dubitare .
Mormorare. Bocc. Di che la giovane mor-
morava anzi che no.
Proporre . Bocc. Propose di tornare a Pa-
rigi .
Lasciare. Bocc. Io per niuna cosa lascerei
di Cristian farmi .
Cominciare . Bocc. Cominceráne a bere un
buon bicchier grande per volta .
Provvedere . Passav. f. 4. Solamente d’ uno
refuggio ha provveduto il misericordioso Id-
dio .
Meritare . Bocc. Meritò questa donna , per
lo suo valore , di eßere amata da un nobile ,
e gran Barone .
Godere . Boccacc. In se medesimo godeva di
queste parole .
Ridere . Bocc. Molto avean le donne riso
del cattivello di Calandrino .
Fremere. Boccacc. D’ ira, e di cruccio fre-
mendo .
Languire . Passav. f. 225. Ben vuole Iddio ,
che
/ BEGIN PAGE 215 /
che ogni uomo ne viva innamorato, e langui-
sca di lei.
Spasimare . Bocc. Oltre agli altri suoi do-
lori , credette di sete spasimare.
Appendice prima .
Ha quest’ ordine molti Verbi di partico-
lare osservazione . Ecco i più notabili.
Pensare per giudicare . Bocc. Si pensò il
detto Meßer Musciatto , costui dovere esser ta-
le , quale la malvagità de’ Borgognoni il ri-
chiedea .
Pensare per determinare. Bocc. Pensò quel-
li commettere a più persone .
Porre si usa per deliberare . Franc. Sacch.
Fra loro hanno posto d’ uccidermi .
Fare si adopera per disporre. Boccacc. Di
Guiscardo ho io già preso partito che far-
ne , ma di te , sallo Iddio, che non so che
farmi .
Tenere si usa per aver qualità. Bocc. Te-
nendo egli del semplice , era molto spesso fat-
to capitano de’ Laudesi . Dante . Ma quello in-
grato popolo maligno , Che discese di Fiesole ab
antico, E tiene ancor del monte , e del maci-
gno , Ti si farà, per tuo ben far , nimico .
Argomentare per pensare . Bocc. Donde ar-
gomentate di darlami tale , che mi piacerà =
S’ argomentò di fornirlo come potesse .
Infignersi per dissimulare . Bocc. Come sa-
vio s’ infinse di queste cose niente sentire .
O 4 Rifi-
/ BEGIN PAGE 216 /
Rifinare per desistere. Bocc. Nè di piagne-
re la sua sventura, e quella di Pietro non
rifinò.
Mancare si usa in senso del destitui , defi-
cere, carere de’ Latini . Bocc. Non volendo
della sua fe mancare, sel fece chiamare =
Trovandola molto leggieri, assai mancò della
sua speranza . Stor. Eur. Gli Ungheri comin-
ciarono a mancar d’ animo. Serd. Stor. Alcu-
ni paesi mancano d’ ulivi.
Vivere per nutrirsi. Bocc. Se tu fai così ,
di che viverem noi?
Degnare vale mostrar d’ apprezzare altrui .
Petrar. Ella non degna di mirar sì baßo . E
con ellissi preso al Passav. Ella non degna sì
basso . Nell’ uso vi s’ appone l’ accompagna-
verbo. Casa . Supplico V. M. , che si degni d’
udirlo .
Osare vale ardire ; ma si truova quasi sem-
pre col solo infinito dopo, e senza la par-
ticella di . Bocc. g. 7. n. 5. Non osava farsi ad
alcuna finestra .
Usare vale costumare . Bocc. g. 2. n. 2. E
voi, gentiluomo, che orazione usate di dire ?
Appendice seconda .
A quest’ ordine appartengono i seguenti
modi di dire.
Amar meglio per voler piuttosto , frase
Franzese . Bocc. Io amo molto meglio di di-
spiacere a queste mie carni , che faccendo agio
loro,
/ BEGIN PAGE 217 /
loro , io facessi cosa, che potesse essere perdi-
zione dell’ anima mia .
Sofferir l’animo , o ’l cuore vale aver ani-
mo. Bocc. Come ti sofferiva l’ animo di dir
di lei, sentendoti quel medesimo aver fatto ,
che ella fatto avea ? = Poichè a me non sof-
fera il cuore di dare a me stessa la morte ,
dallami tu .
Essere bene o male di alcuno vale essere in
sua grazia , o disgrazia. Bocc. Perchè mal
dell’ amore della donna era , Podestà chiamato
di Modona , v’ andò. Gio. Vill. Tutta questa
rovina avvenne al Legato , perch’ era male co’
Fiorentini, che se fosse stato bene di loro, la
sconfitta, ch’ ebbe a Ferrara la sua gente, non
avrebbe avuta .
Sentire per aver qualità . Bocc. Io , il qual
sento dello scemo anzi che no , più vi debbo
eßer caro . Senec. Pist. Come il sapore del vi-
no vecchio , che per vecchiezza sente d’ amaro.
Sentir di se vale aver senso . Bocc. Io son
tutto divenuto sì freddo, che appena sento di
me .
Passar di vita vale morire . Bocc. Dopo
non guari spazio passò della presente vita .
Morir di checchessia vale esserne fieramen-
te innamorato . Firenz. Trinuz. Alessandro
muor di quella Vedova . E così morir di vo-
glia , di fame , di sete , di sonno , e simili .
Morir di suo male vale morir di morte na-
tura-
/ BEGIN PAGE 218 /
turale. Gio. Vill. Al detto assedio di Pado-
va morì Uguiccione della Faggiuola di suo
male .
Fallir della promessa vale mancar di paro-
la . Gio. Vill. Della quale promessa fallì , sic-
come fellone , e traditore.
Passarsi d’ un fallo vale dissimularlo . Boc-
caccio. Avvisò di volersi del fallo commesso
da lui mansuetamente passare .
Terzo Ordine de’ Neutri.
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
un dativo esprimente oggetto|, o fine .
Eccone alquanti.
Pensare . Boccacc. A’ suoi nuovi disii fiera-
mente pensava .
Badare . Bocc. Il che tantosto sepper quel-
le , che a ciò badavano .
Provvedere. Bocc. g. 7. n. 3. Alle quali
cose Iddio provegga.
Parere . Bocc. Non so se a voi quello se
ne parrà , che a me ne parrebbe.
Credere . Bocc. Credi tu , ch’io creda agli
abbajatori.
Consentire . Bocc. Ch’ essa a questo avesse
consentito .
Piacere , e dispiacere. Passav. f. 31. Allora
possiamo credere di piacere a Dio, quando di-
spiacciamo a coloro, che dispiacciono a lui.
Ardi-
/ BEGIN PAGE 219 /
Ardire. Bocc. g. 2. n. I. Di se medesimi
dubitando , non ardivano ad ajutarlo .
Giovare , e nuocere . Bocc. Non solamente
non gli giovavano , anzi pareva , che gli no-
cessero.
Contrastare . Bocc. Contrasta in questo co-
minciamento alla tua libidine.
Apparire . Bocc. Lorenzo le apparve nel
sonno , pallido , e tutto rabbuffato.
Giucare . Bocc. Chi andò a dormire , e chi
a giucare a scacchi .
Avanzare . Bocc. Io che doveva fare , o
debbo di quel , che gli avanza?
Abbisognare per opus esse. Bocc. Proem.
Ho meco stesso proposto di volere , se non a co-
loro , che me atarono, alli quali per avven-
tura per lo lor senno , o per la loro buona ven-
tura non abbisogna , a quegli almeno , a’ qua-
li fa luogo , alcuno alleggiamento prestare .
Mancare . Bocc. Niuna cosa è mancata a
questo convito .
Disdirsi . Bocc. g. 6. n. I. in princ. Più al-
le donne , che agli uomini il molto parlar si
disdice .
Restare . Bocc. Gran peso mi resta, se io
vorrò con una bella novella contentarvi .
Soggiacere . Bocc. Agli uomini dobbiamo ,
sommamente onorandogli , soggiacere .
Succedere per venir dopo . Passav. Succeden-
do l’ un pensiero all’ altro , forte tentazione
commoße il cuor suo .
Suc-
/ BEGIN PAGE 220 /
Succedere per ereditare . Maestruzz. Il ma-
rito succede alla moglie , e guadagna la dota .
Supplire si trova di quest’ ordine . Bocc.
Filoc. l. 6. num. 181. Io con nuova nota sup-
plirò al difetto .
Appendice prima .
Ha quest’ ordine molti Verbi di particola-
re osservazione . Eccone alquanti.
Giovare per dilettare , piacere . Bocc. Poi-
chè Filostrato ragionando in Romagna è entra-
to , a me per quella similmente gioverà d’ an-
dare alquanto spaziandomi .
Aggradire , e aggradare per piacere . Boc-
caccio . Tempo è , che per me si faccia quel-
lo , che vi aggradirà = Prendila adunque ,
s’ ella t’ aggrada , io te ne priego .
Valere per giovare . Bocc. Nè l’un mi var-
rebbe , nè l’ altro voglio , che mi vaglia .
Putire per dispiacere . Bocc. Se ne gli da-
rebbe sì fatta gastigatoja , che gli putirebbe .
Sospirare per desiderare. Dante . A voi de-
votamente ora sospira L’ anima mia .
Aprire si usa neutralmente , e significa in-
trodurre uno nella casa , nella Città, o al-
tro. Matt, Vill. Onde per paura gli aprirono.
Garrire vale sgridare . Passav. f. 63. Ve-
nendo ciò a notizia del padre , garrinne alla
figliuola , ed ebbelane in odio .
Bastare , oltre all’ essere a sufficienza , si-
gnifica ancora avere idoneità , o tempo per
fare
/ BEGIN PAGE 221 /
fare una cosa , mettendo la persona in no-
minativo . Bocc. E bastimi d’ essere stato una
volta schernito = Molto più si conviene nelle
scuole tra gli studianti , che tra noi , le qua-
li appena alla rocca, e al fuso bastiamo.
Stare per toccare. Bocc. A voi , Madon-
na , sta omai il comandare .
Soprastare per indugiare. Bocc. Delle set-
te volte le sei , soprastanno tre, o quattro an-
ni più , che non debbono , a maritarle .
Penare per indugiare , o aver difficultà .
Bocc. Mentre ch’ io penerò a uscir dell’ arca,
egli se n’ andranno pe’ fatti loro .
Prendere si usa per cominciare. Bocc. g. 2.
n. 7. Lasciatami prestamente , presero a fug-
gire .
Sostenere per reggere, resistere. Franc. Sac-
ch. Volendo vedere come sostiene al bere , il
fa provare con un gran bevitore suo fami-
glio .
Usare per frequentare. Bocc. n. I. A Chie-
sa non usava giammai.
Appendice seconda .
Appartengono a quest’ ordine le seguenti
forme di dire .
Ridere a uno vale mostrarsegli amico per
ingannarlo . Vit. SS. Pad. Ella mi cominciò a
mostrare amore , e ridermi , e presentarmi.
Esser presto vale esser pronto . Bocc. g. 2.
n. I. Signor mio , io son presto a confessarvi
il vero . Sa-
/ BEGIN PAGE 222 /
Saper grado vale avere obbligazione . Boc-
caccio. Signori, di ciò, che jersera vi fu fat-
to , so io grado alla fortuna . Liv. M. Non ne
seppono nè grado , nè grazia allo ’mperadore .
Star bene allo vale convenire . Bocc. Io
non son fanciulla , alla quale questi innamora-
menti steano oggimai bene.
Vale anche meritare. Bocc. Avvegnachè ,
egli mi stea molto bene, ch’io non la dovea
mai lasciar salir di sopra .
Vale parimente essere ben disposto . Bocc.
Mi stanno bene le gambe in sulla persona =
Eßendo egli bianco , e biondo , e leggiadro mol-
to , e standogli ben la vita .
Tornar bene per essere di utile , o di pia-
cere . Senec. de’ benef. Varchi . Coloro , i qua-
li sono grati , perchè torna loro bene così ,
non sono grati, se non quando , e quanto tor-
na ben loro .
Tornare per riuscire . Bocc. Cominciò a du-
bitare , non quel suo guardar così fiso moves-
se la sua rusticità ad alcuna cosa, che vergo-
gna le potesse tornare .
Venire a grado per piacere . Bocc. Lo in-
cominciò a servire sì bene , e sì acconciamen-
te , ch’ egli gli venne oltremodo a grado .
Venire in concio per essere opportuno . Boc-
caccio . Se ’l maestro non l’ ha riposta in ca-
sa , verrà troppo in concio a’ fatti nostri .
Venir meno per mancare, e fuggir l’ animo
nel
/ BEGIN PAGE 223 /
nel medesimo senso . Bocc. Quasi come se il
mondo sotto i piedi le fosse venuto meno , le
fuggì l’ animo .
Venir meno per mancar di parola . Bocc.
Rispose, se averla promessa a Pasimunda no-
bile giovane Rodiano , al quale non intendeva
venir meno .
Voler bene, o meglio per amare. Bocc. Do-
ve non era niuno grande , nè piccolo , nè dot-
tore , nè scolare , che non mi volesse il meglio
del Mondo .
Voler bene idiotismo per esprimere guasta-
mento , o disordine . Bocc. Con le pugna tut-
to il viso gli ruppe , nè gli lasciò in capo ca-
pello , che ben gli volesse . Cioè che non fos-
se scompigliato.
Correre agli occhi , alla vista &c. vale ab-
battersi a vedere &c. Bocc. n. 7. Il primo uo-
mo , che agli occhi gli corse, fu Primaßo =
E Amet. Alla vista gli corse il viso della
madre . E Fiamm. E come alcun bel volo , o
notabil corso vedea , così mi correa alla boc-
ca : o Panfilo , ora ci fossi tu qui a vedere .
Dante. E tanto buono ardire al cor mi cor-
se , Ch’ i’ cominciai come persona franca .
Quar-
/ BEGIN PAGE 224 /
Quarto Ordine de’ Neutri .
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
uno accusativo , non già veramente pa-
ziente , ma o un Verbale , o simile spiega-
tivo dell’ azione o qualità del suggetto : ov-
vero un nome , che accenni puro mezzo di
azione transitiva imperfetta . Eccone alquanti .
Vivere . Bemb. Asol. Questa vita , che noi
viviamo , di fatiche innumerabili è piena .
Dormire . Petrar. Dormito hai , bella Don-
na , un breve sonno .
Sognare . Nov. ant. 10. Giacendo il Re so-
lo , si sognò un grave , è maraviglioso sogno .
Errare . Comm. Inf. Il sonnoglioso molto er-
ra la via .
Durare . Bocc. Voi potete mal durar fatica .
Camminare . Firenz. Luc. A me pare , che
nel camminare assai viaggio , non sia altro pia-
cere , che quando il pellegrino arriva in quel
luogo , dov’ egli desidera .
Correre . Boccacc. Io , il quale ho corsi di-
versi , e dolenti mari . Gio. Vill. I France-
schi entrati dentro corsero la terra sanza nul-
lo contasto .
Simigliare . Petrar. Che sol se stessa , e
null’ altra simiglia .
Appendice prima .
Il Verbo potere si può ridurre a quest’ or-
dine,
/ BEGIN PAGE 225 /
dine , perchè il caso , che ha dopo di se ,
non ha forza di accusativo paziente , ma è
termine di relazione alla qualità del sugget-
to ; e l’ azione circa questo termine è accen-
nata dal Verbo in potenza , non già in at-
to . Quindi il Verbo potere il più ha dopo
di se l’infinito . Bocc. Introd. Voi potete così com’
io molte volte avere udito . E g. 4. in princ.
Nè noi possiamo dimorar colle muse . E tal-
volta si tace l’ infinito . Bocc. Sempre non può
l’ uomo un cibo , ma disidera di variare . Vi
s’ intende sofferire . Firenz. Asin. Io era un’ asi-
naccio , che non poteva la vita . Vi s’ intende
reggere .
Appendice seconda .
Menar la vita , o i giorni son modi ap-
partenenti a quest’ ordine , e vagliono il La-
tino vitam , aut dies ducere . Bocc. Fiamm.
In così lieta , e giojosa vita menava i gior-
ni miei . Grad. S. Girol. E‵ Signore di tutti
coloro , che buona vita menano .
Durare si usa per sostenere , mantenere .
Gio. Vill. l. 5. c. 34. I Sanesi non potendo più
durar la guerra co’ Fiorentini , richiesero pa-
ce . E l. 9. c. 125. Alla fine si partiron sen-
za combattere , perchè quel di Baviera non
poteva durar la spesa .
P Quin-
/ BEGIN PAGE 226 /
Quinto ordine de’ Neutri .
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
uno accusativo colle preposizioni ad , per ,
o in , che accenni movimento ad alcun ter-
mine , o fine . Eccone alquanti .
Andare . Bocc. g. 3. n. 5. Messer Francesco
è per andare infra pochi dì a Melano = E n. 4.
Andava per gli campi certe erbe cogliendo =
E n. I. Ser Ciappelletto n’ andò in Borgogna .
Quando il termine del movimento è per-
sona , si può usare indifferentemente a , e
da . Bocc. g. 2. n. 3. Partitami di casa mia ,
al Papa andava , che mi maritasse . E g. 3
n. 6. Adunque andatevene da lui .
Venire ha le medesime costruzioni di an-
dare .
Arrivare . Bocc. Arrivò a Genova un va-
lente uomo di corte , e costumato . Petrar. Da se
stessa fuggendo , arriva in parte , Che fa ven-
detta, e ’l suo esilio giocondo .
Ascendere Verbo non usato dal Boccaccio ,
che usa in sua vece salire . Petrar. E così
n’ ascendemmo in loco aprico . Firenz. Disc. I
grandi onori , a’ quali era asceso il bue .
Aspirare . Guicciardini . Noi aspiriamo al-
la monarchia d’ Italia .
Correre . Bocc. g. 2. n. 5. Corse a dirlo al-
la donna ; la quale corsa alla sua camera pre-
stamen-
/ BEGIN PAGE 227 /
stamente , cercò , se i suoi panni v’ erano . E
g. 4 n. I. Venuto se’ alla fine , alla quale cia-
scun corre .
Incorrere . Bocc. lett. Pin. Ross. In quella me-
desima infamia incorse , nella quale voi di
essere incorso ora vi gravate .
Entrare . Bocc. In quel medesimo casolare
se n’ entrarono = Con lei delle cose state entrò
in parole = Ricominciato il pianto entrò in uno
amaro pensiero .
Appendice prima .
Ci sono i seguenti Verbi di particolare
osservazione .
Andare in significato di riuscir male rice-
ve la preposizione in , e si dice : andare in
rovina , in conquasso , in malora &c. Talvolta
ammette la preposizione a per proprietà di
linguaggio . Bocc. Che l’ anima d’ un sì va-
lente , e savio uomo , per difetto di fede , an-
dasse a perdizione .
Trarre presso i Toscani si usa per accor-
rere , concorrere . Nov. ant. 90. Avea fatta
una fine crostata d’ anguille , ed avevala mes-
sa nella madia Poco stante vide entrare uno
topo per la finestrella , che trasse all’ odore .
Bocc. g. 5. n. 10. Gridando, e difendendolo , fui
cagione , che quivi de' vicini trassero . E g. 9.
n. 5. Quasi al romor venendo, colà trassero .
Entrare quando significa cominciamento di
azione, o di stato riceve la preposizione a .
P 2 Bocc.
/ BEGIN PAGE 228 /
Bocc. Lo abate , co’ due Cavalieri , e con Ales-
sandro , senza più , entrarono al Papa , e fat-
ta la debita reverenza, così cominciò lo aba-
te a favellare . Passav. f. 32. Non acconsen-
tendo a’ prieghi , nè alle lagrime della madre ,
entrò alla Religione .
Mettere si usa per isboccare . Gio. Vill. Per
la giunta di più fiumi , che di sotto a Firen-
ze mettono in Arno .
Tornare si usa per ridondare . Bocc. Ogni
vizio può in grandissima noja tornare di co-
lui , che l’ usa.
Pontare vale spignere con forza . Bocc. Ed
egli steßo ( cominciò ) a pontar col capo nel
coperchio dello avello .
Pendere si usa per inclinare . Gio. Vill. Pa-
rea loro , che pendesse in parte Guelfa .
Ricoverare val rifuggire . Bocc. g. 7. n. 4.
Come vide correre al pozzo , così ricoverò in
casa , e serrossi dentro .
Tirare si usa per aver la mira . Bocc. Tut-
ti quasi ad un fine tiravano assai crudele .
Venire si usa per incorrere . Bocc. Venne in
tanto dolore , che quasi fu per gittarsi dalla
torre in terra .
Aggiugnere si usa per arrivare . Bocc. g. 10.
n. 3. Quando aggiugnerò io alla liberalità del-
le gran cose di Natan ?
Appendice seconda .
Appartengono a quest’ ordine i seguenti mo-
di di dire.
Esse-
/ BEGIN PAGE 229 /
Essere a una persona , o a un luogo vaglio-
no venire , arrivare . Bocc. g. 5. n. 5. I pa-
renti dell’ una parte , e dell’ altra furono a lui ,
e con dolci parole il pregarono . E n. 7. Ad un
suo luogo , al quale Primasso pensò di poter
essere , movendosi la mattina a buon’ ora , ad
ora di mangiare .
Essere al mondo vale starsi laico , o al se-
colo . Bocc. g. 5. n. 10. Se io non avessi vo-
luto essere al mondo , io mi sarei fatta mona-
ca. E g. 4. nel princ. Si dispose di non voler
più essere al mondo , ma di darsi al servigio
di Dio .
Andare per una persona, o cosa vale an-
darla a prendere . Bocc. g. 2. n. I. Il quale
coloro , che per lui andarono , trovarono anco-
ra in camicia dinanzi al giudice . E g. 8. n. 2. ,
parlando di danari : Se voi non gli avete , e
voi andate per essi .
Stare per alcuno vale dipendere alcuna co-
sa da lui . Bocc. Per me non istarà mai cosa ,
che a grado ti sia = Pregandolo , che se per
lei steße di non venire al suo contado , gliele
significasse .
Ritornar sopra capo vale tornare in dan-
no . Bocc. Alla quale la sua beffa, pressochè
con morte essendo beffata , ritornò sopra ’l
capo .
Venire a capo vale conchiudere . Bocc. g. 6.
n. 10. Furono tante , che se io ve le volessi
P 3 tut-
/ BEGIN PAGE 230 /
tutte contare , non ne verrei a capo in parec-
chi miglia .
Sesto Ordine de’ Neutri .
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
uno ablativo colle preposizioni in , o con ,
semplici , o articolate , col significato , o del-
la persona compagna nell’ azione , o della
materia , o del luogo continente . Eccone al-
quanti .
Parlare. Bocc. Voi mi prometteste di far-
mi parlare colla donna vostra , e voi mi ave-
te fatto parlare con una statua di marmo .
Conversare. Cavalc. specch croc. Quelle
genti pagane , colle quali avevano a conver-
sare .
Conferire . Bocc. D’ ogni cosa colla Rei-
na , e colla nuora di lei conferendo .
Litigare. Cavalc. med. cuor. Non litigare
coll’ uomo linguoso .
Scherzare . Franc. Sacch. Non ischerzar
coll’ orso , se non vuogli esser morso .
Errare . Bocc. g. 6. n. I. Spesso ne’ nomi er-
rando .
Perseverare . Bocc. Perseverò in questo lau-
devol costume .
Digiunare Bocc. Ogni settimana tre dì almeno
fosse uso di digiunare in pane , e in acqua .
Abitare . Boccacc. Il quale in Trivigi abi-
tava .
Ca-
/ BEGIN PAGE 231 /
Capire, o capere. Bocc. Via , faccialevisi un
letto tale , quale egli vi cape. E g.6.n.6. Secondo-
chè nell’ animo gli capea . E si noti , che que-
sto Verbo non si usa mai attivo alla manie-
ra de’ Latini , ma sempre neutro .
Dimorare . Bocc. Nel picciolo circuito delle
lor camere racchiuse dimorano .
Appendice prima .
Ci sono i seguenti Verbi di particolare
osservazione .
Cadere si usa per venire . Bocc. g. 2. n. 2.
Caddero in sul ragionare delle orazioni , che
fanno gli uomini a Dio .
Comporre si usa per restare in appuntamen-
to. Bocc. Con lui compose , che la seguente
notte v’ andasse .
Convenire coll’ accompagnaverbo si fa di
quest’ ordine . Boccacc. Considerando , quanto
grave cosa sia a poter trovare chi co’ suoi co-
stumi ben si convenga .
Conversare , altresì coll’ accompagnaverbo ,
si trova di quest’ ordine . Stor. Barl. Io disi-
dero sopra tutte l’ altre cose d’ andar là , ove
abita Barlaam , e conversarmi con lui .
Dimorare si trova pure in simil maniera .
Bocc. Io voglio di grazia da voi , che vi deb-
ba piacere di dimorarvi tacitamente qui con
mia madre .
Stare si usa per consistere , Passav. In que-
P 4 sto
/ BEGIN PAGE 232 /
sto sta la dignità , e l’eccellenza della Vergi-
ne Maria sopra gli altri Santi .
Tenere si usa per aderire . Bocc. Tutta l’
Isola si divise , e chi tenea coll’ uno , e chi
coll’ altro .
Usare per conversare . Boccaccio g. 8. n. 9.
Quanto più uso con voi , più mi parete sa-
vio.
Appendice seconda .
Sono da notarsi i seguenti modi di dire.
Essere in su una cosa vale applicarvisi .
Bocc. g. 6. nel fine . Comandò , che ogni uo-
mo fosse in sul ballare .
Dispensare con uno vale disobbligarlo dal-
la legge comune . Bocc. Andiamo noi con esso
lui a Roma ad impetrare dal Santo Padre,
che nel difetto della troppa giovane età dispensi
con lui , e appresso nella dignità il confermi .
Risieder bene vale star convenientemente .
Passav. f. 192. Quanto la persona è maggio-
re , e di maggiore dignità , tanto meglio in lei
risiede , e più chiaramente risplende la vertù
dell’ umiltà .
Stare , coll’ espressione del prezzo , vale
costare , e pare che si costruisca coll’ ablati-
vo senza preposizione . Lorenz. de’ Medic.
Arid. Subito la vo’ vendere , s’ io la dovessi
dar per manco due fiorini , ch’ ella non mi sta .
Set-
/ BEGIN PAGE 233 /
Settimo Ordine de’ Neutri .
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
uno ablativo colle preposizioni , o sieno
segnacasi da , o di . I Verbi significanti mo-
to da luogo , o liberazione da alcuna cosa
sogliono ricevere il di, e gli altri il da . Ec-
cone alquanti .
Col Da.
Scampare . Bocc. g. 4. n. 10. tit. Egli scampa
dalle forche.
Nascere . Bocc. Dalle quali cose nacquero
diverse paure .
Derivare . Cron. Morell. Da questi sette ,
ch’ i’ t’ ho nominati , ne derivano assai danni .
Dipendere . Gio. Vill. Da voi dipende l’a-
nima di coloro .
Degenerare . Bocc. Nobile uomo fu il tuo
padre , dal quale tu non vuogli degenerare .
Dissentire . Guid. G. Dalla loro parte espres-
samente dissentirono .
Col di .
Uscire . Bocc. Poichè voi ben vi sentite ,
tempo è d’ uscire d’ infermeria .
Partire . Se il termine , donde altri si par-
te , non è persona , si suole usare col di .
Bocc. g. 7. n. 3. Innanzi ch’ io mi parta di qui ,
voi vedrete il fanciul sano . E g. 2. n. 3 Ales-
sandro dell’ Isola non si partiva . Ma se il ter-
mine
/ BEGIN PAGE 234 /
mine è persona , si suole adoperare il da .
Bocc. g 2. n. 8. I fanciulli da lui partire non
si volevano . E si noti , che questo è uno de’
Verbi , che nella lingua Toscana non suole
adoperarsi senza l’ accompagnaverbo .
Fuggire si usa colla stessa regola di parti-
re . Bocc. g. 4. n. 5. Gli occhi le parevano del-
la testa fuggiti . Passav. Contrastate al Diavo-
lo , e fuggirà da voi .
Cadere. Bocc. g. 2. n. 5. Niuno male si fe-
ce nella caduta , quantunque alquanto cadesse
da alto .
Guarire. Dante Inf. cant. 27. Ma come Co-
stantin chiese Silvestro Dentro a Sirati a gua-
rir della lebbre , Così mi chiese questi per
maestro A guarir de la sua superba febbre .
Appendice.
Ci sono i seguenti Verbi di particolare os-
servazione .
Deviare si usa per degenerare . Bocc. Io non
intendo deviare da’ miei paßati .
Muovere si usa per nascere , cominciare ,
procedere , o uscire. Bocc. Amor la vaga lu-
ce , Che muove da’ begli occhi di costei , Ser-
vo m’ ha fatto. Matt. Vill. l. 3. c. 96. La
qual via muove dal Castello di Prato, fatto
anticamente per lo Imperadore , e viene infino
alla porta .
Ritrarre da uno vale somigliarlo . Franc.
Sacch. Da quell’ antica madre non ritrai, Ch’
al
/ BEGIN PAGE 235 /
al mondo dimostrò la sua potenza . E i Tosca-
ni soglion dire d’ un figliuolo : E’ ritrae dal
padre , o dalla madre , cioè gli somiglia .
Variare si usa per essere differente . Bocc.
Quantunque in vestimenti , e in onori alquanto
dall’ altre variino , tutte perciò son fatte qui,
come altrove .
CAP. VI.
Della costruzione de’ Verbi Neutri
passivi .
TRe sono le particelle , che dimostrano il
Verbo neutro passivo , cioè mi , ti , si ,
le quali accennano quel riverbero , o sia ri-
torno dell’ azione nel suggetto , il quale fa
che il Verbo senta del passivo . Contuttociò
gli Autori del buon secolo spessissime volte
adoperano tali Verbi senza particella alcu-
na , come dagli esempj delle seguenti rego-
le si vedrà : e ciò sembra essere una pro-
prietà , e , per così dire , un vezzo della lin-
gua Toscana .
PRI-
/ BEGIN PAGE 236 /
PRIMO ORDINE DE’ NEUTRI PASSIVI.
I Verbi di quest’ ordine sono assoluti , nè
hanno dopo di se caso alcuno proprio ,
benchè possano avere una preposizione col
suo caso . Ecco i più notabili , col modo di
usarli , colle particelle, o senza .
Adombrare si dice delle bestie , che pren-
dono ombra . Bocc. Per ventura v’ ebbe un
mulo , il quale adombrò .
Addormentarsi . Bocc. Si addormenta per le
taverne .
Affogare , comunemente affogarsi. Gio. Vill.
Le terre affogarono sì , che più anni appresso
quasi non fruttarono .
Affondare . Gio. Vill. Più galee delle sue
affondarono in mare colle genti.
Agghiacciare . Bocc. Credi tu , che io , se
quel ben gli volessi , che tu temi , sofferissi ,
ch’ egli stesse laggiù ad agghiacciare ?
Aggiornare, e annottare . Petrar. Ma den-
tro , dove giammai non s’aggiorna , Gravido fa
di se il terrestre umore . Dante . Ma quando
s’ annotta . Ariost. Cavalca e quando annot-
ta , e quando aggiorna , Alla fresc’ alba , e all’
ardente ora estiva .
Aggravare. Bocc. Io temo , ch’ egli non ag-
gravi tanto nella ’nfermità , la quale ha , che
poi
/ BEGIN PAGE 237 /
poi ne siegua cosa , per la quale io il
perda .
Ammalarsi. Gio. Vill. Federigo Imperadore
si ammalò forte = Carlo il grosso ammalò per
modo , che quasi era perduto .
Ammutolire . B. Jacop . Ond’ io , s’ i’ vo’ par-
lare Di te , ammutolisco .
Annegarsi. Dante . E quella s’ annegò coll’
altro incarco . Gio. Vill. Tiberino annegò nel
fiume d’ Albula , passandolo .
Arrossare , arrossire . Bocc. La donna tutta
di vergogna arrossò. Casa Galat. Chi si di-
letta di fare arrossire altrui .
Impigrire . Mor. S. Gregor. Acciocchè la lor
mente per negligenza non impigrisca .
Impoverire . Bocc. Tre giovani male il lo-
ro avere spendono, impoveriscono.
Infermare . Bocc. La Reina di Francia in-
fermò gravemente .
Ingrandire . Gio. Vill. Vennero in grazia
della Chiesa, e ingrandironne molto .
Invecchiare . Petrar. Che gran duol rade vol-
te avvien , che ’nvecchi .
Ingravidare . Bocc. La donna da capo ingra-
vidò .
Insolentire . Tacit. Davanz. Mentre brutta-
mente i capi contendono, l’esercito insolentì .
Prosperare . Bocc. La quale egli poteva ve-
dere , siccome santa , e buona, sempre prospe-
rare , ed aumentarsi .
Rinno-
/ BEGIN PAGE 238 /
Rinnovare . Boccaccio . Non perde ventura ,
anzi rinnuova , come fa la luna .
Sbigottire . Bocc La donna , senza sbigottir
punto , con voce assai piacevole rispose. Pe-
trar. Onde si sbigottisce, e si sconforta Mia
vita in tutto .
Spedirsi. Bocc. Al Negromante disse , che si
spedisse.
Appendice prima .
Ci sono i seguenti Verbi di particolare os-
servazione .
Annighittire vale divenir neghittoso . Pas-
sav. f. 47. Esercitanlo, e non lo lasciano an-
nighittire, ed essere ozioso .
Apporsi vale indovinare . Malmant. cant. 2.
st. 75 E venne immaginandosi, e s’ appose,
Ch’ ella fosse sua moglie , ei suo marito .
Diportarsi vale ricrearsi. Bocc. Poichè al-
quanto diportati si furono , l’ ora della cena
venuta , con festa , e con piacere cenarono .
Disertarsi vale andare in rovina . Bocc. Se
spacciar volle le cose sue , gliele convenne git-
tar via , laonde egli fu vicino al disertarsi .
Esercitarsi vale passeggiare . Bocc. Lo sco-
lare , andando per la corte , s’ esercitava per
riscaldarsi .
Muovere si usa per muoversi . Petrar. Or
muovi , non smarrir l’altre compagne .
Rimanersi vale cessare . Bocc. Vanno ad in-
cantare con una orazione , ed il picchiar si rima-
ne.
/ BEGIN PAGE 239 /
ne . Gio. Vill. Per gufi , che nelle bocche di
quelle trombe fecero nido , si stopparo i detti
artificj per modo , che rimase il detto suono .
Riposarsi vale parimente cessare . Boccacc.
Riposandosene già il ragionare delle donne ,
comandò il Re a Filostrato , che procedesse .
Risentirsi vale svegliarsi. Bocc. La giova-
ne prima , che alcun de’ suoi, si risentì .
Sentirsi vale aver senso . Passav. S. Bernar-
do dice , che ’l membro stupido , e che non si
sente, è più lungi dalla salute .
Appendice seconda .
Appartengono a quest’ ordine i seguenti
modi di dire.
Farsi scorgere vale farsi burlare . Firenz.
Trinuz. Vuo’ tu, ch’ io mi faccia scorgere seco.
Recarsi assolutamente , o coll’ ablativo del-
la persona, o coll’ espression della cagione,
vale pigliare un’ offesa come fatta a se .
Bocc. Checchè egli si abbia di me detto , io
non voglio , che voi il vi rechiate, se non co-
me da uno ubbriaco . Gio. Vill. E recaronsi ,
che gli Aretini avesson loro rotta la pace .
Starsi ha molte significazioni . Si usa per
intertenersi. Bocc. Perciò statti pianamente fi-
no alla mia tornata . E per astenersi da fa-
re . Bocc. Sì è meglio fare , e pentere , che
starsi , e pentersi . E per non parlare . Bocc.
Non rispondeva al figliuolo , ma si stava . E
per non mutare stato. Così nel Boccaccio Mon-
na
/ BEGIN PAGE 240 /
na Giovanna Vedova , stimolata da’ fratelli
a rimaritarsi , disse loro : io volentieri , quan-
do vi piacesse , mi starei , ma se a voi pur pia-
ce , ch’ io marito prenda , per certo io non ne
prenderò mai alcuno altro , se io non ho Fede-
rigo degli Alberighi .
Levarsi diritto si usa dal Boccacc. per quel-
lo , che noi diciamo levarsi in piedi . G. 7.
n. 6. Io mi levai diritta, e come io il volea do-
mandare , chi fosse , e che avesse , ed ecco M.
Lambertuccio venir su . E g. 9. n. I. E pare-
vagli tratto tratto , che il morto si dovesse le-
var ritto , e quivi scannar lui . E g. 5. n. 8.
Levatisi tutti diritti , e riguardando , che ciò
poteße essere , videro la dolente giovane .
Tenersi si adopera in due significati . Prima
per arrestarsi. Nov. ant. Il Re gli chiamò , e
que’ , quando il videro , tennersi . Bocc. Di Fi-
renze usciti , non si tennero , sì furono in In-
ghilterra . E per avere opinione di se . Sen.
Varch Si compiace in se medesimo , e si tiene ,
e , per dir così, è adulatore di se stesso.
Secondo ordine de’ Neutri passivi.
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
un genitivo esprimente la materia dell’
azione Eccone alquanti.
Abbattersi . Passav. f. 239. Abbattesi di dir-
ne alcuna vera , benchè non la sappia per certo.
Accen-
/ BEGIN PAGE 241 /
Accendersi. Bocc. Come disavvedutamente
acceso s’era di lei, saviamente s’era da spe-
gnere .
Accorgersi. Bocc. Più mesi durò , avanti che
di ciò niuna persona s’ accorgeße .
Affrettarsi. Bocc. Quanto può s’ affretta di
celebrare le nozze .
Apparecchiarsi Bocc. g. 4. nel fine. Ciascun
s’apparecchi di dover doman ragionare di ciò.
Attristarsi . Bocc. Della mia lunga dimora
t’ attristi .
Beffarsi , ridersi. Bocc. E di ciò , che avve-
niva, ridersi, e beffarsi , essere medicina certis-
sima a tanto male .
Contentarsi per essere soddisfatto . Bocc. I
suoi uomini pessimamente si contentavano di lei ,
per la sua bassa condizione E per acconsen-
tire. Bocc. Se tu ti contenti di lasciare appreßo
di me questa tua figliuoletta , perciocchè buo-
no aspetto ha , io la prenderò volentieri .
Crucciarsi. Bocc. Se tu di queste cose ti cruc-
ci , io non me ne maraviglio .
Dolersi . Bocc. Della sua prima sciagura , e
di questa seconda si dolse molto .
Gloriarsi . Petrar. Anzi mi glorio D’ esser
servato alla stagion più tarda .
Impacciarsi . Bocc Presupponendo , ch’ essi di
niuno nostro fatto s’impaccino .
Impadronirsi. Tacit. Davanz. S’ impadroni-
rono di quelle terre .
Q Infor-
/ BEGIN PAGE 242 /
Informarsi . Bocc. S’ informano i Sensali e
delle qualità , e della quantità delle merca-
tanzie .
Ingegnarsi . Bocc. In lui t’ ingegna di metter
tenerezza del tuo onore .
Innamorarsi . Boccacc. Di lui ferventemente
s’ innamorò . Nov. ant. Egli innamorò di lei ,
tanto gli parve bella .
Intendersi . Bocc. Io m’ intendo così male de’
vostri nomi , come voi de’ miei .
Lodarsi . Boccacc. Comecchè ogni altr’uomo
molto di lui si lodi , io me ne poßo poco loda-
re io .
Maravigliarsi . Bocc. g. I. n. 5. Quantun-
que di ciò molto si maravigliasse .
Obbligarsi . Bocc. Io mi voglio obbligare di
andare a Genova.
Pentirsi . Bocc. n. I. Perdona egli volentie-
ri a chi si pente d’ averlo bestemmiato .
Ricordarsi . Bocc. Io per me non me ne ri-
cordo .
Scusarsi . Bocc. Di ciò, che intervenuto era,
si scusò .
Vergognarsi . Bocc. Di te stessa vergognan-
doti , per non poterti vedere , t’ avresti cavati
gli occhi .
Appendice prima .
Sono da notarsi i seguenti Verbi di non
tanto nota significazione .
Addarsi vale accorgersi . Cron. Morell. I
Pisa-
/ BEGIN PAGE 243 /
Pisani il sentirono, presero sospetto, e addie-
ronsi del fatto .
Attentarsi vale arrischiarsi . Bocc. Non si
attentava di dir nulla. Passav. f. 160. Fare
imprese , che non fanno , o non attentano di fa-
re gli altri .
Avvisarsi per accorgersi Franc. Sacc. Gen-
tiluomo , avvisiti tu di nessuno , che queste co-
se ti faccia ? E per deliberare Bocc. n. 3. S’ av-
visò di fargli una forza da alcuna ragion co-
lorata .
Brigarsi vale ingegnarsi . Tesor. Brun. Do-
vrebbe ciascheduno brigarsi di saper ben par-
lare . Dante . E brigavam di soverchiar la
strada .
Confortarsi vale concepir fidanza . Boccacc.
Come costei l’ ebbe veduta , così incontanente si
confortò di doverlo guerire .
Conoscersi per intendersi , aver perizia .
Bocc. Per quello , che mi dice Buglietto , che
sai che si conosce così bene di questi panni sbia-
vati . Lib. Mott. S’ io mi conoscessi così di pie-
tre preziose , come io fo d’ uomini , io sarei buon
giojelliere .
Fornirsi per provvedersi . Bocc. g.9.n. 4. Ac-
ciocchè vestir si poteße, e fornir di cavalca-
tura .
Frammettersi , inframmettersi , trammettersi,
intrammettersi vagliono esser mediatore , o
pure ingerirsi . Tratt. Piet. L’ uomo non si fram-
Q 2 metta
/ BEGIN PAGE 244 /
metta di giudicare ciò , che a lui non appartie-
ne . Matt. Vill. l. 8 c. 102. E inframmettendosi
anche il Legato di Romagna di questa materia ,
si rimisono negli ambasciadori. E l. 9. c. 94. Si
tramettea di fare concordia tra loro . Passav.
f. 90. I preti parrocchiani non si possono intra-
mettere de’ peccati , che ’l Vescovo si riserva .
Giovarsi vale approffittarsi. Lib. Astrol. Que-
gli , che si voglion giovare della forza , e del-
la virtù di questo segno .
Gittarsi vale uscire impetuosamente d’ un
luogo . Bocc. Subitamente si gittò di casa per
ajutarla, e corse al pozzo .
Richiamarsi vale dolersi , far querela . Bocc.
Io son venuto a richiamarmi di lui , d’ una va-
ligia , la quale egli m’ ha imbolata .
Ricredersi vale pentirsi, mutar parere . Vit.
Barl. Quando i Vescovi del tempio videro , che ’l
Re si ricredea d’ andare a adorare i loro Id-
dei , sì ebbero grande paura .
Rifarsi vale acquistare , farsi bello &c. Lasc.
Sibill. O come mi rifò io di questo color roso !
Rimanersi vale astenersi . Boccacc. Questo è
mal fatto , e del tutto egli ve ne convien ri-
manere .
Tribolarsi vale affliggersi . Boccacc . Comar
Gemmata non ti tribolar di me , ch’ io sto bene .
Appendice seconda .
A quest’ ordine appartengono i seguenti
modi di dire .
Accon-
/ BEGIN PAGE 245 /
Acconciarsi dell’anima vale prepararsi co’ sa-
gramenti alla morte . Passav. f. 20. Fu indot-
to , che doveße acconciarsi dell’ anima , confes-
sandosi .
Esser tentato vale aver voglia . Boccacc. E
tutto fu tentato di farsi aprire .
Porsi in cuore vale deliberare . Bocc. Io mi
posi in cuore di darti quello , che tu andavi
cercando .
Prendersi dell’amore di alcuno vale innamo-
rarsene . Bocc. n. 5. Sapersi guardare dal pren-
dersi dell’ amore di maggior uomo , ch’ ella
non è .
Rintuzzarsi l’ animo vale distogliersi . Bocc.
Qualche gran fatto de’ essere costui , che ribal-
do mi pare , posciachè così mi s’è rintuzzato
l’animo di onorarlo .
Terzo Ordine de’ Neutri passivi .
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
un dativo , che significhi un termine , il
quale riceva in certo modo l’ azione del Ver-
bo . Eccone alquanti .
Abbattersi . Bocc Colui , che a donna , non
bene a se conveniente , s’ abbatte .
Accordarsi . Bocc. Alla qual cosa il Priore ,
e gli altri Frati creduli s’ accordarono .
Appigliarsi . Petrar. E veggio il meglio , ed
al peggior m’ appiglio.
Q 3 Appros-
/ BEGIN PAGE 246 /
Approssimarsi. S. Grisost. Io m’ approssimo al
peccatore .
Arrendersi . Gio. Vill. S’ arrendeo la Città
a Cerare .
Arrischiarsi. Bocc. Avanti che alcuna s’ ar-
rischiasse a credere che ’l fosse desso .
Avvezzarsi . Bocc. S’ avvezzò a’ cibi del
Monaco .
Confessarsi. Passav. f. 71. S’ andò a confes-
sare al Priore del Monistero di S.Vittore . Si
costruisce talvolta col da per proprietà di
lingua . Bocc. g. 2. n. 8. Divotamente si con-
fessò dall’ Arcivescovo di Ruem .
Obbligarsi. Boccacc. Per belle scritte di lor
mano si obbligarono l’ uno all’ altro .
Opporsi . Bocc. Al qual piacere la fortuna
nemica de’ felici s’ oppose .
Raccomandarsi . Bocc. Raccomandandosi Ca-
landrino al Medico .
Ribellarsi. Passav. f. 46. Coloro , che gli si
ribellano , astenendosi da’ peccati , più aspramen-
te tenta .
Richiamarsi . Bocc. Pensò d’ andarsene a ri-
chiamare al Re .
Appendice prima .
Affarsi vale convenire . Vit. Plut. Ella era
di molti anni , e Demetrio più giovane, che non
le si affaceva .
Apprendersi vale attaccarsi . Dante . Amor ,
ch’al cuor gentil ratto s’ apprende .
Appre-
/ BEGIN PAGE 247 /
Apprestarsi vale apparecchiarsi . Bocc. g. 4.
n. 4. Veggendo di lontan venir le galee, s’ ap-
prestarono alla difesa .
Attenersi si usa per aver fede , stare . Bocc.
Attenendosene Salabaetto alla sua semplice pro-
messione . E per appartenere . Ambra Furt. L’ e-
redità s’ atteneva a me , come più stretto pa-
rente . E per essere parente . Salviati Spin. Ere-
de d’ uno , che non t’ attiene quasi nulla .
Avvenirsi si usa per abbattersi . Bocc. Lo-
dando molto , ovunque con persona a parlar
s’ avveniva , la bella cura , che di lui il Mae-
stro Simone aveva fatta . E per convenire .
Guid. G. Oh come s’ avviene al savio uomo
d’ esser cauto ! E per avere attitudine , e av-
venenza nell’ operare . Firenz. dial. bell. donn.
Se ella va , ha grazia : se ella siede , ha va-
ghezza : se ella canta , ha dolcezza : final-
mente e’ se le avviene ogni cosa maraviglio-
samente .
Darsi si usa per applicarsi . Boccacc. Vit.
Dant. Si diede allo studio e della filosofia ,
e della teologia .
Appendice seconda .
Farsi a un luogo vale sporgersi , affacciarsi .
Boccacc. La vide in capo della scala farsi ad
aspettarlo = Non poßo farmi nè ad uscio , nè
a finestra .
Serbarsi a fare vale indugiare . Bocc. Io in-
tendo di lavorare mentre son giovane, e le fe
Q 4 ste,
/ BEGIN PAGE 248 /
ste , e le perdonanze , e i digiuni serbarmi a
fare quando sarò vecchia.
Quarto Ordine de’ Neutri passivi .
ALcuni pochi Verbi si trovano , che han-
no dopo di se uno accusativo significan-
te qualità del suggetto .
Arrendersi. Passav. f 109. Io ti rassegno le
chiavi del mio officio , e vinta m’ arrendo .
Rendersi . Bocc. Rendendosi in ciò , che po-
tevano, e sapevano , umili , e benigni verso
di lui. Gio. Vill. Rendessi Monaco a Santo
Dionisio .
Farsi in significato di fingersi , o riputarsi .
Bocc. g. 9. n. 2. Essendo stoltissimi , maestri
degli altri si fanno .
Vestirsi. Boccaccio g. 9. n .4. Il fa pigliare
a’ villani , e i panni di lui si veste .
E nell’ uso si sente : io mi confesso vinto ,
io mi veggo perduto , e simili.
Appendice .
Vestirsi si trova col genitivo , o almen col
segno di esso . Nov. ant. 57. Volendo del tut-
to lasciare lo mondo , e vestirmi di drappi di
religione , piacciavi di donarmi una grazia .
Quin-
/ BEGIN PAGE 249 /
Quinto Ordine de’ Neutri passivi .
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
uno accusativo , con preposizione , che
accenni movimento ad alcun termine . Ecco-
ne alquanti .
Abbattersi per incontrarsi , arrivare . Bocc.
S’ abbattè in alcuni, i quali mercatanti parea-
no = S’ abbattè ad un sentieruolo .
Aggirarsi . Pier . Cresc. Per diverse Pro-
vincie m’ aggirai per ispazio di trenta anni .
Avventarsi . Bocc. Un grande , e fiero lu-
po , il quale s’ avventava alla gola di co-
stei = Per lo comunicare insieme , s’ avventa-
va a’ sani . Parla della pestilenza .
Condursi . Bocc. Di quindi marina marina si
condusse infino a Trani . = Quasi da necessità
costretto a scriverle mi conduco .
Convertirsi. Petrar. Subito in allegrezza si
converse La gelosia. E in senso di erogarsi ,
spendersi . Gio. Vill. Montarono le dette
possessioni più di fiorini 15000 , e convertissi a
rifacimento de’ ponti .
Mettersi. Bocc. Essa ad onesto fine a far ciò
si metteva .
Riferirsi . Passav. f. 138. Non si dea in lei
luogo all’ amore di veruna altra cosa , che non
si riferisca a Dio .
Risolversi . Bocc. Laber. Il cuore , non al
tri-
/ BEGIN PAGE 250 /
trimenti che faccia la neve al sole , in acqua
si risolvesse .
Appendice prima .
Sono da notarsi i seguenti Verbi di parti-
colare significazione .
Avvenirsi vale incontrarsi . Boccacc. S’ av-
venne in un luogo fra gli scogli riposto .
Avvolgersi vale andar girando . Boccacc.
Tutto ’l dì per lo salvatico luogo s’ andò av-
volgendo .
Intopparsi vale incontrarsi . Nov. ant. 82.
Questo Romito s’ intoppò in tre grandi scherani.
Recarsi vale ridursi, e così arrecarsi val
condursi . Bocc. Si recherebbe a farlo davan-
ti agli occhi vostri . Gell. Sport. Io rivorrò
la mia dota , e arrecherommi a star da me .
Riserbarsi vale trasferire in altro tempo.
Bocc. Riserbandosi in più comodo tempo le lu-
singhe , cominciò a volerla riprendere .
Scontrarsi vale incontrarsi . Passav. S. Dome-
nico si scontrò in S. Francesco .
Trarsi vale condursi . Bocc. Gli uomini tutti
a riguardar la giovane si traevano.
Appendice seconda .
Andarsene in alcuna cosa vale distruggersi,
risolversi, o propriamente , o figuratamente .
Firenz. Disc. Subito ch’ e’ vide il sole , e’ se n’an-
dò in acqua . Tacit. Davanz. Se n’ andavano
in banchetti i Grandi delle Città .
Levarsi a romore, o in superbia sono mo-
di
/ BEGIN PAGE 251 /
di appartenenti a quest’ ordine . Bocc. Il po-
polo di questa terra , veggendo ciò , si leverà
a romore . Vit. de’ SS. Pad. Non ti levare in
superbia , ma umiliati .
Darsi in su una cosa vale applicarvisi . Boc-
caccio g. 8. n. 6. Calandrino , veggendo , che ’l
Prete non lasciava pagare , si diede in sul
bere .
Sesto Ordine de’ Neutri passivi .
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
uno ablativo con preposizione , il quale
accenna congiugnimento. Eccone alquanti .
Abboccarsi Malmant. S’abbocca appunto con
Baldone steßo .
Accompagnarsi . Bocc. Con li quali ragio-
nando , incautamente s’ accompagnò .
Accordarsi . Boccacc. Con loro accordatesi ,
partefici divennero del podere .
Affaticarsi . Bocc. In che m’ affatico io ?
Confidarsi . Bocc. Nella sua buona , e one-
sta affezion confidandosi .
Congiugnersi . Bocc. Farò , che la mia ani-
ma si congiugnerà con quella .
Consigliarsi . Bocc. Con la sua fante si con-
sigliò .
Contenersi . Bocc. Questa brieve noja , dico
brieve , in quanto in poche lettere si contiene .
Dimesticarsi . Bocc. Gli venne in disiderio
di volersi , se esso potesse , con amenduni , o
con l’ uno almeno , dimesticare .
/ BEGIN PAGE 252 /
Fondarsi . Dante . Quinci si può veder come
si fonda L’eßere beato nell’ atto , che vede .
Imparentarsi . Gio. Vill. S’accordarono con
M. Cane , e imparentarsi con lui .
Intendersi . Boccacc. Discretamente con lui
s’ incominciò ad intendere .
Nascondersi . Bocc. Si nascose in una came-
ra terrena .
Riconciliarsi . Bocc. Disidera di udire buo-
ne novelle del marito , e di riconciliarsi col
suo Tedaldo .
Appendice prima .
Sono degni d’ osservazione i seguenti Verbi .
Acconciarsi vale accomodarsi . Boccacc. Con
lui s’ acconciò per servidore .
Accontarsi vale trattare , accordarsi con uno .
Bocc. Quivi con un ricco mercatante acconta-
tosi , con lui si mise per servidore .
Ricoverare vale rifuggire , e ha senso neu-
tro passivo . Bocc. Come vide correre al poz-
zo , così ricoverò in casa , e serrossi dentro .
Ripararsi vale lo stesso . Bocc. g. 2. n. 8.
Nella Corte del quale il Conte alcuna volta ,
ed egli , e ’l figliuolo , per aver da mangia-
re , molto si riparavano . E senza particella .
Amet Nella quale ( Fiesole ) gran parte ri-
paravano de’ suoi seguaci .
Appendice seconda .
Confidarsi si trova col genitivo di persona .
Bocc.
/ BEGIN PAGE 253 /
Bocc. Lo Abate con un Monaco Bolognese , di
cui egli molto si confidava .
Dirsi con alcuno vale essere suo amico . Ta-
cit. Davanz. Tutta d’ Agrippina un tempo ,
poi non si dicevano punto .
Ritrovarsi con uno vale esser con lui , ac-
compagnarsi . Bocc. Se io senza indugio non
mi ritrovo seco , per certo io me ne credo mo-
rire .
Scontrarsi gli occhi vale vedersi reciproca-
mente . Passav. Che ’l viso , e gli occhi suoi
non si possano iscontrare con quelli del con-
fessore .
Settimo Ordine de’ Neutri passivi .
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
uno ablativo con preposizione , il quale
accenni separazione . Eccone alquanti .
Alienarsi . Matt. Vill. Essendo di natura
Guelfi , per la tirannia erano quasi alienati
dalla Parte .
Appartarsi . Vit. Plut. Eumenio non curava
d’ appartarsi di quivi .
Aßentarsi . Vit. Plut. Non è tempo , che noi
ci doviamo assentare dalla Città .
Astenersi . Bocc. Estimo , che onesta cosa sia ,
che domane dal nostro dilettevole novellare ci
astegnamo .
Contenersi , spiccarsi . Salviat. Granch. Che
se tu
/ BEGIN PAGE 254 /
se tu non hai poter di contenerti di sì piccola
cosa , men forza avresti di spiccarti da lei .
Dilungarsi . Bocc. Nè oltre a due piccole
miglia si dilungarono da essa .
Disciogliersi . Bocc. Di questo amore non
potendo disciogliersi , deliberò di morire .
Disviarsi . M. Aldobr. Non si disviino dal
diritto tramite della ragione .
Appendice .
Si notino i seguenti Verbi di particolare
osservazione .
Mutarsi vale partir d’ un luogo . Bocc. g. 2.
nel fine . Reputo opportuno di mutarci di qui ,
e andarne altrove .
Riposarsi si usa per cessar di fare alcuna
cosa. Bocc. Sogliono similmente , per onor del-
la sopravvegnente Domenica , da ciascuna ope-
ra riposarsi .
Ritrarsi si usa per partir d’ un luogo , o
per distogliersi da una deliberazione . Bocc.
Ordinato , come di quindi si ritraessono, se n’
andarono a Napoli = Avendo disposto di fare
una notabile , e maravigliosa festa in Verona ,
subito , qual che la cagion foße , da ciò si ri-
trasse .
Spacciarsi vale spedirsi . Fiorett. S. Franc.
Il più tosto , che potea , si spacciava da lui .
CAP.
/ BEGIN PAGE 255 /
CAP. VII.
Della costruzione de’ Verbi impersonali .
BEnchè , a parlar con rigore, i soli infi-
niti de’ Verbi possano dirsi veramente
impersonali , perchè per se stessi sono indif-
ferenti a qualunque persona , e niuna deter-
minata ne esigono : contuttociò , uniforman-
doci al modo comune di parlare , chiamere-
mo impersonali que’ Verbi, che si usano so-
lamente nella terza persona , e che dovreb-
bono chiamarsi personali difettivi , ma si chia-
mano impersonali in questo senso , ch’ e’ non
hanno tutte le persone . Di questi Verbi al-
cuni hanno figura attiva , come accadere , al-
tri passiva , come bucinarsi. E si noti , che la
distribuzione degli Ordini negl’ impersonali è
diversa da quella de’ Latini , perchè la no-
stra lingua non ha tutti gl’ impersonali cor-
rispondenti nel caso a quelli della Latina .
PRIMO ORDINE DEGL’
IMPERSONALI .
I Verbi di quest’ ordine sono affatto asso-
luti , e non hanno caso nè avanti , nè
dopo . Ecco i principali , da’ quali si potrà
prender regola per gli altri .
Pio-
/ BEGIN PAGE 256 /
Piovere, tonare . Ciriff. Calvan. E piove-
alfin , quando si speßo tuona .
Nevicare . Bocc. g. 8. n 7. S’ è messa la più
folta neve del mondo , e nevica tuttavia .
Balenare . Dante . Mostrava alcun de’ pecca-
tori il dorso , E nascondeva in men , che non
balena .
Folgorare . Vit. Plut. Folgorò sì forte , che
molti uomini d’arme arse nella folgore .
Grandinare . Bocc. Grandinando tuttavia .
Appendice .
Alcuni de’ suddetti Verbi si trovano col nomi-
nativo , e talvolta ancora con altro caso do-
po Petrar. Sospira , e suda all’ opera Vulca-
no , Per rinfrescar l’ aspre saette a Giove , Il
quale or tuona , or nevica , ed or piove . Gio.
Vill. Innanzichè la battaglia si cominciasse ,
piovve una piccola acqua.
Secondo Ordine degl’ Impersonali .
I Verbi di quest’ ordine hanno avanti di se
un nominativo di cosa espresso , o sottin-
teso . Ecco i più notabili .
Abbisognare, bisognare , ricercarsi , vaglio-
no l’opus eße de’ Latini . Gio Vill. E venis-
sero a Cittade, e in oste quando abbisognasse .
Bocc Come costoro ebbero udito questo , non
bisognò più avanti . Pier. Cresc. In questi co-
tali arbori si ricerca più l’ombra , che ’l frut-
to.
Appa-
/ BEGIN PAGE 257 /
Apparire . Gio. Vill. Mostrando come era
iniqua , come appare per la sua pistola .
Accadere. Bocc. Egli pessimamente , secon-
do le qualità delle persone , e gli atti , che ac-
cadevano , proffereva .
Credersi. Bocc. Credesi , che la marina da
Reggio a Gaeta sia quasi la più dilettevole par-
te d’ Italia .
Convenire . Petrar. Perchè inchinare a Dio
molto conviene Le ginocchia , e la mente . E per
esser necessario . Bocc. n. 100. A che null’ al-
tro rispose , se non che conveniva , che così
fosse . Si usa in figura di personale , ma col
senso d’ impersonale . Bocc. Per certo io il
convengo vedere . Cioè conviene , ch’ io il
vegga . E g. 3. n. 4. Conviensi adunque l’ uomo
principalmente con gran diligenzia confessare
de’ suoi peccati , quando viene a cominciare la
penitenzia . Cioè conviene, che l’ uom si con-
fessi &c.
Importare . Gell. Circe . Che è quello , che
importa più .
Mancare . Petrar. Poco mancò , ch’ io non ri-
masi in Cielo .
Fallare . Bocc. Viensene dentro , e stassi con
meco , e questo non falla mai .
Appendice prima .
Si osservino i seguenti Verbi di particolar
significazione .
R Buci-
/ BEGIN PAGE 258 /
Bucinarsi vale parlarsi di una cosa di sop-
piatto . Bocc. Bucinavasi , ch’ egli era degli
scopatori .
Valere si usa per giovare . Bocc. g. 6. in
princ. La Reina le avea ben sei volte imposto
silenzio , ma niente valea .
Levare , rilevare , montare vagliono impor-
tare . Gio. Vill. Assalivano l’oste , ma poco
levava , sì avea Castruccio afforzato il cam-
po . Dante. La legge natural nulla rilieva .
Bocc. Tu diresti , e io direi , e alla fine nien-
te monterebbe .
Appendice seconda .
Andarne una pena vuol dire , essere tal pe-
na dalle leggi stabilita al tale delitto . Am-
bra Cofan. In queste cose bisogna esser cauto ,
ma dove ne va il capo , cautissimo .
Essere si usa impersonale in significato di
trovarsi . Boccacc. n. 10. nel proem. Colei la
quale si vede indosso i panni più screziati , e
più vergati , e con più fregj , si crede dove-
re essere da molto più tenuta , e più , che l’ al-
tre , onorata : non pensando , che, se fosse chi
addosso , o indosso gliele ponesse , un’ asino ne
porterebbe troppo più , che alcuna di loro , nè
perciò più da onorar sarebbe , che uno asino .
E in significato di esser vero, e per un cer-
to modo proprio della nostra lingua . Passav.
f. 264. Il miglior giacere , e ’l più sano , è il
giacere boccone , o quasi ; perocchè tutte le
mem-
/ BEGIN PAGE 259 /
membra dentro stanno nel luogo loro : se non
fosse già , che la persona aveße tossa , o asma ,
o altra infermità , che le facesse ambascia , o
noja lo stare boccone .
Far forza vale importare . Bocc. Disse il
Zeppa : egli non è ora di desinare di questa
pezza . Spinelloccio disse : non fa forza , io ho
altresì a parlar seco d’ un mio fatto .
Mostrare vale apparire . Bocc. Non è per-
ciò così da correre , come mostra , che voi vo-
gliate fare Gio. Vill. E così mostra , che Ro-
ma si reggesse a signoria di Re 254 anni .
Volersi si usa in varj modi per convenire .
Bocc. Questi Lombardi cani non ci si voglio-
no più sostenere = Comare , egli non si vuol
dire = Elle si vorrebbon vive vive metter nel
fuoco = Ma che? fatto è : vuolsi vedere altro .
Il senso di questi esempi è questo : non con-
vien più sostenerli : non convien , che si di-
ca : converrebbe metterle nel fuoco : convien
vedere altro .
Terzo Ordine degl’ Impersonali .
ALcuni Verbi impersonali hanno dopo di
se un genitivo , che accenna materia
della azione del Verbo . Eccone alquanti
esempj .
Avvenire per accadere . Bocc. Il che de-
gl’innamorati uomini non avviene .
R 2 Cu-
/ BEGIN PAGE 260 /
Curarsi . Bocc. Non altrimenti si curava
degli uomini , che morivano , che ora si cure-
rebbe di capre .
Increscere . Bocc. Per l’ amor di Dio , e per
l’ onor di te , t’ incresca di me .
Ragionarsi . Bocc. Dioneo jeri volle, che og-
gi si ragionasse delle beffe .
Appendice .
Il Verbo divenire in senso di accadere si
adopera dal Boccaccio a modo di personale
della prima de’ Neutri , ma il senso è d’im-
personale . G. 6. n. 4. Fece chiamar Chichibio ,
e domandollo , che fosse divenuta l’ altra coscia
della gru . E g. 8. n. 7. Che è della donna
tua ? A cui la fante rispose : Meßere io non
so . Io mi credeva stamane trovarla nel letto ,
ma io non la trovai nè quivi , nè altrove , nè
so che si sia divenuta . Il senso di questi esem-
pj si è : che fosse accaduto della coscia di quel-
la gru , che sia avvenuto della padrona di
quella fante .
Quarto Ordine degl’ Impersonali .
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
un dativo di persona . Eccone alquanti.
Abbisognare. Boccacc. Se non a coloro , che
me atarono, alli quali per avventura , per lo
lor senno , o per la loro buona ventura , non
abbi-
/ BEGIN PAGE 261 /
abbisogna , a quelli almeno , a’ quali fa luo-
go , alcuno alleggiamento prestare .
Accadere , avvenire . Guitt. lett. Come ac-
cade a’ buoni , così , fratello , mi pare , che
accaggia a’ cattivi . Bocc. Non altramente a
lui avvenne , che al Duca avvenuto era .
Appartenere , aspettarsi , toccare. Boccacc.
Ciò , che al servigio della sala appartiene =
Non era egli valoroso in quelle cose , che a’
giovani s’ appartengono ? Salviati Spin. Sotto
nome di Ghibellino occupa questo patrimonio ,
che di ragione s’ aspetta a Guelfo . Boccaccio .
Questa novella , la quale a me tocca di dover
dire , voglio , che ve ne renda ammaestrate .
Toccare significa ancora il Latino obtingere .
Bocc. In parte ti toccherà il valore di troppo
più , che perduto non hai .
Importare presso i moderni , e nell’uso va-
le esser d’ interesse , o di cura . Firenz. disc.
an. 13. Ti fanno por mente a quelle cose , le
quali , nè a te , nè a me importano .
Convenire , disdirsi. Boccacc. Faccendosi a
credere , che quello a lor si convenga , e non
si disdica , che all’ altre .
Dirsi . Bocc. g. 4. n. 2. La maggior villa-
nia , che mai ad alcun ghiotton si dicesse .
Restare. Bocc. Restava solamente al Re il
dover novellare .
Ricordare , dimenticare. Bocc. Mi ricorda ,
esser non guari lontana dal fiume una torricel-
R 3 la di-
/ BEGIN PAGE 262 /
la disabitata . Amm. ant. Non mi si dimenti-
ca , che la ’nvidia sempre arde a dir male
contra la buona religione .
Appendice prima .
Si osservino i seguenti Verbi di particolar
significato .
Andare una pena , sopra addotto , si fa an-
cora di quest ordine . F. Giord. Predic. A chi
commette così gran misfatto , ne va la vita
per giustizia .
Cadere si usa per appartenere . Boccaccio .
E se a me di ciò cadesse il riprendervi , io so
bene ciò , ch’ io ve ne direi .
Cader per mano vale venir l’occasione .
Boccaccio g. 8. n. 10. Essi , secondochè lor ca-
de per mano , ragionano di cambj , e di baratti .
Calere vale importare . Bocc. Non ve ne
caglia , no , io so ben’ io ciò , ch’ io mi fo .
Fare si usa per importare . Boccaccio . Che
vi fa egli , perchè ella sopra quel veron si
dorma ? Si usa ancora per essere utile , ma
coll’ accusativo , e la preposizione per . Bocc.
g. 3. n. 2. Sono alcuni sì poco discreti nel vo-
ler pur mostrar di conoscere , e di sentire quel-
lo , che per loro non fa di sapere , che alcuna
volta per questo riprendendo i disavveduti di-
fetti in altrui , si credono la loro vergogna sce-
mare , dove essi l’ accrescono in infinito .
Fallare si usa per mancare. Amm. Ant. All’
avaro non falla cagione di negar servigio .
Rile-
/ BEGIN PAGE 263 /
Rilevare, e montare, già addotti , si fan-
no di quest’ ordine , per importare, o giova-
re. Petrar. Ma infino a qui niente mi rileva
Prego , sospiro , o lagrimar , ch’ io faccia . Boc-
caccio g. 2. n. 6. Che monta a te quello , che
i grandissimi Re si facciano ?
Appendice seconda .
Sono da notarsi i seguenti modi di dire .
Aver luogo vale esser necessario . Boccacc.
g. 8. n. I. I dugento fiorini d’oro, che l’ al-
trieri mi prestasti , non m’ ebber luogo , per-
ciocchè io non potei fornire la bisogna , per la
quale gli presi .
Far luogo vale abbisognare , come dal pri-
mo esempio sopra addotto .
Non piaccia a Dio vale no . Bocc. Il do-
mandarono come non era costui attratto ? A’
quali il Fiorentino rispose : non piaccia a Dio,
egli è stato sempre diritto , come è qualunque
di noi .
Venire con addiettivo vale riuscire . Boc-
cacc. Tanto più viene lor piacevole , quanto
maggiore è stata del salire, e dello smontare
la gravezza .
Venire il destro vale presentarsi 1’ opportu-
nità . Bocc. Quando a piè , quando a cavallo ,
secondo che più il destro gli venia .
R 4 Quin-
/ BEGIN PAGE 264 /
Quinto ordine degl’ Impersonali.
I Verbi di quest’ ordine hanno dopo di se
uno ablativo di persona , e vi si possono
ridurre que’ Verbi passivi , i quali si adope-
rano in figura d’ impersonali col caso della
persona , e de’ quali pochi esempj basteranno .
Esser detto . Bocc. g. 9. n. 7. E però , comec-
chè detto ne sia , non lascerò io , che con una
novelletta assai brieve io non vi narri quello ,
che ad una mia vicina adivenne .
Esser creduto . Boccacc. n. 8. Il quale , per
quello , che da tutti era creduto, di grandissi-
me poßessioni , e di danari di gran lunga tra-
passava la ricchezza d’ ogni altro ricchissimo
cittadino .
Appendice prima.
Talvolta per proprietà di linguaggio , in
vece dell’ ablativo, si adopera l’ accusativo
colla preposizione per . Boccacc. g. 6. proem.
Per la Reina , e per tutti fu un gran romore
udito , che per le fanti , e famigliari si face-
va in cucina .
Appendice seconda .
Venire da una cosa significa uscirne odore ,
o puzzo. Boccacc. Dianzi io imbiancai miei
veli col solfo sì , che ancora ne viene = E se
non che di tutti un poco viene del caprino ,
troppo sarebbe più piacevole il piato loro .
Cade-
/ BEGIN PAGE 265 /
Cadere si usa colla preposizione in, e vale
venire, occorrere . Bocc. n. 7. Nel pensiere di
M. Cane era caduto , ogni cosa , che gli si do-
nasse , vie peggio esser perduta , che se nel
fuoco fosse stata gittata . E g.4 n I. Non mi sa-
rebbe potuto cader nell’ animo , se io co’ miei oc-
chi non l’ avessi veduto .
CAP. VIII.
Della Costruzione de’ Verbi Locali.
ABbiamo fin qui trattato della particolar
costruzione di ciascun Verbo ; ora pas-
siamo a trattare della costruzione comune de’
Verbi , di quella cioè , che può essere comu-
ne a più Verbi , benchè sieno di varj ordi-
ni . Cominceremo , all’ uso de’ Gramatici La-
tini , da’ Verbi locali , che sono quelli , i qua-
li ricevono casi significanti luogo. Tre cose
voglion considerarsi per rapporto al luogo ,
la quiete, il moto, e la distanza . La quiete
si chiama stato in luogo ; i moti sono prin-
cipalmente tre , moto da luogo , moto per
luogo , e moto a luogo. La distanza si è lo
spazio , ch’ è tra un luogo, e l’ altro.
STA-
/ BEGIN PAGE 266 /
STATO IN LUOGO .
NE’ Verbi di stato in luogo, regolarmen-
te parlando, il luogo , siasi nome pro-
prio , o appellativo , si mette in ablativo
colla preposizione in semplice , o articolata.
Gio. Vill. Soggiornò alquanto in Forlì . Bocc.
proem. Nel piccolo circuito delle loro camere
racchiuse dimorano . E g. 2. n. 2. Sono la not-
te poi stato in buon luogo , e bene albergato .
Appendice prima .
Negli Autori del buon secolo si trova non
di rado negli stati in luogo usata la prepo-
sizione a in vece d’ in . Bocc. Trovandosi egli
una volta a Parigi in povero stato . E n. I.
Piacevi egli , che il vostro corpo sia sepellito
al nostro luogo ? = Un buon’ uomo , il quale a
capo del ponte si sedea .
Appendice seconda .
Casa , singolarmente quando significa pa-
tria , riceve la preposizione a . Bocc. g. 5.
n. 5. Se io fossi a casa mia , come io sono al-
la vostra , mi tengo io sì vostro amico , che
nè di questo , nè d’ altro io non farei se non
quanto vi piacesse .
Stare a casa in un luogo , che trovasi nel
Boccaccio , significa ciò, che vosgarmente di-
ciamo : star di casa . Bocc. E spiato là , do-
ve ella stesse a casa, incominciò a passare da-
vanti a lei .
Appen-
/ BEGIN PAGE 267 /
Appendice terza .
Ci sono alcuni avverbj , i quali hanno la
forza di rilevare l’ intero caso de’ Verbi di
stato in luogo .
Qui, e qua vagliono in questo luogo , cioè
nel luogo , dove è colui , che parla , e cor-
rispondono all’ hic de’ Latini . Petrar. Qui mi
sto solo , e come amor m’ invita , Or rime , or
versi , or colgo erbette, e fiori . Bocc. Non ti
dare malinconia , figliuola , no; egli si fa be-
ne anche qua .
Non e punto facile lo stabilire una regola
ferma sopra l’ uso di questi due avverbj , e
il dir con certezza quando l’ uno, e quando
l’ altro debba adoperarsi ; perchè le varie
regole , che in ciò si danno da’ Gramatici ,
patiscono gravi difficultà . Sembrami contut-
tociò verisimile l’ opinione del Buommattei
tratt. 16. cap. 7., purchè sia messa in buon
lume Dico adunque con esso lui , che quan-
do si trattta di accennare il luogo di chi ra-
giona preciso , circoscritto , e particularizza-
to , come stanza , casa , chiesa , città , e simi-
li , si adopera l’avverbio qui : ma quando si
vuole accennare il luogo del parlante con
qualche confusione , e indeterminazione , co-
me paese , contrada , o luogo non chiaramen-
te circoscritto , si adopera l’ avverbio qua .
Così nel Bocc. Introd. essendo le sette donne
adunate in S. Maria Novella di Firenze ,
ed
/ BEGIN PAGE 268 /
ed entrando in varj discorsi , Pampinea una di
esse disse così : noi dimoriamo qui , al pa-
rer mio . non altramenti , che se essere voles-
simo testimone di quanti corpi morti ci sieno
alla sepoltura recati, o d’ ascoltare , se i Fra-
ti di qua entro alle debite ore cantino i loro
uficj . Ecco quando parla della Chiesa , do-
ve erano, dice qui , e quando parla dell’ abi-
tazione de’ Frati a loro ignota , e così in
confuso , dice qua. E n. 2. Giannotto mer-
catante in Parigi dice all’ Ebreo : non credi
tu di trovar qui chi il battesimo ti dea ? cioè
in Parigi . Qualche difficultà ci è g. 2. n. I.
dove Marchese in Trevigi accusa Martellino
esistente nella Città medesima, anzi vicino a
lui , e dice al giudice : egli è qua un mal-
vagio uomo , che m’ ha tagliata la borsa con
ben cento fiorini d’ oro. Ma si noti , che non
si circoscrive ivi alcun luogo determinato , ma
s’ intende in quella contrada , o in quella
folla di popolo , e perciò si adopera qua .
Qui , e di qua si adoperano per significa-
re : in questo mondo . Bocc. Vit. Dant. Con as-
siduo studio pervenne a conoscere della Divina
Essenzia , e dell’ altre separate intelligenze
quello , che per umano ingegno qui se ne può
comprendere . Petrar. Perchè mai veder lei Di
qua non spero , e l’ aspettar m’ è noja .
Ci , e ce si adoperano in senso di qui , e
qua . Bocc. g. 2. N. 10, Di dì , e di notte ci
si la-
/ BEGIN PAGE 269 /
si lavora , e battecisi la lana . Innanzi al pro-
nome relativo , e alla particella ne si adope-
ra il ce sciolto, o affisso . Bocc. Io ce la fa-
rò dipignere = Sappi s’ egli sa lavorare , e
ingegnati di ritenercelo = Se pure alcuni ce
ne sono.
Ne’ composti si adopera il qua , non già il
qui . Bocc. g. 8. n. 7. Oh sirocchia mia , io
son quassù = Egli è una giovane quaggiù , che
è più bella , che una lammia .
Costì, e costà vagliono in cotesto luogo, cioè
dov’ è chi ascolta, e corrispondono all’ isthic
de’ Latini ; il primo accenna luogo circo-
scritto , e preciso , e il secondo con qualche
indeterminazione , e si usa ne’ composti . Bocc.
Io vi vidi levarvi, e porvi costì , dove voi
siete , a sedere = Se voi mi metterete costà en-
tro , io vi lavorrò l’ orto = Ed étti grave il
costassù dimorare . F. Giord. Pred. O miseri ,
qual dolore avete di trovarvi ora costaggiù in
tanti tormenti?
Là, e colà vagliono in quel luogo , illic .
Bocc. g. 4. n. 10. Cominciarono a dire : chi è
la ? Dante . Vuolsi così colà , dove si puote
Ciò, che si vuole . E dicesi ancora lassù , lag-
giù , colassù , colaggiù.
Là suole aver corrispondenza colle parti-
celle qua, e qui , posponendosi ordinariamen-
te alla prima , e preponendosi alla seconda .
Bocc. Tu diventerai molto migliore , e più co-
stuma-
/ BEGIN PAGE 270 /
stumato, e più da bene là, che qui non fare-
sti = Senza star ferma, or qua, or là si tra-
mutava piagnendo
Di là talvolta significa nell’ altro mondo .
Bocc. Di questo ti dovevi tu avvedere mentre
eri di là , ed ammendartene . Riprensione fat-
ta a Ferondo , a cui era dato a credere , ch’
egli era nel purgatorio .
Ivi, e quivi vagliono in quel luogo , inten-
dendosi del luogo , di cui si favella , ma do-
ve non è chi favella . Petrar. Era la mia vir-
tute al cor ristretta Per fare ivi , e negli oc-
chi sue difese . Bocc. Quantunque quivi così
muojano i lavoratori , come qui fanno i citta-
dini .
Su , e giù dinotano luogo alto , o basso,
non solamente aggiunti , come sopra , ad al-
tri avverbj , ma ancora da se stessi . Boccacc.
g. 7. n. I. Quando andasse , o tornasse da un
suo luogo , che alquanto più su era . Passav.
f. 52 Vide Gesù Cristo su nell’ aria , in quel-
la forma che verrà a giudicare il mondo . Bocc.
g. 7. n. 6 Ecco Messer , che torna , io credo ,
ch’ egli sia già giù nella corte .
Altrove serve talvolta allo stato in luogo,
e vale in altro luogo . Dante . In una parte
più , e meno altrove .
Dove, e Ove vagliono in quel luogo, nel
quale , o pure nel qual luogo , e corrispondono
all’ ubi de’ Latini , e si può usare l’uno, o l’al-
tro,
/ BEGIN PAGE 271 /
tro secondo che torna meglio ad altrui . Nell’
interrogare vagliono : in qual luogo . Bocc. La
quale dove meno era di forza , quivi più ava-
ra fu di sostegno = Giunto nella camera , dove
Ser Ciappelletto giaceva . E g. 3. n. 8. Non
faceva altro , che domandare : dove sono io ?
E g. 7. n. 6. Ove se’ tu? esci fuori sicura-
mente .
Dovunque , ovunque , dovechè , dove che sia ,
ovechè , ove che sia vagliono in qualunque
luogo , ubicumque . Petrar. Dovunque io son ,
dì , e notte si sospira = Ovunque fur sue inse-
gne , fui lor presso . Bocc. Lett. Pin. Ross. In
ogni parte , dove che noi ci siamo , con egua-
li leggi siamo dalla Natura trattati . E g. 2. n. 5.
Non potremmo noi trovar modo , che costui si la-
vasse un poco dove che sia , che egli non putisse
così fieramente ? E Filoc. Or ecco , anima gra-
ziosa , ove che tu sii , rallegrati , ch’ io m’ap-
parecchio di seguitarti . E Ninf Fiesol Pau-
ra avendo , che non fosse stato Da qualche be-
stia morto ove che sia .
Da per tutto , per tutto vagliono ubique .
Tratt. gov. fam. Lo Padre di famiglia non
può essere sempre da per tutto . Bocc. Introd.
Quasi abbandonati per tutto languieno .
Dove sustantivamente significa luogo . Dan-
te . E questo Cielo non ha altro dove , Che la
mente Divina , in che s’ accende L’ amor , ch’ il
volge , e la virtù, ch’ ei piove = Chiaro mi
fu
/ BEGIN PAGE 272 /
fu allor , com’ ogni dove , In cielo è Para-
diso .
Dentro significa nella parte interna , intus,
e fuori , o di fuori , nella parte esterna , fo-
ris . Petrar. Di fuor si legge , com’ io dentro
avvampi . Dante . Stan li ranocchi pur col mu-
so fuori .
MOTO DA LUOGO .
NE’ Verbi di moto da luogo , regolar-
mente parlando , il luogo si mette in
ablativo colle preposizioni, da , o di , sem-
plici , o articolate . Gli esempj sono addot-
ti in copia alla settima , e de’ Neutri , e de’
Neutri passivi .
Appendice .
Al moto da luogo servono i seguenti av-
verbj .
Di qui , di qua vagliono da questo luogo ,
hinc . Bocc. g. 7. n. 3. Innanzi ch’ io mi parta
di qui , voi vedrete il fanciul sano . E g. I. n. 4.
Io voglio andare a trovar modo , come tu esca
di qua entro . E alla stessa maniera si dice :
di costà , di là , di colà .
Indi , quindi vagliono di quivi , o da quel
luogo , illinc , inde : siccome quinci vale da
questo luogo , hinc . Petrar. L’ anima esce del
cor per seguir voi , E con molto pensiero indi
si svelle . Bocc. Comandò al fante suo , che
quin-
/ BEGIN PAGE 273 /
quindi non sì partisse = Se io quinci esco vi-
vo , e scampo , in ciò fare quella maniera ter-
rò , che à grado ti fia .
Donde , e onde hanno in se la forza del re-
lativo , e vagliono di qual luogo , unde , e ser-
vono anche all’ interrogazione . Bocc. Comin-
ciò piacevolmente a ragionare , e domandar chi
fosse , donde venisse , e dove andasse . Petrar.
E poi domando : or donde Sai tu il mio sta-
to ? Bocc. La buona femmina tornò per la cas-
sa sua , e colà la riportò , onde levata l’ avea .
Nov. ant. 7. Dimmi, onde se’ , e di che con-
dizione ? Ed egli rispose : io son di Soria , e
sono Re .
Altronde vale da altro luogo , aliunde. Bocc.
Faccendo sembiante di venire altronde, se ne sa-
lì in casa sua .
Giù serve a questo moto , accennando la
parte più alta per primo termine . Bocc. g. 2.
n. I. Il pigliarono, e giù del luogo, dov’ era,
il tirarono .
Di su , d’ in su serve ancora a questo mo-
to , ma di esse vedi nelle preposizioni.
MOTO PER LUOGO.
NE’ Verbi di moto per luogo, il luogo si
mette in accusativo colla preposizione
per . Bocc. g. 3. n. 7. Che voi del suo esilio ,
e dell’ essere andato tapino per lo mondo set-
S te
/ BEGIN PAGE 274 /
te anni non siate cagione , questo non sì può
negare .
Appendice prima .
Talvolta la particella vi, sciolta , o affissa ,
rileva il caso del moto per luogo . Bocc. Per
ogni volta , che passar vi solea , credo , che
poscia vi sia passato sette . Ed or volesse Id-
dio , che il passarvi , ed il guatarmi gli fosse
bastato . E così diceva quella donna , perchè
era lontana da casa sua ; che se fosse stata
in casa sua , si sarebbe servita della particel-
la ci , la quale può aver la medesima forza .
Appendice seconda .
Quando il passaggio non è per quel luogo,
ma vicino ad esso , si usa la particella da .
Bocc. Sovente dalla Cuba passando , gliele ven-
ne per avventura veduta un dì ad una fine-
stra = Veggendolo da casa sua molto spesso pas-
sare .
Appendice terza .
Al moto per luogo appartengono i seguenti
avverbj .
Indi vale per quel luogo , illac. Dante. Or
può sicuramente indi passarsi.
Quindi vale lo stesso. Bocc. Passò quindi
un gentiluomo , il quale veggendo la nave , su-
bitamente immaginò ciò , che era .
Dove rileva talora il caso del moto per
luogo , colla forza del relativo . Pier. Cresc.
Si fanno altre tagliuole , colle quali general-
mente
/ BEGIN PAGE 275 /
mente si poßon pigliare tutte le bestie per gli
piedi , e per le gambe , e tendonsi occultamen-
te ne’ luoghi, dove passano .
MOTO A LUOGO.
TRe moti comprende il moto a luogo ,
cioè il moto a luogo propriamente ta-
le , ch’ è movimento ad un termine , che si
fa , o che si è fatto : il moto verso luogo,
ch’ è movimento , che s’accosta , o s’ indi-
rizza ad un termine : e il moto infino a luo-
go , ch’ è movimento terminato , o da ter-
minarsi in un luogo .
Il caso del moto a luogo propriamente ta-
le è l’ accusativo colla preposizione a . Bocc.
g. 2. n. 3. Andiamo noi con esso lui a Roma .
Appendice prima .
Quando il termine del moto è un Regno, una -
Provincia, o pure un luogo non chiaramente
circoscritto, si adopera la preposizione in. Bocc.
g. 5. n. 8. Come se in Francia , o in Ispagna ,
o in alcuno altro luogo lontano andar voleße .
E g. 2. n. 4. Andonne con esse in Cipri E
g. I. n. 7. Fattasi adunque la via insegnare ,
non trovando alcun , che v’ andasse , temette ,
non per isciagura gli venisse smarrita , e quin-
ci potere andare in parte , dove così tosto non
troveria da mangiare .
S 2 Appen-
/ BEGIN PAGE 276 /
Appendice seconda .
Quando il moto a luogo ha forza di andare
dentro al luogo , si adopera la preposizione in .
Bocc. g. 4. n. 10. Nella camera se ne venne .
E nell’ Introd. Ed ecco entrar nella Chiesa tre
giovani .
Appendice terza .
Il caso del moto a luogo vien rilevato spesse
volte e da particelle , e da avverbj, come
siegue .
Ci, e vi significano a questo , o a cotesto
luogo . Bocc. n. I. Io non vorrei , che voi guar-
daste , perchè io sia in casa questi usurieri ;
io non ci ho a far nulla , anzi ci era venuto
per dovergli ammonire . E g. 10. n. 3. Niun
fu , che mai a casa mia capitasse , ch’ io nol
contentassi a mio potere di ciò , che da lui mi
fu domandato . Venistivi tu vago della mia vi-
ta , perchè sentendolati domandare , presta-
mente deliberai di donarlati = S’egli avviene ,
che tu mai vi torni , fa , che tu non sii mai
più geloso .
Servono al moto a luogo gli avverbj so-
pra addotti nello stato in luogo . Bocc. Tu
te ne dovevi andare a casa tua , e non venir
qui = Qua divotamente v’ appresserete a ve-
dergli = Fatti in costà , non mi toccare . E g.
2. n. 5. Andianne là , e laverenlo spacciata-
mente. E g. 6. n I. Essendo forse la via lun-
ghetta , di là , onde si partivano, a colà ,
dove
/ BEGIN PAGE 277 /
dove tutti a piè d’ andare intendevano . Passav.
Dov’ è l’ amore , e ’l piacere , ivi va l’oc-
chio . Matt. Vill. Per gli cavalieri , e masna-
dieri , che quivi erano rifuggiti , niente vi po-
terono acquistare. Petrar. Dove se’ giunto , e
onde s’ è diviso ? Bocc. Non poteva discerne-
re ove s’ andava = Egli era disposto d’ anda-
re , dovunque a lei fosse a grado = e Teseid.
Poi dove ch’ io gissi Altro che ben non credo ,
che sentissi. E Fiamm. O figliuola , ove cor-
ri? = Ove ch’ io vada il sentirò minore =
Non sappiendo perciò , che ’l suo fante là , o
altrove si fosse fuggito . Dante . Come se tu
non fossi ancora Di morte entrato dentro dal-
la rete . Bocc. Come avvenisse , che Giacomi-
no per alcuna cagione da sera fuori di casa
andasse .
Via particella riempitiva pare che ne’ moti
a luogo significhi andare altrove . Bocc. Che
in luogo di somma grazia via il lasciasse an-
dare .
MOTO VERSO LUOGO.
IL caso ordinario di questo moto è l’ accu-
sativo colla preposizione verso , o inver-
so . Bocc. In povero abito n’ andò verso Lon-
dra = Presero adunque le donne , e gli uomi-
ni inverso un giardinetto la via .
S 3 Appen-
/ BEGIN PAGE 278 /
Appendice prima .
Si adoperano le dette preposizioni anche
col genitivo, singolarmente quando il termi-
ne , a cui s’ indirizza il moto , è persona .
Petrar. L’ ali spando Verso di voi , o dolce
schiera amica . Passav. L’ amore si accende in-
verso di lui .
Appendice seconda .
I Poeti adoperano ver , o in ver in luo-
go di verso, o inverso . Dante . Sì vid’ io ben
più di mille splendori Trarsi ver noi . Tasso .
Gazza è Città della Giudea nel fine , Su quel-
la via , ch’ in ver Pelusio mena .
Appendice terza .
In vece di verso usano di dire i moderni
alla volta col genitivo espresso , o tacito .
Firenz. Disc. Preso quel rasojo in mano , se
n’ andò alla volta sua . Tacit. Davanz. Volan-
do Antonio , con parte de’ cavalli alla volta
d’ Italia , gli fu compagno Arrio Varo .
Appendice quarta .
In sù , e in giù coll’articolo innanzi servono
a questo moto , e vagliono verso il basso , o
verso l’ alto. Bocc. g. 3. n. 6. L’ acqua è pur
corsa alla ’ngiù , come ella doveva . Firenz.
Trinuz Io gli vo’ mettere in su un carro , che
vadia da se allo ’nsù , nonchè allo ’ngiù.
MO-
/ BEGIN PAGE 279 /
MOTO INFINO A LUOGO.
IL caso ordinario di questo moto sembra un
dativo , ma è uno accusativo colla prepo-
sizione fino , infino, o fino . Dante Conv. I
raggi non sono altro , che un lume , che viene
dal principio della luce per l’ aere fino alla
cosa illuminata . Gio. Vill. Gli Vennero incon-
tro infino a S. Giovanni Laterano . Bocc. Vit.
Dant. S’ era molte volte udito le sue laudi por-
tare fino alle stelle.
Appendice prima .
La detta preposizione talvolta riceve altri
casi , e altre particelle . Matt. Vill. Il corpo
si serbò fino nel dì seguente . Bocc. Io era te-
stè in pensiero di mandare un di questi miei
infin vicin di Pavia . Gio. Vill. La sua gen-
te scorse sino presso a Parigi.
Appendice seconda .
Finchè , finattantochè , infinchè , infinattan-
tochè servono a questo moto, e portano al sog-
giuntivo d’ un’ altro Verbo , di cui l’ azione
sia termine di quella del Verbo principale .
Bocc. Chi te la fa , fagliele , e se tu non puoi,
tienloti a mente finchè tu possa . Tratt. sap.
Lo mio cuore non può essere in pace , finattan-
tochè egli non si riposi in voi . Pier Cresc. Ed
escane il sangue , infinchè il cavallo quasi in-
fralisca. Bocc. Che alcun non v’ entrasse den-
S 4 tro,
/ BEGIN PAGE 280 /
tro , infinattantochè egli tornato fosse . Si tro-
vano però anche coll’ indicativo. Bocc. Su
per le rugiadose erbe , infinattanto che alquan-
to il sole fu alzato , colla sua compagnia di
portando s’ andò = Niuno doversi muovere del
luogo suo , finattantochè io non ho la mia no-
vella finita.
DELLA DISTANZA D’ UN LUOGO
DALL’ ALTRO .
AVendo noi qui trattato del luogo , non
sarà affatto fuor di proposito il dir
quiche cosa dello spazio fra’ luoghi , o sia
della distanza d’ un luogo dall’ altro .
Quando il Verbo ha dopo di se uno ad-
diettivo , che significhi distanza , il termine
principale si mette in ablativo colle preposi-
zioni da , o di , e la misura della distanza si
mette in ablativo senza la preposizione . Bocc.
Varlungo villa assai vicina di qui = Il luogo è
aßai lontano di qui = E fosse l’ uno lontano
dall’ altro ben diece miglia .
Quando il Verbo ha dopo di se una pre-
posizione , il caso è tale , quale per se lo
esige la preposizione .
Lungi, lontano, discosto, e simili esigono il ter-
mine principale in ablativo con preposizione ,
o talvolta in dativo , e la misura della di-
stanza in ablativo senza preposizione . Bocc.
Si
/ BEGIN PAGE 281 /
Si rimase ben venti miglia lontano . Pier Cresc.
Lungi dalla radice tre dita . Vit. S. Marg. Di-
scosto alla terra cinque miglia .
Vicino , presso , e simili , che dinotano poca
distanza , si trovano comunemente col dati-
vo , non di rado col genitivo , e talora coll’
accusativo . Bocc. Assai preßo a Salerno è una
costa sopra il mare riguardante = E andando
carpone , infin presso le donne di Ripole il con-
dusse . E g. 8. n. 7. Tra salci, ed altri al-
beri presso della torricella nascoso era . Dan-
te . Si ritenne Vicino a’ monti , de’ quai prima
uscìo . Bocc. Tu puoi di quinci vedere forse
un mezzo miglio vicin di qui un boschetto .
Presso aggiunto alla misura della distanza ,
in senso di circa , vuole il dativo . Bocc. Presala
di peso , credo ch’ io la portassi preßo a una ba-
lestrata . E g. 2. n. 2. La notte oscura il soprap-
prese di lungi dal castello preßo ad un miglio .
Ci si adopera in senso del rapporto de’ due
termini della distanza . Bocc. Quante miglia
ci ha ? Haccene più di millanta . Cioè dal
luogo , dove si parlava , al luogo , del quale si
parlava . Ed è da notarsi ancora che il ci si
unisce al Verbo sustantivo , o al Verbo ave-
re , che ne fa le veci , per significare lo spa-
zio da corrersi per arrivare a un luogo . Ec-
cone un’ altro esempio . Bocc. g. 5. n. 3. Que-
sta non è la via di andare ad Alagna : egli
ci ha delle miglia più di dodici .
Ivi ,
/ BEGIN PAGE 282 /
Ivi, o simile particella, mettendo in da-
tivo la misura della distanza, vale da quel
luogo . Bocc. I pastori dissero , che ivi forse a
tre miglia era un castello.
La preposizione a aggiunta alla misura del-
la distanza , vale talora in circa . Bocc. Do-
mandò , quanto egli allora dimorasse presso a
Parigi ; a che gli fu risposto , che forse a sei
miglia .
A’ Verbi significanti moto la misura del
moto si suole aggiugnere in ablativo senza
preposizione . Bocc. g. 5. n. 4. Non eßendo
più che sei miglia camminati . E g. 5. n. 8. Es-
so bene un mezzo miglio per la pigneta en-
trato .
CAP. IX.
Di varj casi , che sono comuni
a molti Verbi .
OLtre i casi locali ci sono altri casi comu-
ni a molti Verbi , i quali per brevità
ridurremo in questo capitolo .
Del dativo comune .
Ammettono talvolta i Verbi un dativo di
quella persona , in grazia , utilità , o inco-
modo della quale ridonda l’ azione del Ver-
bo , ed è maniera Latina . Bocc. Qualunque
altro avuta l’ avesse ( quantunque il tuo amo-
re
/ BEGIN PAGE 283 /
re onesto stato fosse ) l’ avrebbe egli a se ama-
ta più tosto , che a te .
De’ casi di tempo .
I Verbi , che significano azione transitiva ,
o intransitiva ricevono il caso del tempo in
ablativo senza preposizione , o sia in accusa-
tivo. Gio. Vill. Regnò Lottieri in Italia sette
anni . Cronich. Amarett. Lino di Roma se-
dette Papa anni quindici . Bocc. g. 2. n. 6. Do-
ve poi molto tempo si crede , ch’ essi tutti fe-
licemente viveßero .
Quando il tempo non si accenna preciso ,
ma in circa , è molto in uso presso a’ nostri
Autori la preposizione di presso col dativo .
Bocc. Essendo già vecchio di presso a settanta
anni . Ovvero vi si appone : in quel torno ,
che significa circa , intorno . Boccacc. D’ età
di due anni , o in quel torno.
Lo spazio del tempo decorso, o da decor-
rere da un prefisso termine si suole esprime-
re colla particella ivi , ponendo il tempo in
accusativo colla preposizione a . Bocc. Ivi a
pochi giorni si trovò colla Ninetta . E talvol-
ta si tralascia la particella ivi , ed è manie-
ra elegante degli Antichi Nov. ant. 46. Tol-
se per moglie una gentildonna della terra : me-
nolla , e fece a due mesi una fanciulla.
De’ casi d’ istrumento , o di mezzo .
L’ istrumento , e il mezzo si soglion met-
tere in ablativo colla preposizione con . Bocc.
Per
/ BEGIN PAGE 284 /
Per voi non rimase , mostrandovi ognora più
crudele , ch’ egli non s’ uccidesse colle sue ma-
ni = Con un coltello , il meglio che potè , gli
spiccò dallo ’mbusto la testa = Non essendo al-
cun de’ baron suoi, che con prieghi di ciò si
sforzasse di rimuoverlo , il condannò nella te-
sta .
Talvolta per proprietà di linguaggio l’ i-
strumento si mette in genitivo, come notam-
mo nella sesta degli attivi .
De’ casi di cagione .
La cagione , per cui altri opera , si suol
mettere in accusativo colla preposizione per.
Bocc. Il quale già riconoscendola , e per ver-
gogna quasi mutolo divenuto , niente dicea .
Talvolta si mette in dativo . Gio. Vill. Uc-
cise di sua mano con uno stocco il detto Arri-
go , per vendetta del Conte Simone di Monfor-
te suo padre , morto a sua colpa . Bocc. g. 4.
n. 2. Io voglio , che in luogo delle busse , le
quali egli vi diede a mie cagioni , che voi
abbiate questa consolazione .
Talvolta si tralascia la preposizione . Bocc.
g. 10. n. 8. I cui santissimi effetti oggi radissi-
me volte si veggono in due , colpa , e vergo-
gna della misera cupidigia de’ mortali. Cioè
per colpa . E il Vocabolario la giudica for-,
ma quasi avverbiale . In fatti si trova in al-
tri esempj allo stesso modo . Dante Parad.
cant. I. Sì rade volte , padre , se ne coglie
Per
/ BEGIN PAGE 285 /
Per trionfare o Cesare, o poeta, Colpa, e
vergogna dell’ umane voglie . Dittam. l. 6. c. 3.
Questo monte , diss’ ei , fatto è silvestro , Col-
pa , e vergogna di que’ , che son’ ora , Che
miran solo in terra , e da sinestro .
Per conto si usa da’ Toscani col genitivo
in senso di per cagione . Bembo lett. E per
conto di lei , e per vostro ne sentiva io dop-
pio , e gravissimo dolore .
Così ancora dopo i Verbi si mette la ca-
gione in genitivo . Bocc. Di amoroso disio ar-
deva = Oltre agli altri suoi dolori , credette
di sete spasimare . Si trova talvolta negli an-
tichi col dativo. Franco Sacchetti . Se tu la
perdessi , o venisseti meno , tu morresti a do-
dore .
De’ casi di fine .
Il fine si suol mettere in accusativo colla
preposizione per . Bocc. Molti di diverse par-
ti del mondo a lui , per loro strettissimi , ed ar-
dui bisogni concorrevano per consiglio . Talora ,
per lo solito genio della lingua , si trova col-
la preposizione a in forza del gerundio latino .
Bocc. g. 8. n. 9. Mi metterò la roba mia dello
scarlatto , a vedere, se la brigata si rallegrerà .
De’ casi di modo .
Il modo si suol mettere in ablativo colla
preposizione con , o in. Bocc. g. I. n. 8 Tito
non restando di piagnere , con fatica così rispo-
se . Petrar. Sennuccio io vo’ che sappi in qual
maniera Trattato sono. Tal-
/ BEGIN PAGE 286 /
Talvolta si mette in dativo. Bocc. Lett. Pin.
Ross. Morendo a stento , fu lungamente obbrobrioso
spettacolo . E g.2.n.6. Alla maniera Alessandrina
ballò .
Talvolta in genitivo . Dante . La grazia
Del sommo Ben d’ un modo non vi piove .
Talvolta in accusativo colla preposizione
per. Bocc. Per assai cortese modo il riprese .
De’ casi di compagnia .
La persona compagna nell’ azione si mette
in ablativo colla preposizione con Bocc. Con
Griselda lungamente , e consolato visse .
CAP. X.
Della Costruzione degl’ infiniti de’ Verbi .
L’ Infinito ha tre tempi, presente, passa-
to , e futuro , ma non ha voce propria ,
se non quella del presente, come amare ;
perchè nel passato si forma dal Verbo essere ,
o da avere, congiunto col participio del pro-
prio Verbo, come avere , o essere amato : e
nel futuro si forma dalla voce del presente ,
preponendovi l’ infinito di essere , di avere ,
o di dovere , tramezzandovi col primo infini-
to la preposizione per , e col secondo a , e
col terzo infinito non ponendovi alcuna pre-
posizione ; come essere per amare , avere ad
amare , dovere amare .
Ora
/ BEGIN PAGE 287 /
Ora non avendo l’ infinito persone , nè nu-
meri , per se stesso è indeterminato , e perciò
ha bisogno di un Verbo finito, che ’l reg-
ga , e lo determini ad una certa , e particolar
significazione . Ciò si vede chiaramente da
questi esempj. Bocc. g. 4. nel proem. Aßai
manifestamente posso comprendere , quello es-
ser vero , che sogliono i savj dire , che sola
la miseria è senza invidia nelle cose presenti .
E g. 4. n. 3. Carissimi giovani , la nostra usan-
za vi può aver renduti certi , quanto sia l’ a-
more , ch’ io vi porto . E g. 6. n. I. Conoscendo ,
che il Cavaliere era entrato nel pecoreccio , nè
era per riuscirne, piacevolmente disse .
E perchè la costruzione degl’ infiniti è mol-
to varia , porremo qui alcune osservazioni trat-
te dal Cinonio Tratt. de’ Verbi dal cap. 42.
fino al cap. 55.
Osservazione prima .
Gl’ infiniti de’ Verbi attivi , senza variare
la loro voce , ricevono il senso passivo ; e
così gl’ infiniti de’ Verbi neutri passivi, sen-
za l’ affisso , ricevono il senso neutro passi-
vo . Bocc. g. 5. n. 8. nel tit. Invita i paren-
ti suoi , e quella donna amata da lui ad un de-
sinare , la qual vede questa medesima giovane
sbranare . Cioè essere sbranata . E g. 5. n. 3.
Aveva ad un’ ora di se stesso paura , e della
sua giovane , la quale tuttavia gli pareva di
vedere , o da orso, o da lupo strangolare . Cioè
essere
/ BEGIN PAGE 288 /
essere strangolata . Nov. ant. 36. Io sono costu-
mato di levare a provvedere le stelle . Cioè di
levarmi .
Osservazione seconda .
Riceve l’ infinito innanzi a se l’ accusativo
alla maniera de’ Latini, e se ne trovano mol-
ti esempj degli antichi . Alcuni stimano, che
una tal costruzione sia alquanto spiacevole ,
e poco amica della Lingua Toscana . E vera-
mente i pronomi me , e te , che si veggono
spesso negli scrittori del buon secolo innanzi
all’ infinito , oggi non si adoperano , e sen-
ton del duro, e del troppo antico . Ma i
pronomi se , lui, lei, e simili, adoperati dal
Boccaccio nella sua miglior prosa , cioè nel
Decamerone , tornano bene anche in oggi , e
hanno grazia . Bocc. g. 9. n. 4. Per tutto di-
cendo , se il palafreno , e’ panni aver vinti all’
Angiulieri . E g. 4. n. I. Niuna laude da te
data gli fu, che io lui operarla , e più mira-
bilmente , che le tue parole non potevano espri-
mere , non vedessi . E g. 3. n. 9. Che la guar-
dia , e ’l governo del Contado prendeßero , e al
Conte significassero , lei avergli vacua , ed espe-
dita lasciata la possessione .
Osservazione terza .
Ha spesse volte l’ infinito un nominativo
dopo . Bocc. g. 4. n. 8. Adirata , non del non
volere egli andare a Parigi , ma del suo in-
namoramento, gli diße una gran villania . E
g. 5.
/ BEGIN PAGE 289 /
g. 5. n. I. Si vedeva della sua speranza pri-
vare , nella quale portava , che se Ormisda
non la prendeße , fermamente doverla avere
egli.
Osservazione quarta .
Ha non di rado l’ infinito avanti di se la
particella di , e rileva la forza del gerundio
in di de’ Latini . Bocc. Introd. Ed in questa
maniera stettero tanto , che tempo parve alla
Reina d’ andare a dormire .
Talvolta si adopera per leggiadria , o per
proprietà di linguaggio. Bocc. g. 8. n. 7. A
me si conviene di guardar l’ onestà mia sì , che
io coll’ altre donne poßa andare a fronte sco-
perta. E g. 4. n. 8. nel princ. Alcuni, al mio
giudicio , sono , i quali più che l’ altre genti
credon sapere , e sanno meno : e per questo non
solamente a’ consigli degli uomini , ma ancora
contra la natura delle cose presumono di op-
porre il senno loro .
Osservazione quinta .
L’ infinito , preponendovi la particella a,
forma varj modi di dire, i quali rilevano
le seguenti forme di parlare Latine, e anco-
ra Toscane .
Il gerundio in do de’ Latini . Bocc. Fiamm.
lib. 4. num. 64. Le quali cose , ed antichissi-
me , e nuove a’ moderni animi sono non piccio-
la cagione di diporto , ad andarle mirando .
Cioè andandole mirando .
T Il
/ BEGIN PAGE 290 /
Il gerundio in Di . Dante Conviv. Tanta
fu l’ affezione a producere la creatura spiri-
tuale , che la presenzia d’ alquanti, che a mal
fine doveano venire , non dovea , ne potea Dio
da quella produzione rimuovere . Cioè di pro-
ducere.
Il gerundio in dum . Bocc. g. I. n. 5. Co-
me valorosa donna dispostasi ad onorarlo, fat-
tisi chiamare di que’ buoni uomini , che rimasi
v’ erano , ad ogni cosa opportuna , con loro con-
siglio , fece ordine dare .
Il supino in um . Bocc. g. I. nel fine . Co-
mandò , che ciascuno infino alla seguente mat-
tina s’ andasse a riposare . Cioè iret dormi-
tum .
Il futuro in rus . Passav. f. 42. Chi del tem-
po , ch’ è a venire , presumme , fa ingiuria a
Dio , il quale riserva a se il disporre , e ’l
dispensare il tempo . Cioè quod venturum est .
Il futuro in dus . Bocc. g. 9. nel fine . Trat-
tasi la corona , quella in capo mise a Panfilo ,
il quale solo di così fatto onore restava ad
onorare.
Il supino in u . Dante Purgat. cant. 22.
Ma tosto ruppe le dolci ragioni Un alber ,
che trovammo in mezza strada , Con pomi ad
odorar soavi , e buoni . Cioè olfactu suaves .
E di tal sorta sono quel forti a sostenere , e
grave a comportare , che nel Boccaccio si
leggono .
Il
/ BEGIN PAGE 291 /
Il participiale de’ Latini. Bocc. g. 8. n. 7.
Ma il modo , ch’ ella abbia a tenere intorno a
ciò , attendo di dire a lei , quando, e dove
più le piacerà .
Il gerundio Toscano . Bocc. g. 4. n. 10. Dis-
se a’ suoi parenti , che, dove un’ osso fracido ,
il quale aveva nella gamba , non gli si cavas-
se , a costui si convenia del tutto , o tagliare
tutta la gamba , o morire , e a trargli l’ oßo
potrebbe guerire .
Si adopera ancora l’ infinito coll’ a innan-
zi per ripieno , o per proprietà di linguag-
gio . Bocc. g. 5. n. 3. Esso non ardiva a tor-
nare addietro .
Osservazione sesta .
Circa l’ infinito coll’ a innanzi ci sono al-
cune forme di dire Toscane, che qui accen-
neremo .
Il Verbo essere congiunto coll’ infinito di
altro Verbo, mediante la particella a, rile-
va il significato del modo, e del tempo fini-
to di quel Verbo , corrispondente al modo ,
e al tempo dello stesso Verbo essere . Bocc.
g. 3. n. I. Io mi credo , che le Suore sien tut-
te a dormire. Cioè dormano . E g. 5. n. 8.
Che Venerdì , che viene , voi facciate sì , che
M. Paolo Traversari, e la moglie , e la figli-
uola , e tutte le donne lor parenti , e altre ,
chi vi piacerà , qui sieno a desinar meco. Cioè
desinino, o vengano a desinare . Dante usa
T 2 allo
/ BEGIN PAGE 292 /
allo stesso modo il Verbo stare . Altre stan-
no a giacere , altre stanno erte . Cioè giac-
ciono .
Talvolta la particella a preposta all’ infi-
nito , il fa aver la forza del soggiuntivo .
Petrar. Questi avea poco andare ad esser mor-
to . Cioè poco mancava , ch’ ei morisse . Bocc.
g. 5. n. I. Nè vaghezza di preda , nè odio,
ch’ io abbia contra di voi , mi fece partir di
Cipri a dovervi in mezzo mare con armata
mano assalire . Cioè affinchè io vi assalissi.
Oßervazione settima .
L’ infinito, preponendovi la particella da ,
rileva le seguenti forme di dire Latine. Il
gerundio in di . Bocc. g. 6. nel fine. Paren-
do lor tempo da dover tornare verso casa ,
con soave passo , molto della bellezza del luo-
go parlando , in cammino si misero .
Il gerundio in do . Bocc. g. 7. n. 4. Ella
non veniva là , onde s’ avvisava , ma da veg-
ghiare con una sua vicina .
Il gerundio in dum. Bocc. Allo abate se
n’ andò , e domandollo , come star gli pareva,
e se forte si credeva eßere da cavalcare .
Il participiale in significazione attiva . Bocc.
n. I. nel proem. Se spezial grazia di Dio for-
za , ed avvedimento non ci prestaße , la qua-
le a noi , ed in noi non è da credere, che per
alcun nostro merito discenda , ma dalla sua pro-
pria benignità .
Il
/ BEGIN PAGE 293 /
Il participiale in significazione passiva .
Bocc. Proem. La gratitudine , secondo che io
credo , trall’ altre virtù è sommamente da com-
mendare , e il contrario da biasimare .
Il futuro in dus . Bocc. g. 10. n. 8. Se esse-
re le pare ingannata , non io ne son da ripren-
dere , ma ella , che me non domandò , chi io
fossi .
Quando dopo l’ infinito v’ è un nominati-
vo , la particella da coll’ infinito rilevano un
significato finito dello stesso Verbo, attribui-
to a quel nominativo agente . Bocc. n. I. Co-
teste son cose da farle gli scherani , ed i rei
uomini . Cioè , che le fanno , o le farebbo-
no . E g. 2. n. 5. Che Napoli non era terra da
andarvi per entro di notte , e massimamente un
forestiere . Cioè che v’ andasse , o vi dovesse
andare .
Osservazione ottava .
L’ infinito dopo i pronomi chi, cui, che, o
gli avverbj dove , ove , donde , e simili , ha
la forza del soggiuntivo . Bocc. g. 2. n. 2. Qui
è questa cena , e non saria chi mangiarla = E
g. 3. n. 7. Quivi di fargli onore , e festa non si
potevano veder sazj , e spezialmente la don-
na , che sapeva a cui farlosi . E g. 4. n. I. Di
Guiscardo ho io già meco preso partito , che
farne, ma di te , sallo Iddio , che io non so ,
che farmi . E g. 5. n. 3. Non sappiendo dove
andarsi , se non come il suo ronzino stesso , do
T 3 ve
/ BEGIN PAGE 294 /
ve più gli pareva ne la portava . Petrar. p. I.
canz. 13. Che la mia vita acerba, Lagriman-
do trovasse ove acquetarsi . Bocc. Filoc. lib. 5.
presso il Cinonio . E vo cogliendo queste erbe ,
acciocchè de’ liquori di esse faccendo alcune co-
se utili a diverse infermitadi , io abbia donde
vivere .
Osservazione nona .
L’ infinito , preponendovi la preposizione
per ha diversi significati .
Rileva il futuro in rus de’ Latini. Bocc. g. 4.
n. 4. Gli dicesse, ch’ ella infra pochi dì era per
andarne in Granata .
Accenna prossima disposizione ad un’ azio-
ne . Bocc. Introd. I cotali son morti , e gli al-
trettali son per morire. E g. 9. n. 3. Io odo fa-
re alle femmine un sì gran romore , quando so-
no per partorire .
Dinota fine . Bocc. g. 10. n. 9. Credendo co-
stui essere un gran barbassoro, per mostrare di
avere a grado la sua venuta , una gran coppa
dorata , la quale davanti aveva , comandò , che
lavata fosse , ed empiuta di vino , e portata al
gentiluomo .
Insieme col fine dell’ operante dinota an-
cora l’ effetto. Dante. Domenico fu detto , ed
io ne parlo Siccome dell’ agricola , che Cristo
Elesse all’ orto suo per ajutarlo. Cioè perchè
l’ ajutasse .
Talora ha forza di benché col soggiunti-
vo.
/ BEGIN PAGE 295 /
vo . Bocc. g. 10. n. 5. Eßendo alla donna gra-
vi le sollecitazioni del cavaliere , e veggen-
do , che per negare ella ogni cosa da lui do-
mandatole , esso perciò d’ amarla , ne di solle-
citarla si rimaneva , con una nuova , e , al suo
giudicio , impossibil domanda si pensò di voler-
losi torre d’ addosso .
Talvolta rileva il gerundio in do de’ Lati-
ni . Petrar. son. 69. Piaga per allentar d’ arco
non sana .
Osservazione decima .
L’ infinito con altre preposizioni equivale
al gerundio Toscano . Bocc g. 7. n. 4. Esso
mi credette spaventare col gittare non so che
nel pozzo . E g. 3. n. 8. Quantunque Ferondo
fosse in ogni altra cosa semplice , e dissipito , in
amare questa sua moglie , e guardarla bene era
savissimo . E g. I. n. 5. Le quali parole per sì
fatta maniera nell’ animo del Re di Francia en-
trarono , che senza mai averla veduta , di su-
bito ferventemente la cominciò ad amare .
Osservazione undecima .
L’ infinito coll’ articolo singolare rileva un
significato finito del suo Verbo. Bocc. g. 10.
n. 7. Signor mio , il volere io le mie poche for-
ze sottoporre a gravissimi pesi , m’ è di questa in-
fermità stata cagione . Cioè ch’ io abbia voluto.
Oßervazione duodecima .
Nella nostra lingua l’ infinito in singolare
si usa a maniera di nome con articolo , pre-
T 4 posi-
/ BEGIN PAGE 296 /
posizione , o altro equivalente, e anche senz’
articolo affatto . Bocc. Introd. Le leggi , nel-
le sollecitudini delle quali è il ben vivere d’o-
gni mortale . E g. 2. n. 5. E questo pentere non
avendo luogo , vi sarebbe di maggior noja ca-
gione. E g. 4. n. I. Appresso mangiare , se-
condo la sua usanza , nella camera n’ andò del-
la figliuola . E g. 3. n. 3. Per assai cortese mo-
do il riprese dell’ intendere, e del guardare ,
ch’ egli credeva , ch’ esso facesse a quella donna .
E g. 5. n. 2. nel princ. E perciocchè amare
merita più tosto diletto , che afflizione al lungo
andare , con molto mio maggior piacere , della
presente materia parlando , ubbidirò la Reina ,
che della precedente non feci il Re .
In vece del articolo si prepone talvolta ,
per un certo vezzo toscano , la preposizione a
all’ infinito Bocc. n. 4. Io estimo , ch’ egli sia
gran senno a pigliarsi del bene, quando Dome-
neddio ne manda altrui . E g 8. n. 9. Che co-
sa è a favellare, e ad usare co’ savj !
Osservazione decimaterza .
L’usare l’ infinito a modo di nome in plu-
rale , è cosa affatto propria della lingua no-
stra . Bocc. Introd. Nè ancora dar materia agl’
invidiosi di diminuire in niuno atto l’ onestà del-
le valorose donne con isconci parlar. Passav.
f. 215. Alcuni si gloriano di avere begli , e cari
libri, e d’ avere preziosi vestiri, belle immagi-
ni, e belle dipinture.
Osser-
/ BEGIN PAGE 297 /
Oßervazione decimaquarta .
Talvolta in bocca di persona agitata da
qualche passione torna bene l’ infinito o so-
speso da se solo , o al più preceduto da qual-
che particella . Bocc. g. 8. n. 9. , dove Mae-
stro Simone viene dalla moglie sgridato a
questo modo. Ecco medico onorato : aver moglie ,
e andar la notte girando attorno . E g. 9. n. 4.
quel tristo del Fortarrigo , faccendo il dolen-
te , e l’ appassionato , dice del suo farsetto :
Io potrei cercar tutta Siena, e non ve ne tro-
verei uno , che così mi stesse ben , come que-
sto: e a dire , ch’ io il lasciassi a costui per
trentotto soldi ; egli vale ancor quaranta , o
più .
CAP. XI.
Della Costruzione del gerundio .
ANcora intorno alla costruzione del ge-
rundio porremo alcune osservazioni trat-
te dal Cinonio dove sopra dal cap. 57. fino
al cap 67.
Osservazione prima.
Essendo il gerundio un modo infinito del
Verbo , e per conseguenza indeterminato , ha
bisogno d’ un Verbo , o che lo regga , o che
almeno ne faccia conoscere il modo , e il
tempo , in cui si dee intendere. Quando adun-
que
/ BEGIN PAGE 298 /
que il gerundio dipende dal Verbo , che gli
siegue dopo, gli si dà il nominativo . Bocc.
g. 3. n. 4. Ed in sull’ ora della Compieta anda-
re in questo luogo , e quivi avere una tavola
molto larga , ordinata in guisa , che stando tu
in piè , vi possi le reni appoggiare .
Osservazione seconda .
Talvolta il gerundio è indipendente dal
Verbo , che siegue , ed è assoluto , e posto
a modo di parentesi ; e allora fa le veci del
participio presente , ma col nominativo , e
non già coll’ ablativo , come il participio.
E tal nominativo è proprio del gerundio .
Bocc. g. 3. n.7. Io credo , se più foße perseve-
rato , come per quello , ch’ io presuma , egli se
n’ andò disperato , veggendolo io consumare co-
me si fa la neve al sole , il mio duro proponi-
mento si sarebbe piegato . E g. 9. n. 7. Eßendo
Talano con questa sua Margherita in Contado
ad una sua possessione , dormendo egli , gli
parve in sogno di vedere la donna sua andar
per un bosco assai bello .
Osservazione terza .
Si trova talora il nominativo posto avanti
il gerundio . Bocc. g. 3. n. 5. nel tit. Il Zima
dona a M. Francesco Vergellesi un suo palafre-
no , e per quello , con licenza di lui , parla
alla sua donna , ed ella tacendo, egli in per-
sona di lei si risponde . E g. 4. n. 2. So io be-
ne , che stanotte vegnendo egli a me , e io aven-
dogli
/ BEGIN PAGE 299 /
dogli fatta la vostra ambasciata , egli ne por-
tò subitamente l’ anima mia tra tanti fiori, e
tra tante rose , che mai non se ne videro di
qua tante .
Oßervazione quarta .
Negli autori del buon secolo si trova usa-
to il gerundio assoluto , col caso obliquo d’ e-
gli , e d’ ella, che sembra essere l’ ablativo
assoluto col participio alla maniera de’ Lati-
ni . Dante Inf. 32. Io avea già i capelli in
mano avvolti , E tratti glie n’ avea più d’ una
ciocca , Latrando lui cogli occhi in giù raccol-
ti . Petrar. p. I. canz. 13. Men solitarie l’ or-
me Foran de’ miei piè lassi Per campagne , e
per colli , Men gli occhi ad ognor molli , Arden-
do lei , che come un ghiaccio stassi . E un tal
modo dire s’ incontra spesso in Giovanni Vil-
lani , anche col caso avanti il gerundio , ma
non già nel Boccaccio, il quale usa quasi sem-
pre il nominativo
Osservazione quinta .
Il gerundio col Verbo mandare sta in vece
dell’ infinito. Bocc. g. 10. n. 4. E mandolla
pregando , che le doveße piacere di venire a
far lieti i gentiluomini della sua presenzia .
Cioè a pregare . E n. 5. In più parti per lo
mondo mandò cercando, se in ciò alcun si tro-
vaße , che ajuto, o consiglio gli deße . Cioè a
cercare .
Osser-
/ BEGIN PAGE 300 /
Oßervazione sesta.
Si pone talvolta il gerundio in caso obli-
quo in vece del participio presente, o di un
modo , e tempo finito del Verbo . Bocc. g. 3.
n. 8. Affermava , quella solersi usare per lo
Veglio della montagna , quando alcun voleva
dormendo mandare nel suo paradiso , o trar-
lone . Cioè dormente, o mentre dormiva . E
g. 4. n. 10. Trovato Ruggieri dormendo, lo ’n-
cominciò a tentare, e a dire con sommeßa vo-
ce , che su si levaße . Cioè dormente , o che
dormiva . E g. 6. nel fine . Quivi trovarono
i giovani giucando , dove lasciati gli avieno .
Cioè che giucavano .
Osservazione settima .
Si accompagna il gerundio co’ Verbi an-
dare , e venire , e in tal caso significa una
certa frequenza, e successione di azione . Bocc.
La quale andava per gli campi certe erbe co-
gliendo . E g. 2. n. 9. Tu ridi forse , perchè
vedi me uom d’ arme andar domandando di
queste cose femminili . E g. 7. n. 4. Il doloro-
so marito si venne accorgendo , ch’ ella nel
confortare lui a bere , non beeva perciò essa
mai . E g. 8. n. 3. Or con una parola, ed or
con un’ altra , su per lo Mugnone infino alla
Porta a San Gallo il vennero lapidando.
Oßervazione ottava .
I suddetti Verbi , e altri simili , che ac-
compagnano il gerundio , si fanno anch’ essi
gerun-
/ BEGIN PAGE 301 /
gerundj , e così si raddoppia il gerundio. Bocc.
g. 8. si. 7 E andando guatando per tutto , se i
suoi porci vedesse , sentì il miserabile pianto ,
che la sventurata donna faceva . E g. 3. n. 9.
E più tritamente esaminando vegnendo ogni
particularità , e bene ogni cosa compresa , fer-
mò il suo consiglio .
Osservazione nona .
Il gerundio , siccome l’ infinito , non rice-
vono avanti di se le particelle mi , ti , ci , si ,
vi , ma solamente affisse , onde non si dice
per esempio , mi vergognando , ma vergognan-
domi , nè si vergognando , ma vergognandosi ,
e così degli altri . Pure nell’ uso si pongono
talvolta tali particelle innanzi all’ infinito , e
al gerundio , singolarmente precedendo la ne-
gativa , e udiamo per cagion d’ esempio : non
ti maravigliare di questo : non si vergognando
di ciò fare , e simili . E siccome i Verbi , an-
che neutri passivi , lasciano spesse volte l’ af-
fisso , così il lasciano i gerundj , come da
molti esempj potrebbe mostrarsi , ma può ba-
star questo solo del Bocc. g. 4. n. 7. For-
te disiderando , e non attentando di far più
avanti .
Osservazione decima .
Il gerundio , anche senza participio prete-
rito , si trova usato, dice il Cinonio, in sen-
so passivo. Bocc. g. 5. n. 7. Essendo da’ fami-
gliari menato alle forche frustando , passò da-
vanti
/ BEGIN PAGE 302 /
vanti ad uno albergo , dove tre nobili uomini
d’ Erminia erano. Cioè essendo per via fru-
stato. E Petrar. I. p. son. 27. Sol per venir’ al
Lauro , onde si coglie Acerbo frutto , che le
piaghe altrui , Gustando , affligge più , che non
conforta . Cioè gustato. Altri non ammetto-
no nel nostro gerundio questa significazion
passiva , e così negli addotti esempi dicono ,
che quel frustando vuol dire frustandolo i fa-
migliari ; e quel gustando contiene ellissi di
qualche nominativo , come gustandolo altri ,
quando altri il gusta &c . Nè io ho che op-
porre a tal sentimento , massimamente per-
chè tali modi hanno dell’oscuro anzi che no ,
e chi se ne astiene fa senno .
Osservazione undecima .
Si prepone talvolta al gerundio la parti-
cella in , e non senza vaghezza . Petrar. canz.
39. Ella l’ accese , e se l’ ardor fallace Durò
molt’ anni in aspettando un giorno , Che per
nostra salute unqua non viene , Or si solleva
a più beata spene . Si trova ancora con altre
preposizioni , benchè non sia oggi troppo in uso .
Bocc. g. 10. n. 2. Quel male , il quale egli fa,
io il reputo molto maggior peccato della fortu-
na , che suo , la qual se voi , con alcuna co-
sa dandogli , donde egli possa secondo lo stato
suo vivere , mutate , io non dubito punto , che
in poco di tempo non ne paja a voi quello , che
a me ne pare .
Osser-
/ BEGIN PAGE 303 /
Oßervazione duodecima .
Si congiugne il gerundio col participio pre-
terito di avere , o di essere , e prende il
senso di perfetto , o di trapassato , secondo
che lo esige il Verbo , il quale regge la sen-
tenza. Petrar. son. 48. Piacciati omai col tuo
lume , ch’ io torni Ad altra vita , ed a più
belle imprese , Sicchè avendo le reti indarno
tese , il mio antico avversario se ne scorni .
Cioè poichè egli ha tese le reti . Bocc. g. I.
n. 7. Avendo adunque il siniscalco le tavole
messe , fece dire allo abate , che qualora gli
piacesse , il mangiare era presto. Cioè poich’ e-
gli ebbe messe le tavole E g. 4. n. I. Le da-
migelle sue , avendo queste cose , e vedute , e
udite , a Tancredi ogni cosa avean mandata a
dire . Cioè le damigelle, che avevano que-
ste cose vedute . E g. 8. n. 7. Tante , e sì fat-
te cose di te scritte avrei , ed in sì fatta ma-
niera , che avendole tu risapute , che l’ avre-
sti , avresti il dì mille volte disiderato di mai
non esser nata . Cioè quando tu le avessi ri-
sapute .
Il gerundio del Verbo essere co’ participi
de’ Verbi intransitivi può avere senso attivo.
Bocc. g. 9. n. 9. Essendo già quasi per tutto
il Mondo l’ altissima fama del miracoloso senno di
Salamone discorsa . E può avere senso di tra-
passato, come sopra co’ participi del Verbo
avere , secondo che lo esige il Verbo princi-
pale . CAP.
/ BEGIN PAGE 304 /
CAP. XII.
Della Costruzione del participio .
DEl participio parimente porremo alcune
osservazioni tratte dal Cinonio nel cita-
to Trattato de’ Verbi dal cap. 69. fino al cap.
80. E si noti , che il participio presente , es-
sendo voce infinita , dee essere retto , e de-
terminato da un Verbo finito , che regga al-
tresì il sentimento : e il participio preterito
dee essere appoggiato, o al Verbo essere , o
al Verbo avere , da’ quali riceve la sua de-
terminazione .
Osservazione prima .
Il participio presente nel nominativo si
trova bensì , ma dee usarsi di rado , comec-
chè non troppo ricevuto dall’ uso migliore .
Gio. Vill. Or non è questa terra quasi una
gran nave portante uomini tempestanti , peri-
colanti , soggiacenti a tanti marosi , a tante
tempeste ? Bocc. g. 10. n. 8. Sciocche lamentan-
ze son queste , e femminili , e da poca conside-
razione procedenti .
Osservazione seconda .
Più frequentemente si adopera il participio
presente ne’ casi obliqui . Bocc. g. 10. n. 5.
Preporremo la quasi morta donna , e il già rat-
tepidito amore per la spoßata speranza a que-
sta
/ BEGIN PAGE 305 /
sta liberalità di Meßer Ansaldo più fervente-
mente che mai amando ancora , e quasi da più
speranza acceso , e nelle sue mani tenente la
preda tanto seguita ? E g. 2. n. 8. A lui dimo-
rante in Irlanda venne voglia di sentire , se
egli potesse , quello , che de’ figliuoli fosse av-
venuto. E g. 5. n. I. Poichè alquanto di tem-
po ebbe posato in dover lei piagnente racconso-
lare , diliberò co’ suoi compagni , non essere da
tornare in Cipri .
Osservazione terza .
Si trova usato il participio presente in abla-
tivo assoluto . Nov. ant. 24. nel tit. Come il
Soldano donò a uno duo mila marchi , e come
il Tesoriere le scrisse , veggente lui , ad usci-
ta . Bocc. g. 2. n. 8. Avvenne , durante la
guerra , che la Reina di Francia infermò gra-
vemente .
Osservazione quarta .
Il participio presente si trova cogli affissi .
Bocc. Fiamm. f. 79. Egli di te non curantesi .
Ma non è molto in uso.
Osservazione quinta .
Per ciò, che appartiene a’ participj prete-
riti , quando sieno retti dal Verbo essere, e
quando dal Verbo essere, si potrà conoscere
da ciò, che dicemmo su tal punto nel pri-
mo Libro , dove trattammo de’ preteriti. Qui
è da notarsi una particolar costruzione del par-
ticipo voluto, e potuto retto dal Verbo esse-
V re
/ BEGIN PAGE 306 /
re a maniera di passivo , coll’ infinito dopo ,
e colla persona in nominativo . Bocc. n. I. Que-
sti Lombardi cani, i quali a chiesa non sono
voluti ricevere, non ci si vogliono più sostene-
re . E g. 10. n. 9. L’ abbracciò strettamente ,
nè mai dal suo collo fu potuta levare. Passav.
f. 226. Non è voluta udire la verità .
E il participio andato si trova usato col
Verbo eßere nella sopraddetta maniera , ma
a modo d’ impersonale. Bocc. n. I. Colla mag-
gior calca del mondo da tutti fu andato a ba-
ciargli i piedi .
Osservazione sesta .
I participj retti dal Verbo avere si posso-
no accordare col nome, e possono ancora
discordare da esso in genere , e in numero .
Bocc. g. 5. n. I. Lisimaco ogni cosa opportuna
avendo apprestata. E. g. 2. n. 5. Come io avrò
loro ogni cosa dato , mentre che io penerò ad
uscire dell’ arca , essi se n’ andranno pe’ fatti lo-
ro . E g. 6. in princ. Aveva la luna , essendo
nel mezzo del cielo , perduti i raggi suoi .
Nov. ant. 83. Si richiamò un villano d’ un suo
vicino , che gli avea imbolato ciriege .
Quando il participio fatto è posto in vece
del Verbo antecedente , il Boccaccio usa di
finirlo in o , senza riguardo al nome. G. 4.
n. 2. Quivi pensò di trovare altra maniera al
suo malvagio adoperare , che fatto non avea
in altra parte . E g. 9. n. 4. Ed ecco venire
in
/ BEGIN PAGE 307 /
in camicia il Fortarrigo , il quale per torre i
panni , come fatto aveva i danari , veniva .
Parimente quando un participio è avanti
all’infinito , sembra più naturale accordarlo a
guisa di neutro coll’ infinito , che col nome .
Bocc. Molte volte avea desiderato di avere co-
tali insalatuzze d’ erbucce , come le donne fan-
no , quando vanno in villa . E g. 9. n. 3. Ri-
masero contenti d’ avere con ingegni saputo
schernire l’ avarizia di Calandrino.
Osservazione settima .
I participj retti dal Verbo eßere si soglio-
no , almeno in prosa , accordare col nome .
Bocc. g. 4. n. 9. Donna , chente v’è paruta
questa vivanda ? La donna rispose : Monsigno-
re , in buona fe ella m’ è piaciuta molto . E
n. 100. Erano a Gualtieri piaciuti i costumi di
una giovinetta . Si trovano con tutto ciò an-
che non accordati col nome . Bocc. g. 4. n. 6.
De’ così fatti , e de’ più spaventevoli assai n’ho
già veduti , nè perciò cosa del mondo più , né
meno me n’è intervenuto , e perciò lasciagli
andare .
Osservazione ottava .
I participj preteriti assoluti , che hanno do-
po di se l’ ablativo , spesso si accordano , ma
anche talvolta non si accordano col nome .
Bocc. g. 2. n. 9. Giunto adunque il famigliare
a Genova , e date le lettere , e fatta l’ amba-
sciata , fu dalla donna con gran festa ricevu-
V 2 to .
/ BEGIN PAGE 308 /
to . E g. 2. n. 8. Nè prima nella camera en-
trò , che ’l battimento del polso ritornò al gio-
vane , e lei partita , cessò . Nov. ant. 54. Ve-
nuto la sera , ancora il rimisero dentro . E Boc-
caccio g. 2. n. 4. Le mani dalla cassa svilup-
patogli , e quella posta in capo ad una sua
figlioletta , lui come un picciol fanciullo ne por-
tò nella terra.
CAP. XIII.
Della Costruzione del nome .
ALla costruzione del nome nella nostra lin-
gua appartengono , e le accompagnatu-
re , che gli si pongono innanzi , e i casi , ch’ e’
riceve dopo ; delle quali cose tutte qui trat-
teremo ordinatamente , e colla solita bre-
vità .
DELL’ ARTICOLO.
INtorno al dare , o non dare l’articolo a’
nomi porremo alcune brievi osservazioni,
che possano recar qualche lume alla pratica.
Osservazione prima .
Dio , o Iddio nominato da se solo non ri-
ceve articolo , perché è unico , e singulare .
Bocc. g. 8. n. 2. Dio ci mandi bene , chi è
di qua ? = Tenete il vostro figliuolo per la gra-
zia di Dio sano . Se
/ BEGIN PAGE 309 /
Se Dio ha avanti di se qualche nome ad-
diettivo , riceve articolo . Passav. f. 11. L’ on-
nipotente Iddio , e misericordioso giudice , rice-
vendo volentieri la nostra penitenzia , nascon-
de dal suo giudicio i nostri falli . Ma se l’ ad-
diettivo, è dopo , Dio non riceve articolo .
Bocc. g. 2. n. 8. Iddio giusto riguardatore de-
gli altrui meriti altramente dispose .
In Plurale Iddio riceve articolo, quando
cioè si parla delle false deità de’ Gentili , e
si dice : gli Dei , o gli Dij .
Osservazione seconda .
Cielo , sole , luna , terra , mare , mondo , e
altri simili, benché sieno singularmente espressi,
l’ uso porta , che ricevano l’ articolo . E lo
stesso de’ dirsi de’ nomi appellativi, come uo-
mo , città , fiume &c.
Osservazione terza .
I cognomi delle famiglie , quando sieguo-
no i nomi proprj , non hanno comunemente
articolo , onde nel Boccaccio abbiamo: Te-
daldo Elisei , Ricciardo Manardi , Niccoluccio
Caccianimico e altri : ma pur talvolta l’ han-
no dall’ uso , come nel medesimo Boccaccio,
in cui leggiamo : Malgherida de’ Ghisolieri ,
Gentile de’ Garisendi , Egano de’ Galluzzi &c.
Ma quando il cognome si adopera a foggia
di nome proprio , per dinotare una persona
particulare di quella famiglia , vi si pone
sempre l’articolo ; e così nel Boccaccio ab-
biamo :
/ BEGIN PAGE 310 /
biamo : lo Scalza , il Guardastagno , il Ros-
siglione &c.
Osservazione quarta .
I nomi proprj delle parti del Mondo , de’
Regni, delle Province , de’ mari , de’ fiumi ,
de’ monti, e simili possono usarsi coll’ artico-
lo , e senza ; onde in ciò altri dee seguir l’ u-
so più ricevuto . I nomi proprj delle Città
vanno senz’ articolo , da alcuni pochi in fuo-
ri , come il Cairo , la Mirandola &c .
Osservazione quinta .
I nomi proprj degli uomini si usano sem-
pre senz’ articolo . Quelli delle donne si usa-
no e con articolo, e senza , e così usa il
Boccaccio nelle donne del Decamerone , di-
cendo per esempio talvolta Fiammetta , tal-
volta la Fiammetta ; e questo secondo uso è
più dimestico .
Osservazione sesta .
I nomi delle dignità , come Papa , Re ,
Reina , Vescovo , Abate , Badessa , e simili
quando hanno innanzi i titoli di Monsignore ,
Messere , Madonna , Madama &c presso gli an-
tichi si trovano coll’ articolo : Messer lo Pa-
pa , Monsignor lo Re , Madonna la Reina , Mon-
signor l’ Arcivescovo &c. , ma in oggi non so-
no in uso , non dandosi più del Messere , nè
del Monsignore a’ Papi , e a’ Re ; e dicen-
dosi Monsignor Vescovo , il Signor tale &c. So-
lo è rimaso all’ antica foggia il titolo di Ma-
dama ,
/ BEGIN PAGE 311 /
dama , e si dice : Madama la Reina , la Con-
tessa &c.
Il titolo di Papa a maniera di sustantivo ,
ha l’ articolo . Bocc. g. 2. n. 3. Da capo il Pa-
pa fece solennemente le sponsalizie celebrare .
Se è addiettivo precedente al nome proprio ,
non ha articolo . Bocc. n. I. Da Papa Boni-
fazio addomandato , e al venir promosso .
Re a modo di sustantivo , e anche d’ ad-
diettivo sempre esige l’ articolo . Pure l’ Ario-
sto nella prima stanza del Furioso levò l’ ar-
ticolo a Re addiettivo precedente al nome pro-
prio : Per vendicar la morte di Trojano Sopra
Re Carlo Imperador Romano . Ma questa fu
licenza poetica , e da non volersi imitare .
Osservazione settima .
Santo , Santa , Frate , Suora , Monsignore ,
Madama , se sono avanti a’ lor sustantivi ,
facciano l’ articolo , onde abbiamo nel Boc-
caccio San Brancazio , Santa Verdiana , Frate
Puccio , Madama Beritola &c. , e noi dicia-
mo : Suor Ippolita , Monsignor della Casa &c.
Maestro sustantivamente posto riceve arti-
colo ; posto addiettivamente non suol rice-
verlo nell’ uso più comune : ma contuttociò
non può riprendersi chi gliel desse , trovan-
dosi nel Boccaccio nell’ uno , e nell’ altro mo-
do . G. I. n. 10. Maestro Alberto da Bolo-
gna : e ivi più abbasso : Avendo di lontano ve-
duto il Maestro Alberto. E così g. 9. n. 3. si
V 4 tro-
/ BEGIN PAGE 312 /
trova e Maestro Simone , e al Maestro Si-
mone .
Osservazione ottava .
Casa , corte , palagio ( intendendo il prin-
cipale del luogo ) e talvolta anche Chiesa ,
e Città , si usano senz’ articolo. E così an-
cora nozze , festa , contado , e altre , che
dall’ uso si potranno conoscere. Bocc. n. ult.
Giunti a casa del padre della fanciulla ; e
più sotto : Di casa sua così poveramente , e
così vituperosamente uscire . Seneca pist. 53.
Nè già aresti amico sì caro , per cui malleva-
re tu andassi a corte . Bocc. g. 8. n. 5. Ben-
chè i cittadini non abbiano a far cosa del mon-
do a palagio , pur talvolta vi vanno . E g. 7.
n. 5. Che a nozze , o a festa , o a Chiesa an-
dar potesse . Gio. Vill. presso al Salviati. Gli
sbanditi uscirono quasi tutti di città , e di con
tado .
Osservazione nona .
Il Bembo dà per ferma regola , che qua-
lunque volta si dà l’ articolo a un nome ,
debba darsi ancora al genitivo da lui dipen-
dente , e che accenna la di lui materia . Si
fonda il Bembo su gli esempj degli antichi ,
e singolarmente del Boccaccio , in cui leggia-
mo : il mortajo della pietra , la corona dello
alloro , le colonne del porfido . E nota il me-
desimo Bembo , che per contrario , quando
al nome non si dà l’ articolo , al genitivo
da
/ BEGIN PAGE 313 /
da lui dipendente si dà il segnacaso ; onde
leggiamo nel Boccaccio : ad ora di mangia-
re : essendo arche grandi di marmo : tutti di
fronda di quercia inghirlandati . Il Salviati ,
e il Buommatei non ammettono indistinta-
mente una tal regola , ma solamente quando
la ragione il consenta . Se il genitivo adun-
que accenna destinazione ad un’ uso particola-
re , allora siegue la condizione del principal
nome , e riceve l’ articolo . Bocc. g. 7. n. 3. Nel
palco de’ colombi . Gio. Vill. I magazzini del
Vino Greco . Cioè luogo destinato a serbar co-
lombi , e a tener Vino Greco ; che se vi si
ponesse il segnacaso , potrebbe intendersi un
luogo per accidente pien di colombi , o di
greco .
Quando il nome accenna misura , e quan-
tità circoscritta della materia significata dal
genitivo , parimente il genitivo riceve l’ ar-
ticolo , almeno secondo l’ uso migliore . Gio.
Vill. Valse lo stajo del grano da soldi venti .
Quando poi il genitivo accenna materia
intrinseca , come negli esempj addotti dal
Bembo si è la pietra al mortajo , l’ alloro
alla corona , e ’l porfido alle colonne , il
dargli articolo è modo antico , il quale in
oggi non s’ intenderebbe , anzi potrebbe ca-
gionare equivoco : perchè dicendo per esem-
pio : il mortajo della pietra , potrebbe inten-
dersi non d’ un mortajo fatto di pietra , quan-
lun-
/ BEGIN PAGE 314 /
lunque ella sia , ma d’ un mortajo di una par-
ticular pietra , già accennata , o pure d’ un
mortajo destinato a pestavi pietra . E chi
pure avesse scrupolo nel trasgredire la rego-
la del Bembo , il mandi via coll’ esempio
del Bocc. g. 7. n. 3. , dove dice : Fatta fare la
immagine di cera , la mandò ad appiccare coll’
altre dinanzi alla figura di Santo Ambruogio .
Osservazione decima .
Quando in uno stesso parlare sono più no-
mi continuati , dato l’ articolo al primo , è
ben fatto darlo anche agli altri ; e se al pri-
mo non si dà articolo , non darlo agli altri .
Bocc. g. I. n. 7. Primasso aveva l’ un pane man-
giato , e lo abate non vegnendo , cominciò a
mangiare il secondo . E n. I. Il quale nè vec-
chiezza , nè infermità , nè paura di morte , al-
la quale si vede vicino , né ancora di Dio , al
giudicio del quale di qui a picciola ora s’ aspet-
ta di dover essere , dalla sua malvagità l’ han-
no potuto rimuovere . Ma è lecito contuttociò
fare talvolta altrimenti , e l’ hanno fatto i
migliori . Passav. f. 25. Com’ è il digiuno , ci-
liccio , lagrime , discipline , e simili cose , che
fanno coloro , che stanno in penitenza . E nel
Bocc. g. 5. n. 6. Gian di Procida domandato
dall’ Ammiraglio , della cagione perch’ e’ fosse
condotto al supplizio , rispose : Amore , e
l’ ira del Re .
Gli addiettivi , comecchè vanno d’ ordina-
rio
/ BEGIN PAGE 315 /
rio aggiunti a’ sustantivi , non hanno artico-
lo proprio . Pure il ricevono in due casi per
proprietà di linguaggio. Primo posti dopo il
sustantivo a maniera di titolo , e così nel
Boccaccio abbiamo : Ginevra la bella , Isotta
la bionda , Filippo il bornio &c. Secondo po-
sti avanti al sustantivo, mettendo questo in
genitivo. E così troviamo nel Boccaccio : Il
cattivel d’ Andreuccio .
DEL SEGNACASO.
SI tralascia talvolta il segnacaso , o pur si
mette dove sembra , che non operi pun-
to , e ciò per proprietà della lingua , come
dalle seguenti Osservazioni .
Osservazione prima .
De’ tre segnacasi , DA non si tralascia mai ,
se non per dar luogo a una preposizione ;
ma DI, e A si tralasciamo spesse volte del
tutto.
Osservazione terza .
E‵ proprietà della Lingua Toscana toglie-
re il segno dal genitivo di proprietà aggiun-
to al nome casa, ma con queste avvertenze.
Se il genitivo è nome proprio del padron
della casa , si toglie il segnacaso , senza sur-
rogarvi l’ articolo ; onde nel Boccaccio leg-
giamo : in casa Messer Guasparrino : ma se
casa ha l’ articolo , non si lascia il genitivo
del
/ BEGIN PAGE 316 /
del nome proprio senza segno. Bocc. g. 5.
n. 4. Usava molto nella casa di Messer Li-
zio .
Se il genitivo dipendente da casa è nome
appellativo , lascia il segnacaso , ma vuole
l’ articolo, o il pronome questo ; e perciò nel
Boccaccio si legge : a casa il padre : in casa
il medico : in casa questi usurai . Se poi in
questi esempj il caso sia nominativo , o ac-
cusativo , come accenna l’ articolo , o il pro-
nome , nol saprei ben dire , e poco monte-
rebbe il diffinirlo . Il caso di proprietà è il
genitivo ; e in tali modi l’ articolo forse sta
in luogo del segno del genitivo per la figu-
ra enallage ; onde quando si dice : in casa
questi usurai , sarà forse ellissi del segna-
caso di . Ma siasi il caso , ch’ e’ vuol’ essere ,
basterà il sapere in ciò la proprietà della
lingua.
Osservazione terza .
Togliesi il segnacaso dal nome Dio dipen-
dente da mercè , o grazia , dicendo : la Dio
mercè la Dio grazia . Bocc. g. 3. n. 9. La Dio
mercè , e la vostra io ho ciò , che io disidera-
va . Ma se il nome Dio si mette dopo a mer-
cè , vuole il segnacaso . Bocc. g. 3. n. 3. La
mercè di Dio , e del marito mio io ho tante
borse , e tante cintole , ch’ io ve l’ affogherei
entro . Si dice parimente nell’ uso : la Dio
grazia , non già però : la grazia Dio , ma di
Dio . Osser-
/ BEGIN PAGE 317 /
Osservazione quarta .
I pronomi colui , colei , costui , costei , colo-
ro , costoro , possono lasciare il segnacaso ,
purché sieno avanti a nome , e abbiano in-
nanzi l’ articolo, o qualche preposizione . Nov.
ant. 56. Acciocché il potesse mettere alle for-
che in colui scambio . Bocc. Subita speranza
prendendo di dover potere ancora nello stato
reale ritornare per lo colui consiglio . E Fiamm.
La sua forza niente valeva , se le giovani ser-
ve al colei grido non fossono corse . E g. 7. n. 4.
Fidanza nella costui ebbrezza prese . E Fiamm.
lib. 4. E dopo i mandati sospiri , con voce ta-
cita pregai per gli coloro beni umilmente gli
Dij . E g. 4. n. 3. Pensò di potersi ne’ suoi di-
fetti adagiare per lo costoro amore .
Osservazione quinta .
Loro , altrui lasciano il segnacaso di , o in-
nanzi , o dopo che sieno al nome , né ricer-
cano necessariamente articolo proprio. Bocc.
Alcune canzonette dalle predette donne canta-
te a lor diletto . E Introd. Gli uomini sono del-
le femmine capo , e senza l’ ordine loro rade
volte riesce alcuna nostra opera a laudevole
fine = Ciò per l’ altrui case faccendo .
Osservazione sesta .
Cui lascia i segnacasi di , e a . Boccacc. Il
buon’ uomo , in casa cui morto era . Dante. E
di colei , cui son , procaccian danno . Petrar.
Voi , cui fortuna ha posto in mano il freno del-
le belle contrade . Osser-
/ BEGIN PAGE 318 /
Osservazione settima .
Lui, lei , loro lasciano il segno del dati-
vo , quando dipendono da’ Verbi . Dante. Ma
per dar lui esperienza piena , A me , che mor-
to son , convien menarlo Per lo ’nferno quag-
giù di giro in giro = Ond’ io risposi lei , non
mi ricorda , Ch’ io straniassi me giammai da
voi . Bocc. Nè era ancora lor paruto alcuna
volta tanto gajamente cantar gli usignoli , quan-
to quella mattina pareva .
Osservazione ottava .
Quando nel parlare vi son molti nomi,
ch’ esigono il segnacaso , talvolta in alcun
d’ essi si tralascia . Bocc. g. 3. n. 3. Fu una gen-
tildonna , di bellezze ornata , e di costumi ,
d’ altezza d’ animo , e sottili avvedimenti . E
g. 5. n. I. Da’ compagni di Lisimaco , e Cimone
fediti , e ributtati indietro furono .
Osservazione nona .
Talvolta il segnacaso è scioperato , e si
mette per una certa proprietà . Così quando
il Boccaccio dice : il cattivello di Calandri-
no , quel di non opera nulla .
DEL NOME SUSTANTIVO.
CIrca la costruzione del nome sustantivo
porremo alcune brievi osservazioni , af-
finchè si vegga in che la nostra costruzione
sia differente dalla Latina.
Osser-
/ BEGIN PAGE 319 /
Osservazione prima .
Quando si trovano nel discorso due sustan-
tivi di cose diverse , il secondo è genitivo ,
e dipendente dal primo, come presso a’ La-
tini. Passav. f. 229. Tutto lo studio suo puose
ne’ libri della Santa Scrittura .
Osservazione seconda .
Gli addiettivi posti neutralmente a manie-
ra di sustantivi, ricevono , com’ essi , un su-
stantivo dipendente , e in genitivo . Boccacc.
Nella quale tanto di piacevolezza gli dimo-
straste , che s’ egli prima v’ amava , in ben
mille doppj faceste l’ amor raddoppiare = Con
alquanto di buon vino , e di confetto il ricon-
fortò . E g. 4. n. 3. nel proem. Un poco di buo-
no , e che mi piacque , fu nella fine della vo-
stra novella .
Osservazione terza .
Il sostantivo reo non riceve , come in La-
tino , l’ ablativo , ma solamente il genitivo .
S. Grisost. Chiunque si cruccia col suo fratel-
lo , o prossimo , è reo di giudicio .
Osservazione quarta .
I sustantivi , che si riferiscono a lode , o a
biasimo, non ricevono presso di noi l’ abla-
tivo, come presso i Latini , ma solamente il
genitivo . Bocc. Era il Marchese di Monfer-
rato uomo d’ alto valore . E nell’ Introd. Era-
no uomini , e femmine di grosso ingegno.
DE’
/ BEGIN PAGE 320 /
DE’ NOMI ADDIETTIVI .
GLi addiettivi ricevono dopo di se qua-
lunque caso obliquo , come dimostrere-
mo partitamente ne’ seguenti ordini .
COL GENITIVO .
MOlti sono gli addiettivi , che ricevono il
genitivo , ma i più frequenti sono quel-
li , che significano notizia , o ignoranza ; ave-
re, o privazione ; prerogativa , o vizio . Ec-
co i più usitati .
Certo . Bocc. g. 2. n. 9. Acciocchè io ti fac-
cia certo dell’ onestà della mia donna .
Incerto . Bocc. g. 6. n. 2. nel proem. Quello,
che i mortali speße volte fanno , i quali incer-
ti de’ futuri casi , le loro più care cose ne’ più
vili luoghi delle lor case sepelliscono .
Consapevole . Bocc. g. 4. n. 6. La quale di
questo amore consapevole era . E nel Labir. La
maravigliosa eloquenzia , che di costei il tuo
amico , male consapevole del fatto , ti ragio-
nava .
Pratico . Borghin. Fir. disf. Scrissi a un mio
amico intendentissimo , e pratichissimo di questa
sorta d’ antichità .
Ricco , povero . Bocc. g. I. n. 6. Un buono uo-
mo più ricco di danari, che di senno . Cronic.
Mo-
/ BEGIN PAGE 321 /
Morell Povero di moneta , e stretto d’ animo.
Cupido, Avaro , liberale . Bocc. n. 2. Tutti
avari , e cupidi di danari gli vide . E g. 10.
n. 5. Già Dio non voglia , poichè io ho vedu-
to Gilberto liberale del suo onore, e voi del
vostro amore , che io similmente non sia libera-
le del mio guiderdone .
Abbondante , scarso . Bocc. g. 8. n. 7. De’ be-
ni della fortuna convenevolmente abbondante .
Petrar. nel Trionfo di Fama cap. 2. Zenobia
del suo onore assai più scarsa .
Pieno , voto . Bocc. Tutto pieno di simiglianti
cose . Petrar. Voto d’ ogni valor , pien d’ ogni
orgoglio .
Vestito , ignudo . Bocc. Amet. Costei di ve-
stiri vermigli vestita . Matt. Vill. Trovandosi
ignudo , e sfornito di gente d’ arme .
Bello . Bocc. Parendogli essere un bel fante
della persona .
Nobile . Bocc. Amet. f. 70. Antico di sangue ,
e nobile di costumi .
Colpevole , innocente . Bocc. g. 10. n. 8. Sap-
pi , niun di costoro eßer colpevole di quello ,
che ciascuno se medesimo accusa . E g. 2. n. 8.
Con ciò fosse cosa , ch’ egli lui per innocente di
ciò , perchè in esilio andato era , l’ aveße .
X COL
/ BEGIN PAGE 322 /
COL DATIVO .
RIcevono il dativo gli addiettivi , i quali
accennano rapporto a qualche termine ,
senza connotare tacitamente azione . Ecco-
ne alcuni .
Grato , odioso. Bocc. g. 3. n. 10. Servigio ,
che più si poteva fare , grato a Dio . Passav.
f. 168. La superbia è odiosa a Dio , e agli uo-
mini .
Fedele , infedele. Dante . Mischiati sono a
quel cattivo coro Degli angeli , che non furon
ribelli , Nè fur fedeli a Dio , ma per se fo-
ro . Passav. f. 23. L’ uomo è infedele , e dislea-
le a Dio .
Utile , disutile . Bocc. g. 8. n. 7. La cui vita
ancora potrà più in un dì esser utile al Mon-
do , che centomila tue pari non potranno , men-
tre che il Mondo durar dee . Gio. Vill. Sicco-
me uomo disutile al reame , fu disposto della
signoria .
COLL’ ACCUSATIVO ,
E LA PREPOSIZIONE A .
QUegli addiettivi, i quali accennano rap-
porto , e azione espressa , o tacita ,
vogliono l’ accusativo colla preposi-
zione a . Eccone alquanti .
Atto .
/ BEGIN PAGE 323 /
Atto . Bocc. Atta a meglio saper macinare ,
che alcun’ altra = T’ abbia parato dinanzi così
fatta cosa, e a’ disiderj della tua giovinezza atta.
Pronto . Bocc. Pronta a quello in altrui vir-
tuosamente operare , che in se vorrebbe , che
fosse operato .
Inclinato . Fr. Giordan. Pred. Fomentano quel
loro geniaccio inclinato al male.
COLL’ ACCUSATIVO , E LA
PREPOSIZIONE PER .
GLi addiettivi , che hanno caso di cagio-
ne , l’ hanno ordinariamente in accusa-
tivo colla preposizione per . Eccone alcuni
esempi .
Chiaro , famoso , infame , e simili . Bocc. g. 3.
n. 6. Un giovane per nobiltà di sangue chiaro ,
e splendido per molte ricchezze . E g. 10. n. 2.
Ghino di Tacco per la sua fierezza , e per le
sue ruberie aßai famoso . Serd. Stor. Il promon-
torio , che è alle pendici del monte Atlante ,
infame per l’ impeto dell’acque . E così d’ altri
molti simili addiettivi.
COLL’ ABLATIVO .
GLi addiettivi di misura , come alto , pro-
fondo , lungo , largo , grosso &c. hanno
l’ ablativo senza preposizione . Basterà un’e-
X 2 sempio .
/ BEGIN PAGE 324 /
sempio . Gio. Vill. Tutte le torri di Firenze ,
che n’ avea nella Città gran quantità , alte cen-
to venti braccia l’ una . Talvolta però si tro-
vano coll’ accusativo , e la preposizione per .
Bocc. g. 8. n. 7. Questa non è stata lunga per
lo terzo , che fu la sua .
Gli addiettivi, che accennano materia , o
qualità , come dotto , valoroso &c. hanno l’a-
blativo colla preposizione in . Alam. Giron.
Era quivi in que’ tempi un negromante In
quell’arte dottissimo , ed esperto .
Gli addiettivi , che accennano separazio-
ne , vogliono l’ ablativo colla preposizione
da , o di , e così diciamo : esule dalla pa-
tria , alieno dallo studio , sicuro da’ pericoli , pu-
ro da ogni colpa , privo d’ amici, e simili.
DE’ NOMI COMPARATIVI.
IL comparativo innanzi a se può avere av-
verbj determinativi , o di misura , come
molto , più , poco , tanto , quanto &c. ma dopo
ordinariamente ha il genitivo . Bocc. n. I. Non
so cui io mi possa lasciare a riscuotere il mio
da loro più convenevole di te .
Ammette non di rado il nominativo dopo
di se , con la particella che in mezzo . Bocc.
g. 9. n. 3. Rimarrai più sano , che pesce . Pe-
trar. Una donna più bella assai , che ’l sole , E
più lucente .
Oltre
/ BEGIN PAGE 325 /
Oltre al caso suddetto , può il compara-
tivo avere dopo di se altro caso dinotante
eccesso , come per esempio : Pietro è più al-
to di Paolo un sommesso . Ma questo caso il
riceve come addiettivo , e di sua natura , non
come comparativo.
DE’ SUPERLATIVI.
USano i Toscani con molta varietà i su-
perlativi , e perciò qui intorno alla lo-
ro varia costruzione porremo alcune brevi
osservazioni .
Osservazione prima .
A’ superlativi si aggiugne talvolta presso
gli antichi qualche accrescimento , o termi-
ne . Nov. ant. 43. Narcisso fu molto bellissi-
mo . Bocc. g. 2. n. 9. Questa tua così santissi-
ma donna .
Osservazione seconda .
Il superlativo talora è assoluto, come quan-
do si dice : Cicerone fu eloquentissimo : e tal-
volta ha relazione all’ altre cose dello stesso
genere , e accenna eccessivo sopra di quelle .
I Latini mettevano tali cose in genitivo plu-
rale , e dicevano per esempio : Cicero fuit
Romanorum eloquentissimus ; ovvero in geniti-
vo singulare di nome collettivo : Demosthenes
fuit orator præstantissimus totius Græciæ . Ma ,
noi le mettiamo in accusativo colla preposi-
X 3 zione
/ BEGIN PAGE 326 /
zione tra , o fra , o coll’ oltre ad . Bocc. n. 5.
La donna tra tutte l’ altre donne del mondo
era bellissima , e valorosa . E Introd. Nella egre-
gia Città di Fiorenza , oltre ad ogni altra Ita-
lica bellissima .
Osservazione terza .
Il superlativo non si considera con rigor
filosofico, onde presso di noi , come ancora
presso i Latini , riceve dopo di se un compara-
tivo , che il superi . Bocc. g. 5. n. 3. Pietro
lietissimo , e l’ Agnolella più , quivi si sposaro-
no .
Anzi è proprio della nostra lingua porre
dopo il superlativo un positivo . Bocc. n. 3.
Intra l’ altre gioje più care , che nel suo teso-
ro avesse , era uno anello bellissimo , e pre-
zioso .
DE PARTITIVI .
I Partitivi ricevono , come in Latino , il ge-
nitivo plurale , o pure l’ accusativo colla
preposizione tra , o altra equivalente . Bocc.
Proem. Fra’ quali s’ alcuno mai n’ ebbe bisogno ,
io sono uno di quegli.
DE’ PRONOMI .
I Pronomi, se sono addiettivi , non hanno
caso , ma si accordano col loro sustanti-
vo. Se sono a maniera di sustantivi , hanno
caso
/ BEGIN PAGE 327 /
caso talvolta quando hanno forza di partiti-
vi , cioè il genitivo, o l’ accusativo col tra ,
come nell’ esempio addotto di sopra. Pari-
mente quando accennano parte indetermi-
nata di alcuna cosa , hanno il genitivo , come
dagli esempj , che adducemmo nel primo li-
bro cap. 24. sotto i pronomi niente , e alquan-
to .
CAP. XIV.
Della Costruzione della preposizione .
GRandissima varietà s’ incontra nella no-
stra lingua intorno a’ casi , a’ quali ser-
vono le preposizioni , e perciò non si può
stabilire fermamente a qual caso serva cia-
scuna preposizione . Sarà adunque necessario
accennare , qual caso dar si possa a ciascuna
preposizione, cogli esempi de’ buoni Autori,
e colla maggior brevità possibile, trattando
prima delle semplici preposizioni, e appres-
so delle composte .
DELLE PREPOSIZIONI SEMPLICI.
LE preposizioni semplici sono quelle , che
di più preposizioni non sono composte ,
e sono le seguenti .
DI . Serve ordinariamente al genitivo , di
X 4 cui
/ BEGIN PAGE 328 /
cui è segno , avanti a’ nomi , pronomi av-
verbj, preposizioni , e infiniti . Bocc. Erano
gli anni della fruttifera incarnazione del Fi-
gliuolo di Dio al numero pervenuti di mille
trecentoquarantotto = In cambio di ciò, ch’ io ri-
cevetti = Intendo di raccontare cento novelle .
Gio. Vill. Non però , che fosse della gran-
dezza di prima . Boccacc. La quale tornò , e
disse di sì .
Serve talvolta al dativo in vece di a . Bocc.
Erano uomini , e femmine di großo ingegno , e
i più di tali servigj non usati = Ischia è un’
isola assai vicina di Napoli = Io ho trovata
una giovane secondo il cuor mio assai presso di
qui .
Serve anche all’ ablativo in vece di da ;
non solamente ne’ casi di separazione , come
sì è veduto , ma in altri ancora . Bocc. g. 4. n. 9.
Il Guardastagno passato di quella lancia, cad-
de , e poco appresso morì . E g. 6. n. 10. Cer-
taldo è un Castello di Valdelsa , il quale quan-
tunque picciol sia , già di nobili uomini , e d’a-
giati fu abitato . E ivi . Chiunque di questi
carboni in segno di croce è tocco , tutto quello
anno può viver sicuro , che fuoco nol toccherà ,
che non si senta .
Parimente serve all’ ablativo in vece di con,
o in . Bocc. Maestri lavorate di forza = Ve
ne potreste andare di brigata .
Fa ancora le veci di per . Liv. Egli pia-
gnea ,
/ BEGIN PAGE 329 /
gnea , e di grande pietà non potea molto fa-
re . Bocc. Abbi di certo , che niuno altro uom
vive , il quale te quant’ io ami .
Serve altresì all’ accusativo , e all’ ablati-
vo, in forza dell’ ex , e dell’ inter de’ Lati-
ni . Dante Conviv. La natura umana è per-
fettissima di tutte le altre nature di quaggiù .
Talora è segno di particolarità , e vale al-
cuni , o alquanti , e s’ addatta a più casi .
Bocc. Ebbevi di quelli , che intender vollono
alla Melanese . = Fece due galee sottili arma-
re , e messivi su di valenti uomini , con esse so-
pra la Sardigna n’ andò .
Si usa ancora per dinotar figliuolanza , ma-
niera comune a noi , e a’ Greci ; e così nel
Boccaccio leggiamo : Giannuol di Severino ,
Cecco di Messer Fortarrigo , Cecco di Messere
Angiulieri, e simili.
E‵ ancora contrassegno, o titolo, ma in-
corporata coll’ articolo . Tav. Rit. Colla Pul-
zella Isotta delle bianche mani. Bocc. g. 8. n.9.
Siccome è il Tamagnin della Porta. Cioè che
sta alla Porta.
A .
Serve d’ordinario al dativo , di cui è se-
gno . Bocc. Infino all’ ora della cena libertà con-
cedette a ciascuno .
Serve ancora all’ accusativo in forza della
preposizione ad de’ Latini . Amm. ant. L’ani-
mo nostro si dee chiamare ogni dì a render ra-
gione .
/ BEGIN PAGE 330 /
gione . Bocc. Fu preso da due , e segretamen-
te a Tancredi menato = Di notte se ne fuggi-
rono a Rodi .
E in forza di per . Bocc. g. 4. n. Io voglio,
che in luogo delle busse , ch’ egli vi diede a
mie cagioni , che voi abbiate questa consola-
zione . Passav. f. 4. Avvegnachè a sua colpa la
navicella sia fracassata , e rotta . Tav. rit. Ne
furono assai allegri , da poi che l’ ebbono a si-
gnore .
E in forza d’ in . Nov. ant. 46. A voi non
sarebbe onore , che ’l vostro legnaggio andasse
a povertade .
Serve all’ ablativo in senso d’ in , o con .
Nov. ant. 3. Essendo poveramente ad arnese .
Bocc. Se tu non fossi di conforto bisognoso , co-
me tu se’ , io di te a te medesimo mi dorrei .
Talora fa le veci del pro de’ Latini . Bocc.
L’ avrebbe egli a se amata più tosto , che a te .
E talvolta ha forza dell’ablativo della quin-
ta de’ Neutri de’ Latini . Bocc. In abito di pe-
regrini ben forniti a danari , e care gioje .
Nov. ant. 2. Cotanto dico , che ’l cavallo è nu-
tricato a latte d’ asina .
Vale talvolta a modo , a similitudine . Boc-
caccio g. 9. n. 5. Cotesti tuoi denti fatti a bi-
scheri .
E talora a rispetto, a comparazione . Boc-
caccio g. 6. n. 5. Con viso piatto, e ricagnato ,
che a qualunque de’ Baronci più trasformato
l’ ebbe , e sarebbe stato sozzo .
Fa
/ BEGIN PAGE 331 /
Fa ancora le veci di da segno dell’ abla-
tivo . Bocc. Amenduni gli fece pigliare a tre
suoi servidori . E n. 2. Appresso , a gran va-
lenti uomini il fece compiutamente ammaestra-
re nella nostra Fede . E g. 3. n. 10. E udendo
a molti commendare la Cristiana Fede , un dì
ne domandò alcuno . E g. 2. n. I. Fatevi a cia-
scun , che mi accusa, dire quando , o dove gli
tagliai la borsa .
A incorporato coll’articolo , e aggiunto a
certi nomi femminini forma modi avverbiali
indicanti alcuna particolar maniera . Così nel
Boccaccio abbiamo : alla trista, alla scape-
strata , all’ antica &c. , e nell’ uso diciamo :
alla franzese , alla romana &c.
A si adopera elegantemente per in in signi-
ficazione di tempo . Bocc. g. 7. n. I. Egli è la
fantasima , della quale io ho avuta a queste
notti la maggior paura , che mai si avesse .
Congiunta cogl’ infiniti, dà loro la forza
de’ gerundi Latini . Bocc. Nè a negare , nè a
pregare son disposta = A trargli l’ oßo potreb-
be guerire = Or via va colle femmine a span-
der lagrime. E Concl. Quando questo fu , egli
erano poche a scrivere delle soprascritte no-
velle. E g. 10. n. 8. Che ho io a curare, se
il calzolaio piuttosto , che ’l filosofo , avrà
d’ un mio fatto, secondo il suo giudicio, disposto
in occulto , o in palese , se il fine è buono?
Talvolta vale la preposizione inverso .
Bocc.
/ BEGIN PAGE 332 /
Bocc. Montata in sulla torre , e a tramonta-
na rivolta cominciò a dire .
DA .
E segno dell’ ablativo , che dinota opera-
zione , separazione , termine di partenza , o
differenza . Bocc. Chi non v’ ama , e da voi
non disidera d’ eßere amato , sì mi ripiglia =
Credendo lui eßere tornato dal bosco , avvisò
di riprenderlo forte = Petrar. Pien d’ un vago
pensier , che mi disvia Da tutti gli altri =
Quand’ era in parte altr’ uomo da quel, ch’ io
sono .
Congiunta co’ pronomi primitivi ha forza
di solo , e senza compagnia , e vi si frammet-
te talvolta il per . Dante . Poscia rispose lui :
da me non venni. Lib. cur. malattie . Molte
malattie gueriscono da per se, senza l’ opera
del medico .
Fa le veci della preposizione , o sia del se-
gnacaso di . Bocc. Degno cibo da voi il re-
putai .
E della preposizione , o sia segna caso a .
Bocc. Vi menerò da lei , e son certo , ch’ ella
vi conoscerà = Andrà faccendo per la piazza
dinanzi da voi un gran sufolare .
Talvolta accenna cagione , e vale l’ob de’
Latini. Bocc. Una valle ombrosa da molti ar-
bori.
Accenna la patria particulare. Bocc. g. 5.
n. 5. Questa giovane non è da Cremona , né da
Pavia ,
/ BEGIN PAGE 333 /
Pavia , anzi è Faentina . Ma se la patria è
più generale , come Regno , Provincia , Iso-
la , si adopera il di . Bocc. g. 3. n. 8. Disse il
Monaco : io sono anche morto , e fui di Sardi-
gna .
Spesso ancora accenna attitudine , o con-
venevolezza . Bocc. g. 3. n. 9. Essendo ella già
d’ età da marito . E g. 4. n. 4. Gioje da don-
ne portandole , come i mercatanti fanno , a ve-
dere . E g. 5. n. 4. Materia di crudeli ragiona-
menti , e da farvi piagner v’ imposi.
Vale talvolta in circa . Bocc. g 3. n. 8. In co-
sì fatti ragionamenti fu tenuto Ferondo da die-
ci mesi . E g. 8. n. 10. Comperate da venti botti .
Può ancora valere di che , onde , congiun-
to coll’ infinito , o col nome . Bocc. n. 3. Pen-
sossi costui avere da poterlo servire . E g. 5.
n. 10. Sì da cena ci ha : noi siamo molto usa-
te di far da cena , quando tu non ci se’ .
Accompagnato cogli avverbj molto , poco ,
niente , bene , tanto , più , sottintendendosi l’ in-
finito fare , o altro equivalente , accenna abi-
lità , o attitudine . Bocc. g. 6. n. 2. Sempre
poi per da molto l’ ebbe, e per amico . E g. 3.
n. 2. Uomo , quanto a nazione, di vilissima
condizione , ma per altro da troppo più , che
da così vil mestiere . Lasca Spir. Tu se’ più
da poco , che Maso , che si lasciava fuggire i
pesci cotti. Bocc. g. 10. n. I. Molti , i quali
a comparazione di voi da niente sono . E g. 2.
n. 2.
/ BEGIN PAGE 334 /
n. 2. Par persona molto da bene , e costuma-
to . E g. 3. n. 10 Non sospicò , che ciò Guccio
Balena gli aveße fatto , perciocchè nol conosce-
va da tanto .
Da innanzi a Verbo , o a nome dinota con-
venienza , o necessità ; ma davanti a’ Verbi si
congiugne coll’ infinito, ed equivale al no-
minativo gerundio . Bocc. g. 2. n. 3. Diede
ordine a quello , che da far fosse . E g. 6. Nel
princ. Dioneo , questa è questione da te .
Ne’ giuramenti , e nelle asserzioni dinota
convenienza alla qualità della persona , che
parla. Stor. Aiolf. Ti giuro da cavaliere ,
ch’ io non l’ ho veduto . Redi Lett. Non le ri-
spondo da medico , ma bensì da suo buono
amico .
IN .
Questa preposizione , se ad essa si segue l’ ar-
ticolo, si muta in ne , e s’ incorpora coll’ ar-
ticolo stesso , dicendo nel , nella &c. Petrar.
son. 2. Onde i miei guai Nel comune dolor s’ in-
cominciaro . Pure si trova in innanzi all’ arti-
colo , e talvolta accompagnato anche col nel .
Buti Inf. 20. Secondo che dice in lo testo . Fi-
renz. rim. 101. Asconder rose colte in la vii ce-
nere . Amm. ant. dist. 25. rub. 3. amm. 2. In nel
numero di pecore , e di fiere è avuto qualunque
è oppresso da’ diletti del corpo .
Si usa co’ Verbi di stato. Bocc. In un let-
tuccio assai piccolo si dormiva.
E co’
/ BEGIN PAGE 335 /
E co’ Verbi di moto. Bocc. n. 2. Montò a
cavallo , e come più tosto potè , se n’ andò in
Corte di Roma .
E in senso di dentro . Bocc. g. 7. n. 3. Que-
sti son vermini , ch’ egli ha in corpo .
E in senso di sopra . Bocc. g. 7. n. 9. Mol-
to meglio sarebbe a dar con essa in capo a Ni-
costrato .
In vece d’ a . Bocc. Fiamm. O Iddio , ve-
ditore de’ nostri cuori , le non vere parole det-
te da me , non m’ imputare in peccato .
In vece di con . Bocc. Orribilmente comin-
ciò i suoi dolorosi effetti , ed in miracolosa ma-
niera a dimostrare .
In vece di per . Bocc. E così in contrario
le taverne , e gli altri disonesti luoghi visitava
volentieri .
In vece di contro . Bocc. lett. Pin. Ross. Vi-
tellio Cesare sentì la ribellione de’ suoi eserci-
ti, ed in se vide rivolto il Romano popolo .
In significato di verso . Petrar. In me mo-
vendo de’ begli occhi i rai , Cria d’amor pen-
sieri .
In senso di nello spazio . Bocc. Cento no-
velle raccontate in dieci giorni da una onesta
brigata di sette donne , e di tre giovani .
Per a maniera , a foggia . Bocc. Niuna co-
sa valendole il chieder mercè colle mani in
croce .
Dinota ancora talvolta età indeterminata
Fra
/ BEGIN PAGE 336 /
fra due termini distanti . Bocc. Giovane anco-
ra di ventotto in trent’ anni.
Si trova ancora usato per intorno . Boccacc.
g. 4. n. 2. Meßagli una catena in gola , mandò
uno al rialto , che bandisse .
PER .
Co’ Verbi di moto pare che riceva l’accu-
sativo alla maniera de’ Latini . Bocc. Cominciò
a fare le più smisurate cortesie , che mai fa-
cesse alcuno altro , a chi andava , e veniva
per quindi .
Co’ Verbi di stato, in senso d’ in, riceve
l’ ablativo. Bocc. Per le sparte ville , e per
gli campi, e per gli loro colti , e per le case
di dì , e di notte morieno .
Si usa in vece di a, e di da , e di con .
Bocc. Per modo di diporto se n’ andò alla pic-
cola casetta di Federigo = Ho meco stesso pro-
posto di volere in quel poco , che per me si può,
alcuno alleggiamento prestare . Guid. G. Al qua-
le errore per queste parole rispose .
Talvolta dinota cagione , mezzo, o stru-
mento. Petrar. Felice l’ alma , che per voi so-
spira . Bocc. g. 2. n. 9. Per vergogna quasi mu-
tolo divenuto , niente dicea . Gio. Vill. Si ru-
bellò a’ Fiorentini il Castello di Piano Travi-
gne di Valdarno per Carlino de’ Pazzi di Val-
darno . Bocc. g. 2. n. 4. Fattasi alquanto per lo
mare , che già era tranquillo, e per gli ca-
pelli presolo , con tutta la cassa il tirò in
terra . Accen-
/ BEGIN PAGE 337 /
Accenna talora fine . Petrar. son. 161. Per
ritrovar ove ’l cor lasso appoggi , Fuggo dal
mio natio dolce aer Tosco .
Vale ancora il pro de’ Latini , in significa-
to d’ in favore , in nome , in vece . Bocc. Io
farei per Currado ogni cosa , ch’ io potessi , che
gli piaceße . E g. 5. n. 7. Ad uno M. Currado ,
che per lo Re v’ era capitano , la ’ngiuria fat-
tagli da Piero contata , il fe pigliare . E g. 6.
n. I. Spesso ne’ nomi errando, un per uno al-
tro ponendone .
Aggiunta a’ nomi, benchè sovente quasi a
maniera di ripieno , pure può significare in
luogo, in considerazione , come , e simili. Nov.
ant. 35. Il lodava , siccome egli era , per lo più
cortese signore del Mondo . Bocc. n. I. Eßendo
stato un pessimo uomo in vita , in morte è repu-
tato per Santo = Ebbè ciò , ch’ ella diceva ,
più che per vero. E g. 7. n. 8. Sì di quel d’Ar-
riguccio medesimo la sovvenne , ch’ ella si chia-
mò per contenta.
Preposta all’ infinito, con avanti il Verbo
essere , o stare , gli dà la forza del partici-
pio futuro de’ Latini ; e talvolta significa es-
sere in procinto, pericolo , o risico di fare ,
o farli una cosa . Bocc Io sono per ritrarmi
del tutto di qui . = Tenendo forte con amen-
due le mani gli orli della cassa , a quella gui-
sa , che far veggiamo a coloro , che per affo-
gar sono, quando prendono alcuna cosa . Cec-
Y ch.
/ BEGIN PAGE 338 /
ch. Stiav. prol. E pur con tutto ciò io sto per
dirvelo .
Aggiunta a nomi sustantivi, nell’uso de’ To-
scani , accenna una particolar considerazione .
Adduce il Vocabolario uno esempio dell’uso :
questo cavallo è troppo grasso per barbero .
Cioè considerato come barbero .
Talora è nota di distribuzione . Bocc. Di
quello un mezzo bicchier per uomo deße alle pri-
me mense = Fattesi venire per ciascuno due pa-
ja di robe , diße : prendete queste .
Accenna ancora mezzo d’ origine , e discen-
denza , ed è modo comune a’ Greci. Boccacc.
Essi son per madre dicesi di paltoniere . Gio.
Vill. E di loro per donna nacquero tutti i Con-
ti Guidi .
Dinota alcuna volta tempo , e vale duran-
te un tale spazio . Bocc. A ciascuno per un
giorno s’ attribuisca il peso , e l’onore . E g. 2.
n. 7. E quivi per più dì dimorando , si mostrò
forte della persona disagiato .
Si giugne a’ nomi dinotanti spazio , nume-
ro , o misura . Bocc. g. 5. n. I. Si videro for-
se per una tratta d’ arco vicini alla nave .
Ha talora forza di benchè , qualunque , e si-
mili . Bocc. g. 4. n. 6. nel princ. Assai volte
avevano quella canzone udita cantare , nè mai
avevan potuto , per domandarne , sapere , qual
si foße la cagione , perchè foße stata fatta . E
g. 7. n. I. Temere non ci bisogna , ch’ ella non ci,
può ,
/ BEGIN PAGE 339 /
può , per potere , ch’ ella abbia , nuocere .
E rileva talvolta la forza del gerundio .
Boccacc. g. 8. n. 9. Cominciò ad andarsene lungo
S. Maria della Scala, verso il prato d’ Ogni
Santi , dove ritrovò Bruno , che per non po-
ter tener le risa, s’era fuggito .
CON .
Preposizione congiuntiva , che accenna stru-
mento, compagnia , e modo , e serve all’ a-
blativo . Bocc. Quello , che avete mangiato ,
e stato il cuore di M. Guglielmo Guardasta-
gno , perciocchè io con queste mani gliele strap-
pai = Con Griselda lungamente , e consolato
visse = Tito non restando di piagnere , con fa-
tica così gli rispose .
Co’ pronomi me , te , se si unisce la pre-
posizione con, lasciando la n, e dicendo me-
co , teco , e seco , com’ è noto. Anzi gli an-
tichi dicevano ancora nosco, e vosco, che al-
tri oggi non direbbe , se non se nel verso .
Seco medesimo ha forza di avverbio , onde si
dice anche di femmina . Bocc. g. 7. n. 5. Non
si seppe sì occultare, ch’ egli non foße pre-
stamente conosciuto dalla donna . La quale , que-
sto vedendo , diße seco medesimo : lodato sia
Iddio .
Parimente con s’incorpora coll’ articolo del-
la voce seguente , come più distintamente si
vedrà nel terzo libro .
Y 2 DEN-
/ BEGIN PAGE 340 /
DENTRO, ENTRO .
Dentro, quando è preposizione, dinota la
parte interna , e riceve ordinariamente il da-
tivo . Bocc. Eße dentro a’ dilicati petti temen-
do , e vergognando tengono le amorose fiamme
nascose .
Riceve ancora l’ accusativo. Dante. Così
dentro una nuvola di fiori Donna m’ apparve
sotto verde manto .
E si trova ancora col genitivo, e coll’ablati-
vo . Passav. f. 242. E avvegnachè non possa
adoperare dentro alla mente per diretto , per
indiretto puote aßai di male operare : e se non
dentro della porta , almeno dentro dagli anti-
porti , che sono i sentimenti .
Entro comunemente si accompagna coll’ac-
cusativo . Bocc. Io voglio , che tu giaccia sta-
notte entro il letto mio .
Riceve ancora il dativo . Petrar. Le not-
turne viole per le piagge , E le fiere selvag-
ge entro alle mura .
Le si propone la particella per , ed è pro-
prietà di linguaggio . Petrar. Al fin vid’ io per
entro i fiori, e l’ erba Pensosa ir sì leggia-
dra , e bella donna .
FUORA , FUORI , e in verso FUORE.
Preposizione , che nota separamento , e di-
stanza , ed è contraria di entro , o dentro .
Vuole il genitivo . Bocc. A lui parve esser si-
curo , e fuor delle mani di coloro. Petrar. Usci-
ta
/ BEGIN PAGE 341 /
ta è pur del bell’ albergo fuora = Or m’ ha
d’ ogni riposo tratto fuore .
Si trova coll’ accusativo . Petrar. Fuor tut-
ti i nostri lidi, Nell’Isole famose di fortuna
Due fonti ha .
SOPRA .
Preposizione dinotante sito di luogo supe-
riore , contraria di sotto . Le più volte si co-
struisce coll’ accusativo . Bocc. Presala , sopra
la barca la misero , e andar via.
Non di rado riceve il dativo . Bocc. Con-
verrà , che voi n’ andiate sopra ad un’ albero .
E talvolta il genitivo . Bocc. Cominciò a
piangere sopra di lei, non altramente , che se
morta fosse .
Si adopera per di là da , oltre , più che .
Bocc. Gran parte delle loro possessioni ricompe-
rarono , e molte dell’ altre comperar sopra quel-
le = Ben cento miglia sopra Tunisi ne la por-
tò = La quale un giovanetto amava sopra la
vita sua.
E per contro , addoßo . Bocc. Ordinarono un
grandissimo esercito , per andare sopra i nimi-
ci = Partito il Re, subitamente furon molti so-
pra i due amanti .
E per appresso , vicino . Bocc. Marsiglia è
in Provenza sopra la marina posta .
E in vece di per . Boccacc. Tante quistioni
malvagiamente vincea , a quante a giurare di-
dire il vero sopra la sua fede era chiamato .
Y 3 E per
/ BEGIN PAGE 342 /
E per circa, intorno. Bocc. Laber. Maravi-
gliatomi forte sopra le vedute cose cominciai a
pensare .
E per innanzi , avanti . Buti comm. Inf.
Nella notte del Venerdí Santo sopra ’l Sabato
Santo .
Accenna talvolta pegno. Bocc. Messo s’ era
in prestare a’ Baroni sopra castella , e altre
loro entrate = Avendo portate tre belle , e ric-
che robe, volendo il suo oste eßer pagato , pri-
mieramente gli diede l’ una, e appreßo conven-
ne gli desse la seconda , e cominciò sopra la ter-
za a mangiare .
Sopra sera vale già venuta la sera . Bocc.
Urban. Quivi sopra sera arrivò furiosamente
un bellissimo giovane , con una testa di cinghia-
le nella mano .
Sopra parto , o sopra partorire vale nell’ at-
to , o poco dopo l’ atto del partorire. Gio.
Vill. Tornando la detta Reina , morì sopra
partorire ella , e la creatura . Lasca Sibill.
Morì sopra parto in cotesta casa .
Sopra se significa pensoso. Bocc. La don-
na , udendo questo , alquanto sopra se stette .
Significa ancora diritto in sulla persona . Boc-
caccio. Colle carni più vive , e colle barbe più
nere gli vedeste , e sopra se andarne, e caro-
lare , e giostrare . E significa ancora non si
appoggiato . Boccacc. Infino a tanto , che per
M. Torello non le fu detto , che alquanto so-
pra se stesse. So-
/ BEGIN PAGE 343 /
Sopra ciò accenna soprantendenza a qual-
che uficio . Bocc. Dando a coloro , che sopra
ciò sono per iscritto tutta la mercatanzia , è
dato per gli detti al mercatante un magazzi-
no . Oggi si scrive sopracciò, e in Toscana
ha forza di nome, e significa il sopranten-
dente all’ ufficio , di cui si parla . Salviati
Granch. Prese partito di ricorrere al Soprac-
ciò in Dogana .
SOTTO .
Preposizione , che dinota inferiorità di sito,
e talvolta di condizione , e di grado, ed è
correlativa di sopra . Si costruisce ordinaria-
mente coll’accusativo . Bocc. Sotto un poco
di tetto , che ancora rimaso v’ era , si ristrin-
sono amenduni . Talora col genitivo . Bocc.
Ciascuno e castella, e vassalli aveva sotto di
se . E talvolta ancora col dativo . Boccacc.
Fiamm. lib. 2. E quella , che di lasciar t’ap-
parecchi, so che conosci lieta , pacifica , abbon-
devole , magnifica , e sotto ad un solo Re .
Sotto si adopera in significato di con. Boc-
caccio . Avrei ben saputo , e saprei sotto al-
tri nomi comporla . E canz. 4. Quanto si dol-
ga con ragione il cuore D’ esser tradito sotto
fede amore . Matt. Vill. Per comandamento de’
detti due Re , sotto pena di cuore , e di ave-
re s’ uscirono del reame di Francia .
TRA , FRA .
Tra , ch’ è abbreviata da intra , e Fra da
Y 4 infra,
/ BEGIN PAGE 344 /
Infra , sono due preposizioni, che significano
in mezzo , e vogliono l’ accusativo .
Quando sono congiunte con una sola co-
sa , accennano rinchiudimento in quella.
Bocc. Fiamm. lib. I. Con questa letizia a me
sola fra verdi erbette era diviso sedere in un
prato . E più abbasso: Poi quasi stanca tra la
più folta erba postami a giacere , mi posava .
Congiunte con due cose, accennano lo spa-
zio , o il comprendimento in mezzo ad amen-
due. Bocc. g. 3. n. 2. In una gran sala del pa-
lagio del Re , la quale in mezzo era tra la
camera del Re, e quella della Reina , si na-
scose . Petrar. Ov’ ella ebbe in costume Gir fra
le piagge , e ’l fiume . Bocc. Laber Fra gli
aspri sterpi, e le rigide piante , piangendo ,
mi parea dimorare . E nell’ Amet. Se medesi-
mo mira quasi dubbio tra ’l sì, e ’l no d’ ac-
quistarla .
Vagliono talvolta per mezzo . Bocc. Sali-
ta in sulla sala , tra uomo , e uomo là se
n’ andò .
Talora nella conversazione , nel numero , nel-
la compagnia . Bocc. Fannosi a credere , che
da purità d’animo proceda il non saper tra le
donne , e co’ valentuomini favellare .
E in vece d’ in. Passav. E non creda la per-
sona , che la confessione non sia intera , perch’el-
la si confessi tra più volte , e in diversi tempi
ad uno medesimo confessore per legittima ca-
gione . Tal-
/ BEGIN PAGE 345 /
Talvolta accennano perplessità . Bocc. g. 5.
n. 8. Avendo queste cose vedute , gran pezza
stette tra pietoso, e pauroso . Petrar. son. 119.
In riso , e ’n pianto, fra paura, e spene, Mi
rota sì , ch’ ogni mio stato inforsa .
Si adoperano anche per addentro . Bocc.
g. 2. n. 6. Un dì ad andare fra l’ isola si mise .
Gio. Vill. Se n’ andaro tutti in Granata fra terra.
E per fuori, oltre , sopra. Bocc. g. 5. n. I.
Egli tra gli altri suoi figliuoli ne aveva uno ,
il quale di grandezza, e di bellezza di cor-
po tutti gli altri giovani trapassava . E g. 2.
n. 9. E avendo una sera fra l’ altre tutte lie-
tamente cenato , cominciarono di diverse cose
a ragionare .
Tra si adopera non di rado per distingue-
re , e insieme congiugnere due cose , o so-
lo , o posponendogli altra particella . Ed in
tal caso è regola fermamente osservata da’
buoni Autori , che il tra si metta solamen-
te al principio del primo termine , e nel
principio del secondo termine gli corrispon-
da la congiunzione e , o ed. Ciò s’ intende-
rà meglio cogli esempj . Boccacc. g. 4. n. 2. Il
condusse in sulla piazza , dove tra quegli, che
venuti gli eran dietro , e quegli ancora , che,
udito il bando , da Rialto venuti v’ erano, era
gente senza fine . E g. I. n. 2. E ora che egli
s’ accorse , e ch’ egli ancora da alcuno fu in-
formato, egli trovò &c. E g. 3. n. 10. La gio-
vane
/ BEGIN PAGE 346 /
vane tra con parole, e con atti il mostrò lo-
ro . E g. 3. n. I. Tra per l’ una cosa, e per l’al-
tra non vi volli star più . Matt. Vill. Più di
dugento tra dell’ una setta , e dell’ altra se ne
trovarono morti di ferro .
Fra me, fra se, fra loro accennano l’ in-
terno della persona , o delle persone , da cui
reggesi il sentimento . Bocc. Fiamm. Fra me
sovente dicendo. E g. I. n 7. Fra se medesimo
disse : veramente è questi così magnifico , come
uom dice , E g. 5. n. 6. Fra se deliberarono di
doverla pigliare . E g. 5. n. 3. Cominciaron fra
loro ad aver consiglio .
Si trova usato fra in forza della particel-
la di nel primo termine di uno spazio di
tempo, colla corrispondenza della congiun-
zione e nel secondo termine . Boccacc. g. 8.
n. 10. Scrivemi mio fratello , che senz’ alcun
fallo io gli abbia fra qui, e otto dì mandati
mille fiorini d’ oro .
PRESSO , VICINO .
Preposizioni dinotanti prossimità di luogo,
benchè talvolta ad altre prossimità si addat-
tino .
Presso ordinariamente ha il dativo , ma può
anche ricevere il genitivo , e l’ accusativo .
Bocc. g. 2. n. 4. Assai presso a Salerno è una
costa sopra il mare riguardante , la quale gli
abitanti chiamano la costa di Malfi. E g. 8.
n. 7. Tra salci, ed altri alberi presso della
torri-
/ BEGIN PAGE 347 /
torricella nascoso era. E g. 8. n. 9. Infin presso
le donne di Ripole il condusse .
Vale talvolta circa , intorno . Boccacc. g. 8.
n. 9. Presala di peso , credo, ch’ io la portassi
presso a una balestrata . Gio. Vill. Stando all’
assedio di Genova presso di cinque anni .
E ancora si usa per in comparazione , al
paragone . Petrar. Che presso a que’ d’ amor
leggiadri nidi, Il mio cor lasso ogni altra vi-
ta sprezza .
Lo stesso che presso significano appo, e ap-
preßo .
Appo , che scrivesi sempre disaccentata , ha
ordinariamente l’ accusativo, ma si trova an-
cora col genitivo , e col dativo ; e significa
talvolta prossimità morale a una persona ,
cioè nel giudicio, concetto , o confidenza di
essa ; talvolta vale in comparazione ; e tal-
volta accenna alla Latina puro stato in luogo.
Bocc. Ordinò, che colui de’ suoi figliuoli, appo
il quale , siccome lasciatogli da lui, fosse questo
anello trovato , che colui s’ intendesse eßere il
suo erede . Liv. decad. 3. Fu risposto agli am-
basciadori , non essere appo di loro alcun me-
rito . Passav. f. 283. Gli umili si rallegrano
degli spregj , e de’ disonori , e sono contenti di
vedersi tenere vili , e dispetti nel parere al-
trui , come sono appo a se nel parere loro.
Bocc. Quantunque appo coloro , che discreti
erano , io ne fossi lodato . Cioè nel giudizio
di
/ BEGIN PAGE 348 /
di coloro . Bocc. g. 6. n. 2. Bonifazio Papa,
appo ’l quale M. Geri Spina fu in grandissi-
mo stato . Cioè nella sua grazia , e confiden-
za. Gio. Vill. I Baroni veggendo il picciol po-
dere del Re di Araona, appo la gran poßan-
za del Re Carlo , si furono molto sbigottiti.
Cioè in comparazione . Gio. Vill. Papa Gio-
vanni sopraddetto appo Vignone in Proenza
in pubblico Concistoro diede sentenza di scomu-
nicazione contro Lodovico Dogio di Baviera .
E’ stato in luogo alla Latina : apud Avenio-
nem.
Appresso serve al genitivo , al dativo , e
all’ accusativo. Bocc. g. 4. nel fine . Appres-
so della bella fonte con grandissimo piacere , e
ben serviti cenarono . E n. I. S’ eran posti ap-
presso a un tavolato, il quale la camera , do-
ve Ser Ciappelletto giacea, divideva da un’ al-
tra . E g. I. n. 6. nel princ. Emilia , la qua-
le appresso la Fiammetta sedea . E questa co-
struzione coll’ accusativo è la più frequente .
Ha appresso tutte le sopraccennate signifi-
cazioni di presso . Di più si adopera per do-
po . Boccacc. g. 4. n. I. Se appresso la morte
s’ ama , non mi rimarrò d’ amarlo. E g. 2. n. 5.
Or via , mettiti avanti, io ti verrò appresso .
Vicino serve al genitivo , e al dativo. Boc-
cacc. g. 3. n. 4. Vicino di S. Brancazio stette
un buono uomo, e ricco. E g. 8. n. 7. Assai vi-
cino stava alla torricella.
Sì
/ BEGIN PAGE 349 /
Sì usa per circa , intorno . Bocc. g. 10. n 4.
Priegoti, che perch’ ella sia nella mia casa vi-
cin di tre mesi stata , ch’ ella non ti sia men
cara . E in senso del parum abesse de’ Lati-
ni . Bocc. g. 5. n. 3. Gittò la sua lancia nel
fieno, e assai vicin fu ad uccidere la nascosa
giovane .
RASENTE .
Vale tanto vicino, ch’ e’ si tocchi quasi la
cosa, ch’ è allato. Vuole l’ accusativo , ma
riceve ancora il dativo . Pier. Cresc. Appren-
donsi meglio se s’ innestano in pedale rasente la
terra . Franco Sacchetti . Fece un foro con un
succhio in quel muro rasente a quella pentola .
LUNGO .
Vuole l’ accusativo , ma riceve ancora il
dativo , e in verso talvolta il genitivo. Signi-
fica prossimità , e quando serve a’ Verbi di
moto, significa moto vicino a una cosa , e
per lo verso della sua lunghezza. Boccacc.
g. 8. n. 9. Cominciò ad andarsene lungo S. Ma-
ria della Scala verso il prato d’ Ognißanti. E
g. 7. n. 8. Conciofossecosachè la sua camera fos-
se lungo la via . E g. 7. in fin. E lungo al
pelaghetto a tavola postisi , quivi cenarono .
Dante . E quale Ismeno già vide , ed Asopo
Lungo di se di notte furia , e calca .
LUNGI , LONTANO , DISCOSTO .
Lungi, e in verso lunge , vuole l’ablati-
vo , ma riceve ancora il dativo . Brunett.
Teso-
/ BEGIN PAGE 350 /
Tesorett. Lo tuo celliere dee essere contro a
Settentrione , freddo, e scuro , e lungi da ba-
gno , e da stalla, e da forno. Petrar. Tanto
dalla salute mia son lunge . Dante. Non mol-
to lungi al percuoter dell’ onde Siede la fortu-
nata Callaroga .
Lontano s’ addatta a’ medesimi casi , che lun-
gi , ed è usato dal Boccaccio nel Decame-
rone . G. 3. n.5. Da una parte della sala as-
sai lontano da ogni uomo colla donna si pose a
sedere . E g. 9. n. 3. Non guari lontano al bel
palagio trovò Natan tutto solo . E g. 4. n. 8.
Mi parrebbe , che per fuggir questo , voi il do-
veste in alcuna parte mandare lontano di qui .
Discosto si addatta al dativo, e all’ ablati-
vo . Bemb. Asol. E poco da lei discosto tra
gli alberi un uom tutto solo passeggiare . Gelli
Circe. Tanto gli ho trovati discosto al vero .
VERSO , INVERSO.
Oltre a’ significati, che accennammo ne’ mo-
ti a luogo, hanno ancora talvolta i seguenti.
Si usano per in comparazione, in paragone .
Dante. Tutte l’ acque , che son di qua più mon-
de , Parrieno avere in se mistura alcuna , Ver-
so di quella , che nulla nasconde = Che inver-
so d’ ella Ogni dimostrazion mi pare ottusa .
E per intorno, circa . Gio. Vill. Verso la se-
ra , quando i Viniziani si ricoglievano , aperso-
no una porta della terra . Matt. Vill Inverso
l’ uscita di Giugno cavalcaro verso Bologna.
E si
/ BEGIN PAGE 351 /
E si noti , che tali preposizioni , quando si
danno al tempo , e al luogo , sempre voglio-
no l’ accusativo ; ma quando si danno a per-
sona , ricevono il genitivo.
FINO , INFINO , SINO , INSINO .
Preposizioni, che significano termine di mo-
to , o di azione , delle quali abbiamo detto ab-
bastanza ne’ moti infino a luogo .
CIRCA.
Preposizione, che vale il circum, circa de’
Latini , non usata però dal Boccaccio , che in
luogo di essa usa intorno , forse, e simili ;
che si trova contuttociò in altri autori del
buon secolo , col genitivo , col dativo , e
coll’ accusativo. Dante. Così di quelle sem-
piterne rose Volgensi circa noi le duo ghirlan-
de . Pier Cresc. Sopra la quale sia fatto muro
d’ altezza di una puntata, ch’ è circa di tre
braccia. Matt. Vill. La dierono a’ collegati ,
ricevuti da loro circa a diecimila fiorini d’oro.
OLTRE .
Preposizione, che serve al dativo, e all’ac-
usativo , e significa il præter de’ Latini. Boc-
cacc. n. I. Non solamente l’ avere ci ruberan-
no , ma forse ci torranno , oltre a ciò , le per-
sone .
E in senso di plusquam. Bocc. g. 2. n. 9.
Non era sì poco , che oltre a diecimila dobbre
non valesse .
E in senso di supra. Petrar. L’ alma mia
fiamma , oltra le belle bella .
E in
/ BEGIN PAGE 352 /
E in significato del præter esclusivo de’ La-
tini , che noi esprimiamo col fuori. Boccacc.
g. 2. tit. Chi da diverse cose infestato , sia,
oltr’ alla sua speranza , riuscito a lieto fine .
Mare, monti, Arno , modo , misura si trovano
ne’ buoni Autori quasi sempre in accusativo sen-
za preposizione dopo oltre, di maniera , che
talvolta s’ uniscono in una sola parola , e si usa-
no quasi avverbialmente . Bocc. g. 6. n. 10. Una
santissima , e bella reliquia , la quale io medesimo
già recai dalle sante terre d’ oltre mare Fr.
Giordan. Oltremonti nella Francia non si usa
mai spiccare nullo impiccato , ma tanto vi sta ,
quanto può attenervisi . Gio. Vill. Nel sesto
d’ Oltrarno il primo il campo vermiglio , e sca-
la bianca . Boccaccio g. 2 n. 9. Lo ’ncominciò a
servir sì bene, e sì acconciamente , ch’ egli gli
venne oltremodo a grado . E g. 4 n. 8. Di che
fu oltremisura dolente . Pure si trova con prepo-
sizione nel Bocc g. 10. n. 9. E per Lombardia ca-
valcando , per passare oltre a monti , avvenne,
che si scontrarono in un gentiluomo .
Oltra è lo stesso , che oltre , ma è più del
verso, che della prosa. Petrar. p. I. canz. I7.
Canzon , oltra quell’ alpe Là , dove il Ciel è
più sereno , e lieto , Mi rivedrai sovr’ un ruscel
corrente .
AVANTI , DAVANTI , INNANZI ,
DINANZI , PRIMA .
Preposizioni , che hanno fra se molta somi-
glian-
/ BEGIN PAGE 353 /
glianza nel significato ; ma perchè qualche
varietà nel loro uso s’ incontra, meglio sa-
rà considerarle a una per una.
Avanti vale l’ ante de’ Latini , e vuole l’ac-
cusativo, o ’l dativo : e talvolta riceve il ge-
nitivo . Bocc. n. 7. Avanti ora di mangiare
pervenne là , dove lo Abate era . E g. 2.
n. 3. Camminando adunque il novello Aba-
te ora avanti , e ora appresso alla sua fa-
miglia , gli venne nel cammino presso di se
veduto Alessandro . E nel Filoc. Andò al di-
serto , ove Giovanni avanti di lui era venuto
per annunziarlo .
Avanti significa ancora alla presenza , col
dativo , o coll’ablativo. Bocc. n. 6. Ch’ egli
ogni mattina dovesse udire una Messa in S. Cro-
ce , e all’ ora del mangiare avanti a lui pre-
sentarsi . E nel Filoc. E che ciò , che ti ho con-
tato , sia vero, manifestaloti il sangue mio ,
lo quale per tante ferite puoi vedere avanti
da te spandere.
Davanti vale alla presenza , e si usa col
dativo , coll’ accusativo , e coll’ ablativo, e
più di rado col genitivo . Bocc. g. 2. n. 3. Se in
altra parte , che davanti al Papa, stati fosse-
ro, avrebbono ad Alessandro , e forse alla don-
na, fatta villania . E g. 2. n. 7. Paßando un
giorno davanti la casa , dove la bella donna
dimorava , gli venne per ventura veduta . Pas-
sav. f. 12. Sali nella mente tua , quasi in una
Z sedia
/ BEGIN PAGE 354 /
sedia judiciale, e poni te malfattore davanti
da te, judice di te ; non volere porti dietro a
te , acciocchè Dio non ti ponga avanti a se.
Col genitivo lo cita il Cinonio adoperato nel
Filoc., ma non è troppo in uso.
Innanzi serve al dativo, e all’ accusativo ,
e dinota tempo , o luogo , e vale prima .
Bocc. Introd. Siccome molti innanzi a noi han-
no fatto . Petrar. cap. 6. I’ son colei, che sì im-
portuna , e fera Chiamata son da voi , e sor-
da , e cieca , Gente, a cui si fa notte innan-
zi sera .
Si usa talora per sopra , più che &c. Bocc.
g. 3. n. 5. T’ ho sempre amato, e tenuto caro
innanzi ad ogni altro uomo .
E per alla presenza . Bocc. g. 8. n. 3. Ch’ el-
la si guardaße d’ apparirgli innanzi quel giorno.
Dinanzi serve comunemente al dativo ,
benchè si usi ancora col genitivo , coll’ ac-
cusativo , e coll’ ablativo ; e vale dalla par-
te anteriore ; contrario a dopo , e a dietro .
Bocc. Dinanzi alla casa del morto co’ suo’ pros-
simi si ragunavano i suoi vicini = Egli era pur
poco fa qui dinanzi da noi . Gio. Vill. L’ at-
tendevano in su i gradi dinanzi la Chiesa di
S. Pietro . Libr. Astrol. Quella dinanzi delli
tre , che sono nel circondamento meridionale del
capo .
Vale talvolta alla presenza , appresso . Boc-
caccio . Io sarò sempre e dinanzi a Dio, e
dinan-
/ BEGIN PAGE 355 /
dinanzi agli uomini fermissimo testimonio della
tua onestà .
Prima si usa talvolta in forza di preposi-
zione col genitivo , e vale avanti , innanzi .
Bocc. Teseid. Acciocchè prima della tua par-
tita Foße finta la mia trista sorte.
DIETRO , DOPO .
Dietro vale il post , e ’l retro de’ Latini,
e vuole il dativo . Bocc. g. 5. n. 8. E dietro a
lei vide venire sopra un corsier nero un cava-
lier bruno forte nel viso crucciato .
Cogl’ infiniti de’ Verbi sembra avere l’ ac-
cusativo . Bocc. Un giorno dietro mangiare
laggiù venutone , in un canto sopra un carello
si pose a sedere .
Si trova anche coll’ ablativo . Dante . So-
pra le spalle dietro dalla coppa , Con l’ ale aper-
te gli giaceva un Draco.
Di dietro vale lo stesso , che dietro, e vuo-
le il dativo . Bocc. Elle non correranno di die-
tro a niuna a farsi leggere . Pure il Buti nel
comento del luogo di Dante testè citato gli
dà l’ ablativo: Dice , che in sulle spalle di
dietro dalla collottola gli era un Dragone .
Dopo serve all’ accusativo , e dimostra or-
dine di luogo , o di tempo, o di azione , e
vale post retrò . Nov. ant. 44. Quel cotal ma-
rito era dopo la parete della camera . Bocc.
g. I. n. 7. Dopo alquanti dì , non veggendosi
chiamare , incominciò a prender malinconia. E
Z 2 n. 5.
/ BEGIN PAGE 356 /
n. 5. Dopo alcun riposo preso in camere orna-
tissime , venuta l’ ora del desinare , il Re, e
la Marchesana ad una tavola sedettero .
Riceve ancora il dativo, e talvolta il ge-
nitivo . Passav. f. 56. Il cavaliere , che dopo
alla colonna avea ascoltato , e osservato ciò ,
che detto , e fatto era , gli tenne celatamente
dietro. Bocc. Non molto dopo a questo conven-
ne al marito andare infino a Genova . Moral.
S. Gregor. Per quegli , a cui tu vai, ti scon-
giuro , e priego , che io dopo di te non riman-
ga sette dì.
CONTRO , CONTRA .
Preposizioni dinotanti opposizione . Ammet-
tono il genitivo , il dativo , e l’ accusativo ;
e benchè alcuni stabiliscano regola , che col
dativo sempre debba dirsi contro , e non mai
contra , ciò però vien contraddetto da esempj
chiarissimi de’ primi lumi della nostra lingua .
E‵ ben vero, che un non so che di durezza
si sente nel dare a contra il dativo , per l’in-
contro di quell’ ultimo a col segnacaso , ma
non dee per tutto ciò chi l’ usasse conden-
narsi d’ errore . Ecco gli esempj . Bocc. Lui
domandò, se vero fosse ciò, che contro di lui
era stato detto = Acciocchè poi non avesser ca-
gione di mormorare contra di lui , quando il
monaco punisse . = Niuna altra medicina esse-
re contro alle pestilenze migliore = Io mi ver-
gogno di dirlo, perciocchè contra all’ altre non
posso
/ BEGIN PAGE 357 /
posso dire , ch’ io contra a me non dica = Con-
tra il general costume de’ Genovesi . Matt. Vill.
Avendo il nostro Comune la guardia di Prato
presa contro la comune volontà de’ terrazzani .
Vagliono talvolta rincontro , a rimpetto .
Bocc. Metti cinquemila fiorini d’ oro de’ tuoi
contro a mille de’ miei. Gio. Vill. S’ apprese
fuoco in Porta rossa, contra alla via , che tra-
versa , che va a casa gli Strozzi.
GIUSTA , GIUSTO , SECONDO .
Preposizioni dinotanti conformità ; ma le
prime due sono poco in uso presso gli Scrit-
tori .
Giusta , giusto vogliono l’ accusativo . Matt.
Vill. Egli intendeva di mettergli in pace giu-
sta suo potere . Bocc. Filoc. Ti preghiamo, che
se per noi alcuna cosa far si può , che gran
piacer ti sia , la ne dica, con ferma speranza,
che fornita sia giusto il poter nostro . Ma nel-
la Teseide si trova col dativo . Di che ciascun
si gìa maravigliando , Faccendo a lui , giusto
al potere , onore .
Secondo vuole l’ accusativo . Bocc. Essi fu-
rono , secondo il comandamento del Re , mena-
ti in Palermo.
Secondo si adopera in senso di per quanto com-
porta l’essere, o la qualità di checchessia, e in tal
caso riceve l’ accusativo, ma senza articolo, o
pronome . Bocc. Io ti saprò bene, secondo don-
na, fare un poco di onore = Era ben vestita ,
Z 3 e , se-
/ BEGIN PAGE 358 /
e, secondo sua pari, assai costumata. E g. 3
n. I. Un giovane lavoratore forte , e robusto ,
e, secondo uom di villa , con bella persona =
E quivi, secondo cena sprovveduta, furono
assai bene , e ordinatamente serviti .
ECCETTO , SALVO , FUORI ,
IN FUORI .
Preposizioni eccettuative , delle quali =
Eccetto vuole l’ablativo. Filipp. Vill. La-
sciando al Capitano ragazzaglia, e vile gen-
te , eccetto alquanti Italiani .
Salvo riceve parimente l’ ablativo , o sia
quel caso , con cui rilevar sogliamo l’ abla-
tivo assoluto latino , o in iscambio una pro-
posizione . Gio. Vill. Rendegli la signoria di
Lombardia, salvo la Marca Trivigiana . Bocc.
Non la lasciar per modo , che le bestie, e gli
uccelli la divorino , salvo se egli nol ti co-
mandasse .
Fuori si usa in forza di preposizione eccet-
tuativa , come le due accennate , col metter-
vi dopo che, o solamente . Bocc. Niuno segna-
le da potere rapportare le vide , fuorichè uno,
ch’ ella n’ avea sotto la sinistra poppa .= Quel-
la trovò di roba piena esser dagli abitanti ab-
bandonata , fuor solamente da questa fanciulla .
In fuori significa lo stesso , che eccetto , e
salvo, ma gli si prepone la cosa eccettuata
in ablativo colla preposizione da. Bocc. Mae-
stro alcuno non si trova, da Dio in fuori , che
ogni cosa faccia bene.
Al-
/ BEGIN PAGE 359 /
Altri che , altro che vagliono fuorchè . Boc-
caccio . Introd. Egli mi pare , che niuna per-
sona , la quale abbia alcun polso , e dove pos-
sa andare, come noi abbiamo , ci sia rimasa ,
altri che noi. E n. I. Avea grandissima vergo-
gna, quando uno de’ suoi strumenti fosse altro che
falso trovato .
SENZA .
Preposizione separativa corrispondente al si-
ne de’ Latini, che sanza più frequentemente
dicevasi dagli antichi . Il caso di questa pre-
posizione, secondo il Cinonio , è l’ accusa-
tivo , ma può essere che sia ablativo corri-
spondente a quello della preposizione Latina .
Riceve ancora l’ infinito, o il participio, a
cui l’ infinito si sottintenda , o talvolta il ge-
nitivo . Bocc. Introd. Assai n’ erano di quelli
che di questa vita senza testimonio trapassa-
vano . E g. 6. n. 6. Una novella , nella quale
quanta sia la lor nobiltà si dimostra , senza
dal nostro proposito deviare , e perciò mi pia-
ce di raccontarla. E g. 6 n. I. Mise mano in
altre novelle , e quella , che cominciata avea ,
senza finita lasciò stare . E nell’ Amet . Ecco
ch’ io vaglio poco, e molto meno Sanza di te
ispero di valere .
Si usa talvolta per oltre . Boccacc. Aveva
de’ fiorini più di millanta nove , senza quelli,
ch’ egli aveva a dare altrui.
Z 4 QUAN-
/ BEGIN PAGE 360 /
QUANTO .
Si usa in forza di preposizione coll’ accusa-
tivo , ed esprime comparazione . Bocc. Filoc.
Sicchè quanto me puote essere alcun dolente ,
ma più no. E nella Fiamm. O figliuola a me
quanto me stessa cara , quali sollecitudini ti
stimolano ?
DELLE PREPOSIZIONI COMPOSTE.
A modo , maniera , guisa, foggia &c.
VOgliono il genitivo, o pure una propo-
sizione, a cui preceda la particella che.
Bocc. A modo del Villan matto , dopo danno
fe patto = A modo che se steste cortese , vi re-
cate le mani al petto. M. Aldob. Usare acqua
di finocchio , fatta a maniera d’ acqua rosa .
Dante . Ch’ a guisa di scorpion la punta ar-
mava. Sagg. nat. esper. Cedono per ogni ver-
so , e sparpagliansi a guisa che noi veggia-
mo l’ acque da ogni minimo bruscolo , che so-
pra vi caggia, dirompersi. Allegri . Avete voi
finissimi capelli, Che pajon tanti orpelli , Quasi
a foggia di stelle .
Altre preposizioni composte , che servono
al genitivo .
APpiè Bocc. Lo ’ngannatore rimane appiè
dello ingannato .
In mezzo . Bocc. g. 2. n. 7. In mezzo di
loro
/ BEGIN PAGE 361 /
loro fattala sedere , non si potè di ragionar con
lei prender piacere , perciocchè essa poco, o nien-
te di quella lingua intendeva . Si trova anche
coll’ accusativo . Petrar. son. 272. Con refri-
gerio in mezzo ’l fuoco vissi .
A pruova , cioè a gara , a concorrenza , a
competenza. Boccacc. Udendo forse venti canti
d’ uccelli , quasi a pruova l’un dell’ altro , can-
tare .
A rispetto . Bocc. Certo la dottrina di qua-
lunque altro è tarda, a rispetto della tua . Si
dice ancora per rispetto . Boccacc. La quale,
per rispetto della madre di lui , lui sollicita-
mente serviva.
Allo ’ncontro vale dirimpetto . Bocc. g. 6.
n. 5. Venendo di qua allo ’ncontro di noi un fo-
restiere . E col dativo . Gio. Vill. l. 9. c. 256.
n. 6. Non è la detta torre della Sardigna ap-
punto allo ’ncontro alla torre delle mura d’Ol-
trarno .
Preposizioni, che servono al dativo .
ACcanto , accosto , di costa, allato , dalla-
to. Bembo rim. Canzon, qui vedi un tem-
pio accanto al mare . Ariost. Fur. Volagli in-
torno , e gli sta sempre accosto . Bocc. Fattosi
aprire un giardino , che di costa era al pala-
gio , in quello , che tutto era dattorno murato,
se n’ entrarono = Era il luogo , il quale F. Puc-
cio
/ BEGIN PAGE 362 /
cio aveva alla sua penitenza eletto , allato
alla camera, nella quale giaceva la donna .
E col genitivo . Boccaccio g. 9. n. 6. La
quale allato del letto dove dormiva , pose la
culla .
Allato significa talvolta in comparazione .
Petrar. son. 98. Ogni angelica vista , ogni at-
to umile Fora uno sdegno allato a quel , ch’ io
dico .
Appetto , dirimpetto , a fronte , incontro , di-
rincontro . Bocc. Egli non ha in questa terra
medico , che s’ intenda d’orina d’ asino , a petto
a costui = Fu messo a sedere appunto dirimpetto
all’uscio della camera . E nel Filoc. Vidi a fronte
alla mia camera in un’ altra dimorar due don-
ne . E g. 9. n. 6. Eßendone due dall’ una del-
le facce della camera , e ’l terzo di rincontro
a quegli dall’ altra . Petrar. Sono animali al
mondo di sì altera Vista , che incontr’ al Sol
pur si difende .
Attorno , dattorno , intorno , dintorno . Pier.
Cresc. Da lasciar sono i sermenti, ma non at-
torno al duro, nè in sommo . Boccacc. g. 10.
n. 9. La sua famiglia venuta dattorno a costo-
ro , come smontati furono , i cavalli adagia-
rono . E g. 8. n. 7. E mille lacciuoli, col mo-
strar d’ amarti , t’ aveva tesi intorno a’ piedi .
g. 2. nel princ. A lei dintorno si posero a se-
dere .
Addoßo , cioè sopra la persona. Dante.
O Ru-
/ BEGIN PAGE 363 /
O Rubicante , fa , che tu gli metti Gli unghio-
ni addoßo sì, che tu lo scuoi . E per inverso .
Bocc. Non altramenti, che ad un can forestie-
re tutti quelli della contrada abbajano addos-
so . E per contro . Boccaccio . Un’ altro pro-
cesso gli avrebbe addoßo fatto . E per in cor-
po. Passav. f. 247. Entra il Diavolo addosso ad
alcuni , e per la lingua loro predice le cose ,
ch’ egli sa .
In vece d’ addosso si usa talvolta elegante-
mente sopra, o allato, e s’ intende delle co-
se , che altri ha in tasca, o intorno alla per-
sona . Bocc. g. 8. n. 3. In Mugnone è una pie-
tra , la qual chi la porta sopra , non è ve-
duto da niuna altra persona . E ivi n. 2. Voi
mi prestate cinque lire. Rispose il Prete : se
Dio mi dea il buono anno , io non gli ho al-l
lato .
Di presso , di sopra , di sotto . Gio. Vill.
Di presso a quella torre a novanta braccia si
ha una porta . Bocc. Laber. Parvemi vedere
surgere a poco a poco di sopra alle montagne
un lume . E si trova col genitivo , e coll’ ac-
cusativo . Tesorett. Delfino è un grande pesce ,
e molto leggiere, che salta di sopra dell’ ac-
qua . Bocc. Amet. Ameto alla venuta delle due
Ninfe di sopra i verdi cespiti levò il capo . E
anche coll’ ablativo. Dante . Giurato avria
poco lontano aspetto , Che tutti ardesser di so-
pra da’ cigli . Di sotto ha gli stessi casi . Bocc.
g. 10.
/ BEGIN PAGE 364 /
g. 10 n. 2. Avendo Ghino in una sala tutti gli
suoi arnesi fatti venire , e in una corte , che
di sotto a quella era , tutti i suoi cavalli, al-
lo Abate se n’ andò . Piero Cresc. Quando il ca-
lore del sole lieva in alto l’ umore di sotto del-
la terra, diventa continuamente il campo cal-
do, ed umido . Dante. Siede Rachel di sotto
da costei .
Preposizioni , che fervono all’ accusativo .
INfra significa dentro, e dopo . Bocc. Parec-
chi miglia , quasi senz’ accorgersene , n’ an-
darono infra mare = Quasi tutti infra ’l terzo
giorno morivano .
Intra . Bocc. Intra gli altri , a’ quali con
piu efficacia gli vennero gli occhi addosso po-
sti , furono due dipintori .
Di contra, di contro vagliono l’ e regione
de’ Latini. Dante Parad. 32. Di contra Pietro
vedi seder Anna. Gio. Vill. Giunse ad ora di
mezzo giorno appiè di Benivento alla valle di
contro alla Città. Qui ha il dativo .
Su , di su, in su, d’ in su .
Su val sopra, e s’attacca coll’ articolo se-
guente , raddoppiandone la consonante , e se
incontra alcuna vocale, si dice sur . Boccacc.
g.3. nel fine. Il Re dopo questa sull’ erba , e ’n
su i fiori avendo fatti molti doppieri accende-
re , ne fece più altre cantare . Pier Cresc. La
cui
/ BEGIN PAGE 365 /
cui parte di sotto sia sur un bastoncello piccolo .
Di su. Dante E questi fue Di sulla Croce
al grande uficio eletto .
In su da’ migliori Autori si dice più volen-
tieri, che su ; è così d’ in su in vece di dire
di su. Bocc. Fece un giorno pescare , e sopra
due barchette, egli in su una co’ pescatori, ed
ella in su un’ altra con altre donne andarono a
vedere = Gli parve in sulla mezza notte sen-
tire d’ in sul tetto della casa scender nella ca-
sa persone .
Preposizioni , che servono all’ ablativo.
DI qua, di là . Bocc. Il qual motto passato
di qua da mare ancora dura . Petrar. E
già di là dal rio passato è il merlo .
Di fuori per fuori . Bocc. g. 6. n. 2. Fatta di
presente una bella panca venire di fuori dal
forno , gli pregò, che sedessero .
Di lungi . Bocc. g. 2. n. 2. La notte il soprap-
prese di lungi dal castello presso ad un miglio .
CAP. XV.
Della Costruzione dell’ avverbio .
PRopriamente parlando l’ avverbio non reg-
ge caso alcuno , imperocchè il caso , che
gli siegue appresso, dipende , o dal Verbo,
o da
/ BEGIN PAGE 366 /
o da qualche preposizione sottintesa : ma per-
chè pure alcuni avverbj hanno dopo di se
il caso , benchè non proprio, sarà ben fatto
trattare della costruzione dell’ avverbio, an-
che per rapporto a’ casi. Ed essendo gli av-
verbj della lingua Toscana in gran numero,
per procedere con qualche chiarezza , divide-
remo questo capitolo in due paragrafi , nel
primo de’ quali tratteremo degli avverbj, che
hanno caso dopo di se ; e nel secondo di al-
cuni avverbj di particolare osservazione intor-
no al loro uso .
§. I.
Degli avverbj , che banno caso.
ECCO .
E‵ Avverbio dimostrativo di cosa,che soprav-
venga , o di cosa impensata . Ha dopo
di se , o un nominativo, o un’ infinito , o
una preposizione, a cui talora precede la par-
ticella che ; e avanti di se non di rado ha la
congiunzione e per proprietà di linguaggio .
Bocc. g. 2. n. 5. Avendo la fanticella già la
sua donna chiamata, e detto, ecco Andreuccio ,
la vide in capo della scala farsi ad aspettarlo .
E g. 10. n. 8. Maravigliossi Varrone dell’in-
stanzia di questi due , e già presumeva niuno
dovere esser colpevole , e pensando al modo
della
/ BEGIN PAGE 367 /
della loro assoluzione , ed ecco venire un gio-
vane chiamato Publio Ambusto. E g. 5. n. 10.
Ed essendosi la donna col giovane posti a tavola
per cenare, ed ecco Pietro chiamò all’ uscio.
E nell’ Introd. Ecco che la fortuna a’ nostri
cominciamenti è favorevole .
Eccoti per ecco , senza relazione a persona,
è lo stesso , che l’ecce tibi de’ Latini . Vit.
Crist. E dicendo queste parole , eccoti quel mal-
vagio Giuda .
Ecco riceve gli affissi dell’ articolo, o delle
particelle mi, ti, ci, che dinotano la cosa , o
persona dimostrata . Bocc. Eccole, ch’ ella me-
desima piangendo me l’ ha recate = Lo scolare
accostatosi all’ uscio disse : eccomi qui Madonna .
Ecco , dinotante irrisione, ha il caso senz’ar-
ticolo . Bocc. Ecco onesto uomo , ch’ è divenuto
andator di notte , apritor di giardini. E lo stes-
so si usa coll’ imperativo vedi adoperato in
senso di ecco, e irrisoriamente . Bocc. g. 8.
n. 3. Deh vedi bel ciottolo, così giugnesse egli
testè nelle reni a Calandrino .
Avverbj dinotanti quantità .
HAnno dopo di se il genitivo della mate-
ria, di cui dinotano la quantità. Assai.
Bocc. Entrati in ragionamento della valle delle
donne , assai di bene , e di lode ne dissero .
Più. Bocc. Essi hanno più di conoscimento ,
che’ giovani.
Me-
/ BEGIN PAGE 368 /
Meno. Bocc. g. 5. n. 2. Cominciò a costeg-
giare la Barberia , rubando ciascuno , che meno
poteva di lui.
Alquanto . Bocc. Chi alquanto non prende di
tempo avanti , non par che ben si possa provve-
dere per l’ avvenire .
Altrettanto . Petrar. Così avess’ io del bel
velo altrettanto .
Altri avverbj col caso .
MEglio è avverbio comparativo, e vale :
più bene , e si adopera in significato di
più, e di piuttosto . Ordinariamente ha per
caso il genitivo , ma si trova col dativo, e
coll’ accusativo, ch’ è proprio del suo verbo.
Bocc. Ragguagliando molto la prima cosa, nella
quale tu se’ meglio di lei , con questa ultima ,
nella quale pare , che essa sia meglio di te . E
g. I. n. 10. I motti, perciocchè brievi sono , mol-
to meglio alle donne stanno , che agli uomini .
E g. 2. n. 8. Amando meglio il figliuol vivo con
moglie non convenevole a lui , che morto senz’
alcuna . Gli si aggiugne talvolta l’ articolo per
proprietà di lingua . Bocc. g. 2. n. 3. Tu puoi,
se tu vuogli, quivi stare il meglio del mondo .
Insieme vale unitamente, di compagnia, e si
accompagna coll’ ablativo, colla preposizio-
ne con , alla quale si aggiungono talora le
particelle , meco, seco. Bocc. Introd. Ciascun
pruo-
/ BEGIN PAGE 369 /
pruovi il peso della sollecitudine insieme col
piacer della maggioranza. E g. 10. n. 9. Di
questo di stamattina sarò io tenuto a voi, e
con meco insieme tutti questi gentiluomini, che
d’ intorno vi sono.
Come avverbio comparativo ha dopo di se
il caso proprio del Verbo , che regge il ter-
mine suo di comparazione, ed è spesse vol-
te un nominativo ; ovvero ha il caso del Ver-
bo dell’ altro termine della comparazione ,
quando questo regge il termine , in cui è il
come. Bocc. Introd. Nascevano nel cominciamen-
to d’ essa certe enfiature , delle quali alcune cre-
scevano come una comunal mela , altre come
un’uovo. E nel Proem. Nelle quali Novelle
piacevoli, ed aspri casi d’ amore, ed altri for-
tunati avvenimenti si vedranno , così ne’ mo-
derni tempi avvenuti , come negli antichi .
Nov. ant. 33. Lo palafreno sia tuo, e la per-
sona : che io t’ amo come me medesimo .
Talvolta si adopera in senso di quanto, co’
Verbi essere, ed avere, col nominativo, che
accenna replicazione dell’altro termine della
comparazione . Nov. ant. 25. Se io avessi così
bella cotta, come ella, io sarei altresì sguar-
data, com’ ella. Pure nel Boccaccio si trova
coll’ accusativo g. 5. n. 3. Pietro non essendosi
tosto, come lei, de’ fanti , che venieno , av-
veduto, fu da loro sopraggiunto , e preso. Ve-
di lib. I. cap. 22.
A a Mer-
/ BEGIN PAGE 370 /
Mercè significa per grazia , per cortesia, e
si dice ancora interamente mercede , e ha do-
po di se il genitivo , e innanzi talvolta ha
l’ articolo , talvolta no. Bocc. g. 3. n. 3. Io
non ho bisogno di sue cose, perciocchè , la mercè
di Dio , e del marito mio , io ho tante borse,
e tante cintole , ch’ io ve l’ affogherei entro .
E g. 7. n. 6. Qui me ne venni, dove, mercè d’Id-
dio , e di questa gentildonna , scampato sono .
Si usa talora a modo di nome sustantivo ,
col porgli innanzi l’ addiettivo , in prosa
coll’ articolo , e in verso senza. Bocc. g. 2.
n. 10. Egli, la sua mercè, per ciò , che io vo-
glio, mi ti rende . Petrar canz. 29. Or par, non
so perchè, stelle maligne, Che ’l Cielo in odio
n’ aggia, Vostra mercè, cui tanto si commise .
E son. 21. Ringrazio lui, che i giusti preghi
umani , Benignamente , sua mercede , ascol-
ta .
Quanto col dativo dopo vale il quod atti-
net de’ Latini. Passav. f. 181. Io sono assomi-
gliato al loto , quanto alla concezione , e al
nascimento : e alla favilla del fuoco , quanto
alla vita : e alla cenere , quanto alla morte .
E talvolta vi si frappone il Verbo essere .
Bocc. g. 4. princ. Quanto è a me, non m’ è an-
cora paruta vedere alcuna così bella , e così
piacevole , come queste sono .
Vale talora il quoad de’ Latini. Bocc. g. 9.
n. 10. Guarda , quanto tu hai caro di non gua-
stare
/ BEGIN PAGE 371 /
stare ogni cosa, che per cosa , che tu oda , o
veggia , tu non dica una parola sola.
S. II.
Avverbj di particolare osservazione.
LAsciando stare gli avverbj locali, de’ qua-
li abbiamo a sufficienza trattato nel ca-
pitolo della costruzione de’ loro Verbi ; per
due capi possono richiedere gli avverbj par-
ticolare osservazione , o perchè non sieno co-
munemente noti , o perchè , quantunque no-
ti , sieno nella nostra lingua di vario uso .
Avverbj non tanto noti comunemente .
Alto significa altamente , o in alto . Bocc.
g. 8. n. 3. Calandrino sentendo il duolo , levò
alto il piè .
Col Verbo fare significa fermarsi . Ariost.
Fur. 25. 68. Davan segno di gire , or di far
alto .
Detto di per se significa l’ eja , e l’ age de’
Latini . Firenz. Trinuz. Or sete voi chiaro ?
alto, ben, andiam via .
Al tutto vale il penitus de’ Latini . Passav.
f. 95. O che il prete fosse al tutto ignorante,
che non sapesse discernere i peccati , o fare
aßoluzione .
A a 2 Ap-
/ BEGIN PAGE 372 /
Appresso significa spesse volte postea . Bocc.
g. 2. n. 6. In ciò dalla madre della giovane pri-
ma , e appresso da Currado soprappresi furono.
Cotanto vale tanto. Bocc. n. 2. Quello, di
che tu mi hai cotanto pregato .
Dianzi vale poco fa . Bocc. g. 7. n. I. Io dissi
dianzi il Te lucis , e la ’ntemera , e tante
altre buone orazioni , che temere non ci bisogna .
Gli si aggiugne talvolta poco. Filipp. Vill.
Si partirono dalle frontiere , dove poco dianzi
si erano ridotti.
Di presente significa subito , immantenente .
Nov. ant. 59. Se n’ andòe di presente alla ma-
dre , e contolle tutta la ’mbasciata. Bocc. n. I.
E farebbe , che di presente gli sarebbe appor-
tato .
Di presente che vale subito che . Gio. Vill.
Di presente che fu fatto signore , tolse ogni
signoria, e stato a’ nobili di Roma .
Di tanto vale in questo . Bocc. g. 8. n. 9. Se
non che di tanto siam differenti da loro , ch’
eglino mai non la rendono , e noi la rendiamo,
come adoperata l’ abbiamo .
Fattamente, colla particella sì, o così avanti,
vale in tal modo. Boccacc. Introd. Udendo co-
stei così fattamente parlare . E g. 6. nel fine.
Sii dunque Re , e sì fattamente ne reggi , che
del tuo reggimento nella fine ci abbiamo a lo-
dare.
Guari significa molto , ma quasi sempre col-
la
/ BEGIN PAGE 373 /
la negativa . Boccacc. g. 2. n. 7. Il quale non
istette guari , che trapassò . E ivi n. 5. Una
novella non guari meno di pericoli in se con-
tenente , che la narrata da Lauretta . E g. 7
n. 9. Fermamente , se tu il terrai guari in boc-
ca , egli ti guasterà quelli , che son dallato .
Guari si adopera ancora in forza di nome
addiettivo , e sustantivo, e vale molto. Bocc.
g. 4. n. 6. Dopo non guari spazio passò della
presente vita . E g. 8. n. 10. Non preser guari
d’ indugio le tentazioni a dar battaglia alle
forze di costui .
In punto significa in prossima disposizione .
Vit. Plut. La Città era in punto d’ ardersi
tutta , e di perdersi .
In pruova vale apposta. Passav. f. 113. Mag-
gior peccato è peccare in pruova , e per certa
malizia , che per ignoranza , o per infermitade.
In questa , in questo vagliono in quest’ ora,
in questo punto : e in quella , in quello vagliono
in quell’ ora , in quel punto ; e talora a tali av-
verbj si pone dopo la particella che . Bocc.
g. 3. n. 8. Ed in questa si accorse lo Abate ,
Ferondo avere una bellissima donna per moglie .
E g. 8. n. 7. Ed in questo la fante di lei so-
pravvenne. E g. 9. n. 8. Ed in questo, ch’ egli
così si rodeva, e Biondel venne . E g. 7. n. 3.
E non sapeva nè che mi fare , nè che mi dire ,
se non che F. Rinaldo nostro compare ci venne
in quella . Dante Inf. 12. Quale è quel toro,
A a 3 che
/ BEGIN PAGE 374 /
che si slaccia in quella, Che ha ricevuto già ’l
colpo mortale .
In quel torno vale circa , e si dice ordina-
riamente di numero . Matt. Vill. Vi vennero in
numero d’ ottanta , o in quel torno . Boccacc.
g. 5. n. 5. D’ età di due anni, o in quel torno.
Mezzo si usa per quasi . Boccacc g. 7. n. 5.
Alla donna pareva mezzo avere inteso .
Non pertanto vale nondimeno . Bocc. Teseid.
A Palemon pareva male stare , Ma non per-
tanto cacciò la paura .
Nulla più vale il nihil magis de’ Latini .
Petrar. Nell’ estremo occidente Una fera è soa-
ve , e queta tanto , Che nulla più .
Per tutto vale in ogni luogo. Boccacc. g. 7.
n. 2. Il dovreste voi medesime andar dicendo
per tutto .
Per tutto ciò significa contuttociò , tuttavia,
e lo stesso vale ancora per tutto questo . Bocc.
g. 9. n. 6. Nè v’ era per tuttociò tanto di spa-
zio rimaso, che altro, che strettamente andar
vi si potesse . E ivi n. 9. Gioseffo per tutto que-
sto non rifinava .
Posta forma due avverbj non tanto noti ,
cioè a posta fatta, che vale a caso pensato .
Gio. Vill. Provvedutamente , e a posta fatta
furono sorpresi da cinquecento cavalieri di Pi-
sani .
A posta d’ alcuno vale a suo piacimento .
Boccacc, g. 5. n. 4. Io non poßo far caldo, e
fred-
/ BEGIN PAGE 375 /
freddo a mia posta , come tu forse vorresti .
Più assolutamente , ma coll’ articolo avanti
vale plerumque . Bocc. g. 4. n. I. A mostrarlo
con romore, e con lagrime, come il più le fem-
mine fanno, fu assai volte vicina .
Punto significa niente . Bocc. g. 2. n. 8. Ella
nè allora, nè poi il conobbe punto .
Si usa talvolta per qualche poco . Passav.
f. 226. Molto da dolersene è , e da piangerne
chi ha punto di sentimento, o di cognoscimen-
to , o zelo dell’ anime .
Si usa per mica . Boccaccio g. 3. n.7. Ma-
donna , Tedaldo non è punto morto , ma è vi-
vo , e sano .
Quasi vale ferè . Bocc. g. 8. n. 3. Tutte sono
quasi come nere.
Vale ancora veluti . Petrar. son. 225. Per-
le , rubini , ed oro , Quali vil fango egual-
mente dispregi .
Vale talvolta come se . Boccaccio g. I. n.7.
Senza punto pensare , quasi molto tempo pensa-
to aveße , disse .
Ratto vale prestamente , e raddoppiato ac-
cenna prestezza maggiore . Petrar. canz. 37.
Ratto , come imbrunir veggo la sera , Sospir
del petto , e degli occhi escon’ onde . Dante
Purg. 18. Ratto ratto , che ’l tempo non si perda .
Senza che vale præterquamquod . Bocc. g. 6.
n. 10. Senzachè egli ha alcune altre tacche-
relle con queste , che si tacciono per lo migliore .
A a 4 Sen-
/ BEGIN PAGE 376 /
Senza modo vale smisuratamente . Boccacc.
g. 3. n. 5. Uomo molto ricco, e savio , ed av-
veduto per altro , ma avarissimo senza modo .
Senza più vale solùm, dumtaxat . Boccacc.
g. 2. n. 3. Lo Abate con gli due cavalieri, e
con Alessandro , senza più, entrarono al Papa.
Se tu sai modo avverbiale, che vale il
quantumlibet de’ Latini . Bocc. g. 8. n. 9. Sie
pur infermo, se tu sai, che mai di mio me-
stiere io non ti torrò un denajo . E g. 5. n. 5.
Questo , se ti piace , io il ti prometto , e fa-
rollo : fa tu poi , se tu sai, quello, che tu
creda , che bene stea .
Tale si usa per talmente . Bocc. g. 8. n. 9.
Io fo boto, che io mi tengo a poco, che io non
ti do tale in sulla testa , che il naso ti caschi
nelle calcagna .
Testè vale in questo punto , o poco avanti .
Bocc. g. 9. n. 5. A me conviene andare testè a
Firenze . E g. 8. n. 10. Io ho testè ricevute
lettere di Messina .
Tosto val subito . Bocc. g. 9. N. 5. Deh sì ,
per l’ amor di Dio, facciasi tosto .
Avverbj di vario uso .
Altrimenti , o altramente vale in altro mo-
do . Bocc. g. 2. n. 3. Ciascun , che bene , ed
onestamente vuol vivere , dee , in quanto può,
fuggire ogni cagione , la quale ad altrimenti
fare
/ BEGIN PAGE 377 /
fare il potesse conducere . E Introd. Veggonsi i
campi pieni di biade non altramente ondeggia-
re , che il mare .
Ancora, oltre il noto significato di etiam,
vale talora nunc quoque , talora nondum. Bocc.
g. 2. n. I. Il quale coloro, che per lui anda-
rono , trovarono ancora in camicia . E g. I.
n. 10. Non sono ancora molti anni paßati .
Appunto vale giustamente , e senza fallar
d’ un punto ; ma nell’ uso si adopera per ne-
gare con disprezzo , per contraffrase , rispon-
dendo per esempio a chi ci dice alcuna cosa :
oh appunto , sapete molto voi .
Avanti, oltre il senso di ante, ha quello
ancora di potius . Bocc. g. 4. n. 4. Il condannò
nella testa, volendo avanti senza nipote rima-
nere , che esser tenuto Re senza fede .
Bene, oltre all’ ordinario senso del benè de’
Latini, si usa in varj modi.
Per molto . Boccacc. g. 8. n. 10. Vendè i suoi
panni a contanti, e guadagnonne bene.
Per affermare , e solo, e col sì . Boccacc.
g. 7. n. I. Disse la donna a Gianni : ora spu-
terai , quando io il ti dirò . Disse Gianni : be-
ne . E g. 9. n. 5 Diße Bruno: daratti egli il
cuore di toccarla con un brieve , che io ti da-
rò ? Disse Calandrino : sì bene .
Per bensì, ch’ è il quidem de’ Latini . Boc-
cacc. g. 5. n. 6. Il fallo commesso da loro il
merita bene , ma non da te.
E co’
/ BEGIN PAGE 378 /
E co’ Verbi essere, e stare , per approvare
nel senso del benè est de’ Latini . Bocc. g. 9.
n. I. Se egli dice di volerlo fare , bene sta ,
dove dicesse di non volerlo fare , sì gli dì da
mia parte , che più dove io sia non appari-
sca. Passav. f. 127. Se puote avere quello me-
desimo confeßore , bene è : se non, confessisi a
un’ altro .
Star bene , coll’ espressione della persona ,
vale esser conveniente , e si adopera anche iro-
nicamente in senso di quel , che diciamo fa-
migliarmente star fresco . Bocc. g. 4. proem.
Alla mia età non istà bene l’ andare omai die-
tro a queste cose . E g. 5. n. 10. E certo io sta-
rei pur bene , se tu alla moglie di Ercolano
mi volessi agguagliare , la quale è una vec-
chia picchiapetto , e spigolistra . E parimente
per esser conveniente , ma in ragione di pe-
na, e di confusione . Bocc. g. 8. n. 9. Senti-
rono alla donna dirgli la maggior villania ,
che mai si dicesse a niun tristo , dicendo : deh
come ben ti sta .
Si usa ancora in senso di molto nella qua-
lità , cioè pienamente , perfettamente , e simi-
li. Bocc. g. I. n. 3. Il Giudeo s’ avvisò troppo
bene , che ’l Saladino guardava di pigliarlo
nelle parole. E g. 8. n. 4. Voi già v’ appressate
molto bene alla vecchiezza , la qual cosa vi
dee fare e onesto , e casto . E g. 3. n. 6. Pre-
sala bene sì, che partir non si poteva , diße .
Met-
/ BEGIN PAGE 379 /
Metter bene vale essere utile . Amm. Ant.
A neuno uomo mette bene volere fare quello ,
che natura gli niega .
Come si usa per quando . Bocc. g. 8. n. 10.
Come prima ebbe agio , fece a Salabaetto
grandissima festa.
E per in qualunque maniera . Gio. Vill. Ma
come si fosse , il detto Giovanni fu menato in
su uno carro per tutta la città , e attanagliato .
Così avverbio di similitudine assai noto .
Ha spesso la corrispondenza del come. Bocc,
g. 2. n. 5. Il fanciullo come sentito l’ ebbe ca-
dere , così corse a dirlo alla donna.
Si tace talvolta con grazia . Nov. ant. 83.
E però tutti poveri bisognosi , uomini , come
femmine , a certo díe fossero nel prato suo .
Così fattamente , così fatto sono modi mol-
to in uso nella nostra lingua . Bocc Introd.
Se ne sarieno assai potute annoverare di quel-
le, che la moglie , e ’l marito , gli due, o i
tre fratelli , o il padre , o il figliuolo , o così
fattamente ne contenieno . E ivi. Tra le donne
erano così fatti ragionamenti .
Da capo vale l’ iterum de’ Latini . Bocc.
g. 2. n. 3. Quivi da capo il Papa fece solen-
nemente le sponsalizie celebrare .
Vale ancora da principio . Bocc. g. 3. n. 7.
Il peregrino da capo fattosi , tutta la storia
raccontò .
Di nuovo vale iterum . Bocc. g. 3. n. 3. E
di
/ BEGIN PAGE 380 /
di nuovo ingiuriosamente , e crucciato parlan-
dogli, il riprese molto .
Vale ancora nuovamente . Bocc. g. 10. n. 8.
Questo non è miracolo , nè cosa , che di nuovo
avvenga .
Di poco vale poco tempo avanti . Gio. Vill.
I più furono de’ Grandi , che di nuovo erano
stati rubelli , rimessi in Firenze di poco .
Vale talvolta per poco. Gio. Vill. Fu scon-
fitto , e atterrato , e fedito , e di poco scam-
pò la vita .
Forte vale ad alta voce . Bocc. g. 2. n. 5.
Andreuccio , non rispondendogli il fanciullo , co-
minciò più forte a chiamare .
E per gagliardamente . Bocc. g. 10. n. 8. I
cani presa forte la giovane ne’ fianchi , la
fermarono .
E per profondamente . Bocc. g. 3. n. 2. Comec-
chè ciascuno altro dormiße forte , colui , che
colla Reina stato era, non dormiva ancora .
E per molto . Bocc. g. 5. n. 3. E biasimaron-
gli forte ciò , ch’ egli voleva fare .
E dinotando vemenza d’animo . Bocc. g. 5.
n. 9. Avendo veduto molte volte il falcone di
Federigo volare , istranamente piacendogli, for-
te disiderava di averlo .
Già avverbio di tempo passato , oltre a’
significati noti, ne ha due altri notabili ,
cioè =
Per nondimeno . Filoc. lib. 6. Passarono den-
tro,
/ BEGIN PAGE 381 /
tro, e videro i due dormire, ma già per que-
sto niuna pietà rammorbidì i duri cuori .
Per forse. Bocc. g. I. n. 8. Cosa, che non
foße mai stata veduta, non vi crederei io sa-
pere insegnare , se ciò non fosser già starnuti.
Giammai vale unquam. Bocc. n. 2. Fu il più
contento uomo , che giammai fosse .
Intanto posto assolutamente , vale interim .
Dante . Intanto voce fu per me udita : Ono-
rate l’ altissimo poeta .
E si usa ancora correlativo d’ in quanto , e
vale per tale , o per tanta parte . Gio. Vill.
Lasceremo omai l’ ordine delle storie de’ Ro-
mani , e degl’ Imperadori, se non intanto , in
quanto apparterrà a nostra materia .
Laddove vale purchè . Bocc. Introd. Laddo-
ve io onestamente viva, nè mi rimorda di al-
cuna cosa la coscienza , parli chi vuole in con-
trario .
E riceve senso avversativo, come il rice-
ve anche dove . Bocc. lett. Pin. Ross. La po-
vertà è esercitatrice delle virtù sensitive ; lad-
dove la ricchezza , e quelle , e questi addor-
menta . E g. 5. n. 10. Il qual diletto fia a me
laudevole , dove biasimevole è forte a lui .
Mai vale unquam , onde per farlo negare
convien aggiugnergli la negativa. Bocc. g. 3.
n. 6. E giurógli di mai non dirlo. E ivi. Io
intendo , che da quinci innanzi sien più , che
mai .
Si
/ BEGIN PAGE 382 /
Si trova in senso di nunquam senza la ne-
gativa . Bocc. g. 2. n. 7. Alle sue femmine co-
mandò , che ad alcuna persona mai manifestas-
sero chi fossero .
Quando mai precede alla negativa , amen-
due precedono al verbo. Bocc. g. 2. n. 7. Ma
eßa tenera del mio onore mai ad alcuna per-
sona fidar non mi volle, che verso Cipri ve-
niße .
Quando la negativa precede al mai, ci ha
esempli del posporre , e dell’ antiporre il mai
al Verbo , benchè forse più frequentemente si
posponga. Bocc. Introd Lasciamo stare , che
i parenti insieme rade volte , o non mai si vi-
sitassero, e di lontano. Gio. Vill. E in questo
mezzo l’ arti , e la mercatanzia non istetter
mai peggio in Firenze .
Mai si usa talora in vece di sempre . F. Giord.
Pred Così è oggi bello il Cielo, come fu mai .
Mai unito al sempre, gli accresce forza.
Bocc. g. 8. n. 2. Se voi mi prestate cinque li-
re , io sempre mai poscia farò ciò , che voi
vorrete . Petrar. Che m’ ha sforzato a sospi-
rar mai sempre.
Male , oltre al significato di malamente , ha
anche quello di poco , difficilmente , e simili.
Bocc. g 2 n. 9. Domandando perdonanza , la
quale ella , quantunque egli mal degno ne fos-
se, benignamente gli diede . E g. 4. nel princ.
Voi siete oggimai vecchio , e potete male durar
fatica .
Sì
/ BEGIN PAGE 383 /
Sì avverbio , che afferma. Bocc. g. 3. n. 8.
Adunque , diße la donna , debbo io rimaner ve-
dova ? Sì , rispose lo Abate .
Quando è caso di verbo gli si prepone il
segnacaso , o l’ articolo. Bocc. g. 4. n. 10.
La qual tornò, e disse di sì. E g. I. n. 6. Il
buono uomo rispose del sì .
Sì bene, e maisì già furono accennati nel
primo libro .
No , non avverbj di negazione , che signi-
ficano lo stesso .
No ha talora la corrispondenza del sì
espressa, o sottintesa. Bocc. g. 6. n. 10. Pre-
stamente risponde egli , e sì , e no, come giu-
dica si convenga. E g. 8. n. 7. Potrà vedere
se gli occhi miei d’ averti veduta strabocche-
volmente cadere si saranno turbati, o no .
Quando la negazione si ha a porre due
volte in un medesimo ragionare , sempre una
d’ esse è no, o si anteponga , o si posponga .
Bocc. g. 7. n. 2. Disse allora Peronella : no,
per quello non rimarrà il mercato . E ivi n. 9.
Diße allora Pirro : non farnetico no , madonna .
No quando è caso di verbo riceve il se-
gnacaso, o l’ articolo. Bocc. g. 9. n. I. Dirò
io di no della prima cosa , che m’ ha richie-
sto ? E g. I. n. 7. Ciascuno rispose del no .
Mainò , non già furono accennati nel pri-
mo libro.
Non se ha a negare più cose poste innanzi
al
/ BEGIN PAGE 384 /
al Verbo, si aggiugne a ciascuna di esse, ma
non già al Verbo . Dante Purg. 21. Perchè
non pioggia, non grando , non neve, Non ru-
giada , non brina più su cade, Che la scalet-
ta de’ tre gradi breve .
Ma se ’l Verbo va innanzi, ad esso si ag-
giugne la negazione ; si aggiunga poi, o non
si aggiunga alle cose negate , benchè sia co-
stume d’ aggiugnerla ad esse ancora. Bocc.
g. 4. nel princ. Non curatosi de’ palagi, non
del bue, non del cavallo, non dell’ asino, non
de’ danari, nè d’ altra cosa, che veduta aves-
se, subitamente disse .
Non posto interrogativamente talora non
solamente non niega, ma vi sta come se non
vi fosse . Dante . Non v’accorgete voi, che noi
siam vermi, Nati a formar l’ angelica farfal-
la , Che vola alla giustizia senza schermi?
Anzi che no vale più tosto che altro. Bocc.
g. 2. n. 10. E’ mi pare, anzi che no, che voi
ci stiate a pigione. E g. 3. n. 5. Anzi acerbet-
ta , che no , così cominciò a parlare.
Onde , oltre al servire al moto da luogo ,
mostra ancora cagione , materia , origine, e
simili. Bocc. g. 2. n. 8. Lasciagli stare colla
mala ventura , che Dio dea loro , ch’ essi fanno
ritratto da quello, onde nati sono.
Ove , oltre al servire allo stato in luogo,
significa ancora quando, e a rincontro . Bocc.
g. 10. n. 9. Che che di me s’ avvenga, ove
tu
/ BEGIN PAGE 385 /
tu non abbi certa novella della mia vita , che
tu m’ aspetti un’ anno , ed un mese , ed un dì
senza rimaritarti . E g. 8. n. 7. La ’nfermità
del mio freddo col caldo del letame puzzolente
si convenne curare , ove quella del tuo cal-
do col freddo dell’ odorifera acqua rosa si cu-
rerà .
Parte presso gli antichi valeva interim .
Petrar. Che mi consuma , e parte mi diletta .
Bocc. g. 8. n. 7. Parte che lo scolare questo di-
ceva , la misera donna piagneva continovo .
A parte a parte vale particulatim . Bocc.
g. 10. n. 8. E che quello , che io dico , sia ve-
ro, riguardisi a parte a parte .
Da parte vale seorsim. Boccacc. g. 7. n. 9.
Tratto Pirro da parte , quanto seppe il me-
glio, l’ ambasciata gli fece .
In disparte vale lo stesso. Petrar. L’ altre
maggior di tempo, o di fortuna Trarsi in dis-
parte comandò con mano .
D’ altra parte, o dall’ altra parte vale a
rincontro. Bocc. g. 9. n. 5. Calandrino inco-
minciò a guardare la Niccolosa, e a fare i
più nuovi atti del mondo . Ella d’ altra parte
ogni cosa faceva , per la quale credesse bene
accenderlo . Petrar. Trionf. Amor. cap. 3. E
veggio andar quella leggiadra , e fiera , Non
curando di me , nè di mie pene , Di sua vir-
tute , e di mie spoglie altera . Dall’ altra par-
te, s’ io discerno bene , Questo signor , che tut-
to ’l
/ BEGIN PAGE 386 /
to ’l mondo sforza , Teme di lei , ond’ io son
fuor di spene .
Da ogni parte vale affatto . Passav. f. 168.
Dicendo col Salmista : humiliatus sum usque-
quaque, Domine : vivifica me secundum ver-
bum tuum . Io sono umiliato da ogni parte : vi-
vificami tu, Signore , secondo la tua parola .
In parte vale non interamente. Bocc. g. 3.
n. 9. Dando fede alle sue parole , siccome quel-
la , che già in parte udite le aveva d’ altrui,
cominciò di lei ad aver compassione . E nel
Proem. De’ quali modi ciascuno ha forza di
trarre, o in tutto, o in parte l’ animo a se .
Poi avverbio di tempo , vale dopo , appres-
so , ed è contrario di prima . Bocc. n. I. Veg-
gendo la gente , che noi l’ avessimo ricevuto
prima , e poi fatto servire , e medicare così
sollecitamente .
Poscia vale lo stesso , che poi. Bocc. g. 4.
n. 8. Ed io non sarò mai poscia lieta .
Di poi lo stesso che poscia . Cron. Morell.
Fecesi questo primo ufficio a mano, e di poi se
ne fe borsa.
Dappoi lo stesso che di poi. Gio: Vill. S’ ar-
rendeo Cappiano, salvo la rocca ; e dappoi la
rocca , salvo l’ avere .
Si noti , che dipoi , e dappoi sono talmente
avverbj, che non sogliono adoperarsi in for-
za di preposizioni, ma si adopera dopo ; ben-
chè non manchino autorità in contrario d’au-
tori
/ BEGIN PAGE 387 /
tori del buon secolo; ma dee ciascuno atte-
nersi all’uso più regolato, e migliore, ch’ è
il suddetto .
Notisi ancora , che dopo, essendo , com’ è
detto , preposizione , non riceve dopo se la
particella che , ma la ricevono sì bene i due
accennati avverbj. Gio: Vill. Avendo la lega
di Lombardia molto afflitta la Città di Par-
ma , di poi che ebbono il Castello di Colornio.
Passav. f. 44. Non mi sbigottirò , temendo di
qualunque grave infermitade , dappoich’ io ho
così efficace , e vertuosa medicina , com’ è la
morte di Cristo . E il Boccaccio l’ ha usato
con iperbato g. 5. n. 10. E da che diavol siam
noi , poi da che noi siam vecchie , se non da
guardare la cenere intorno al focolare ?
Talvolta il Boccaccio sopprime il poi ne’
suddetti avverbj, come g. 8. n. 9. Vedrete pu-
re , come l’ opera andrà , quando vi sarò sta-
to , dacchè non avendomi ancora quella Con-
tessa veduto , ella s è innamorata di me .
Prima forma molte maniere avverbiali de-
gne di essere osservate .
Come prima vale tostochè . Bocc. g. 2. n. 5.
Vivi sicuro , che come prima addormentato ti
fossi, saresti stato ammazzato .
Da prima vale la prima volta. Bocc. g. 9.
n. I. Era sì contraffatto, e di sì divisato vi-
so, che chi conosciuto non l’ avesse , vedendol
da prima ne avrebbe avuto paura.
B b 2 Im-
/ BEGIN PAGE 388 /
Imprima si dice per proprietà di lingua in-
vece di prima . Bocc. n. 2. Io voglio imprima
andare a Roma .
Primachè . Bocc. g. 2. n. 7. Madonna , non vi
sconfortate primachè vi bisogni.
Prima vale talora potiusquam . Bocc. Laber.
f. 65. E prima credo si troveranno de’ cigni
neri , e de’ corvi bianchi, che a’ nostri succes-
sori di onorarne alcun’ altra bisogni d’ entrare
in fatica .
Colla negativa vale talvolta , infinattanto-
chè , talvolta subito che . Bocc. g. 9. proem.
Quivi riposatisi alquanto , non prima a ta-
vola andarono , che sei canzonette cantate fu-
rono . E g. 4. n. 7. Non prima abbattuto ebbe
il gran cesto in terra , che la cagione della
morte de’ due miseri amanti apparve .
Pria, e pria che ne’ predetti significati di
prima sono per lo più voci poetiche . Petrar.
Non è questo il terren, ch’ i’ toccai pria ? =
E pria che rendi Suo dritto al mar , fiso, u’ si
mostri , attendi , L’ erba più verde , e l’ aria
più serena .
Pure vale almeno . Boccacc. n. I. E tutti i
panni gli furono indosso stracciati , tenendosi
beato chi pur un poco di quelli potesse avere.
E talvolta certamente. Bocc. g. 8. n. 6. Deh
come dee potere esser questo ? Io il vidi pur
jeri costì .
E talora finalmente. Bocc. g. 8. nov. 9. Si
sfor-
/ BEGIN PAGE 389 /
sforzò di rilevarsi , e di volersi ajutar per
uscirne , ed ora in qua , ed ora in là ricaden-
do , tutto dal capo al piè impastato , dolente ,
e cattivo, avendone alquante dramme ingozza-
te, pur ne uscì fuori.
E per solamente. Bocc. g. 8. nel fine . La
varietà delle cose , che si diranno , non meno
graziosa ne fia, che l’ aver pure d’ una par-
lato .
Quando avverbio di tempo vale , com’ è
noto, in quel tempo , che, addattandosi a tutte
le differenze del tempo.
Quando replicato vale talora . Bocc. g. I.
n 10. Incominciò a continovare , quando a piè ,
e quando a cavallo davanti alla casa di que-
sta donna .
Di quando in quando vale alle volte. Pier
Cresc. Quivi conviene esser luoghi nascosi con
virgulti , ed erbe , dove le lepri di quando in
quando nasconder si poßano.
Quando che sia vale una volta finalmente ,
o in qualche tempo , o in qualunque tempo .
Bocc. g 2 n. 6. Sperando, che, quando che
sia, si potrebbe mutar la fortuna . Passav. f. 38.
Avranno fine, quando che sia, i nostri gra-
vi tormenti .
Quanto avverbio di quantità. Bocc. g. 3.
n. 7. Non sa , quanto dolce cosa sia la ven-
detta , nè con quanto ardor si desideri, se non
chi riceve l’ offese . E g. 6. n. 10. Intendo di
B b 3 mo-
/ BEGIN PAGE 390 /
mostrarvi , quanto cautamente con subito ri-
paro uno fuggisse uno scorno .
Ha la corrispondenza di tanto espressa ,
o sottintesa. Bocc. g. 10. n. 8. Quanto tu ra-
gionevolmente ami Sofronia , tanto ingiusta-
mente della fortuna ti duoli . E g. 4 proem.
Nè dal monte Parnaso , nè dalle muse non
m’ allontano, quanto molti per avventura s’ av-
visano .
Trattandosi di tempo vale quamdiu. Bocc.
g. 2 n. 8. Dell’ eredità de’ miei paßati avoli
niuna cosa rimasa m’ è , se non l’ onestà : quella
intendo io di guardare , e di servare quanto
la vita mi durerà .
Sempre avverbio di tempo vale o senza
intermissione , o ogni volta. Bocc. g. 5. n. 8. Il
qual colpo come la giovane ebbe ricevuto , così
cadde boccone , sempre piagnendo. E g. 9. n. 3.
Con quanti sensali aveva in Firenze teneva
mercato , il quale sempre si guastava , quan-
do al prezzo del poder domandato si perveniva .
Sempre che vale ogni volta che Bocc. g. 2.
n. 4. Sempre che presso gli veniva , quanto
potea con mano la lontanava.
E talora vale mentre che. Bocc. g. 6. n. 4.
Io ti farò conciare in maniera , che tu con tuo
danno ti ricorderai , sempre che tu ci vive-
rai, del nome mio .
Sempre mai sembra avere maggior forza .
Bocc. g. 2. n. 9. Egli credeva certamente, che
se
/ BEGIN PAGE 391 /
se egli diece anni, o sempre mai fuori di casa
dimorasse , ch’ ella mai a così fatte novelle non
intenderebbe.
Senza che vale oltrechè . Bocc. g. 8. n. 7. E
fu sì lungo aspettare , senza che fresco le fa-
ceva troppo più, che voluto non avrebbe , che
ella vide l’ aurora apparire .
Se non che vale nisi. Boccacc. g. 3. n. 3. E
avrei gridato, se non che egli, che ancor den-
tro non era, mi chiese mercò per Dio, e per
voi .
Se non se significa nisi ; e talora il secondo
se, pare, che abbia forza di forse. Gio: Vill.
M. Mastino signore d’ undici cittadi le perdè
tutte , se non se Verona, e Vincenza. Petrar.
A qualunque animale alberga in terra, Se non
se alquanti, che hanno in odio il sole, Tempo
da travagliare è quanto è ’l giorno .
Sì , oltre al senso di affermare , vale an-
cora così. Boccacc. Introd. In abito lugubre ,
quale a sì fatta stagione si richiedea.
Si usa ancora per nondimeno . Bocc. g. 4. n. 8.
Pognamo , che altro male non ne seguisse , sì ne
seguirebbe , che mai in pace, nè in riposo con
lui viver potrei .
E per infinchè . Bocc. g. 2. n. 2. Non si ri-
tenne di correre , sì fu a Castel Guiglielmo .
Gli corrisponde talora il che, o il come .
Bocc. g. 8. n. 2. Che desinava la mattina con
lui Binguccio dal Poggio , e Nuto Buglietti, sì
B b 4 che
/ BEGIN PAGE 392 /
che egli voleva far della salsa. E g. 2. n. 2.
Incominciò a ringraziare Iddio , e S. Giuliano ,
che di sì malvagia notte , com’ egli aspetta-
va, l’ avean liberato .
Si trova talvolta replicato in forza del tum
de’ Latini. Bocc. g. 5. n. I. Era Cimone , sì per
la sua forma, e sì per la sua rozzezza, e sì
per la nobiltà, e ricchezza del padre quasi
noto a ciascun del paese ,
Solo , solamente avverbj limitativi assai noti .
Col che dopo vagliono purchè . Bocc. In-
trod. Senza fare distinzione dalle cose oneste
a quelle, che oneste non sono, solo che l’ ap-
petito le chieggia . E ivi . Molto più ciò per
l’ altrui case facendo, solamente che cose vi
sentissero, che loro venissero a grado.
Non solamente è avverbio relativo di ma .
Bocc. g. 6. n. 10. Chi conosciuto non l’ avesse ,
non solamente un gran rettorico l’ avrebbe
stimato , ma avrebbe detto eßere Tullio me-
desimo .
Sol tanto vale lo stesso, che solamente . Bocc.
g. 3. n. 5. Sol tanto vi dico, che come imposto
m’ avete, così penserò di far senza fallo .
Tanto avverbio di quantità. Bocc. g. 8. n. 7.
So io bene , che cosa non potrebbe essere avve-
nuta , che tanto dispiacesse a Madonna .
Segna lunghezza di tempo . Bocc. Introd.
A me medesimo incresce andarmi tanto tra tante
miserie ravvolgendo.
E col-
/ BEGIN PAGE 393 /
E colla corrispondenza di che. Bocc. g. 9. n. 4.
Se n’ andò a’ suoi parenti a Corsignano , co’
quali stette tanto, che da capo dal padre fu
sovvenuto .
E colla corrispondenza di quanto. Bocc.
Introd. Poichè in quello tanto fur dimorati ,
quanto di spazio dalla Reina avuto avevano ,
a casa tornati trovarono Parmeno studiosa-
mente aver dato principio al suo uficio .
A tempo, a tempi vale ad ora opportuna .
Dant. Parad. cant. 8. Quella sinistra riva, che
si lava Di Rodano , poich’ è misto con Sorga ,
Per suo signor a tempo m’ aspettava . Bocc.
g. 6. n. I. parlando de’ motti, dice : per far-
vi avvedere , quanto abbiano in se di bellez-
za a tempi detti, un cortese impor di silenzio
fatto da una gentildonna ad un cavaliere mi
piace di raccontarvi .
Talvolta vale per alcun tempo. Pier Cresc.
nel Prol. Avvegnachè la lor fortuna a tempo
paja prosperevole , in fine pur manca, e pe-
risce .
A luogo , e a tempo vale parimente oppor-
tunè . Bocc. g. 10. n. 8. Poi a luogo, e a tem-
po manifesteremo il fatto .
Per tempo , per tempissimo vale a buona, o
a bonissim’ ora. Bocc. g. 7. n. 5. E quivi an-
dasse la mattina per tempo. E g. 5. n. 3. Una
mattina per tempissimo levatosi, con lei insie-
me montò a cavallo .
Un
/ BEGIN PAGE 394 /
Un tempo vale per qualche tempo . Bocc.
g. 10. n. I. Preso partito di volere un tempo
eßere appresso ad Anfonso Re d’ Ispagna. Pe-
trar. Felice agnello alla penosa mandra Mi
giacqui un tempo .
Troppo , oltre al noto significato di sover-
chiamente, vale ancora molto , e questo signi-
ficato s’ incontra spessissimo ne’ buoni Autori,
e singolarmente nel Boccaccio. Nov. ant. 83.
Vi trovò tanto oro , e tanto argento strutto ,
che valse troppo più, che tutta la spesa. Bocc.
g. 2. n. 6. Egli è troppo più malvagio , ch’
egli non s’ avvisa .
Via, vie vagliono molto . Nov. ant. 28. E‵
via più matto , e forsennato colui , che pena ,
e pensa di sapere il suo principio . Bocc. g. 3.
princ. Le quali cose, oltre agli altri piaceri,
un vie maggior piacere aggiunsero.
Via vale talvolta orsù. Boccacc. g. 5. n. 4.
M. Lizio udendo questo, disse : via , facciale-
visi un letto tale, quale egli vi cape.
Via via vale subito . Bocc. g. 9. n. 5. E po-
co fa si dieder la posta d’ essere insieme via via .
Vit. S. Margher. Via via che ella fu nata, fu
ripiena di Spirito Santo.
CAP.
/ BEGIN PAGE 395 /
CAP. XVI.
Della costruzione dell’ interjezione .
L’ Interjezione veramente non ha proprio
caso, ma solamente il caso richiesto dal
verbo sottinteso . Pure accenneremo con bre-
vità, quali casi sogliano alle interjezioni ag-
giugnersi .
O , OH , OI .
Quando servono per chiamare hanno il vo-
cativo . Petrar. O aspettata in Ciel beata , e
bella Anima .
E così ancora quando sono esclamazioni .
Boccacc. g 10. n. 3. Oh liberalità di Natan
quanto se’ tu maravigliosa !
Nelle espressioni di contentezza , o di affli-
zione hanno l’accusativo . Petr. canz. 17. O me
beato sopra gli altri amanti. Bocc. g.7. n.2. Oimè
lassa me , dolente me , in che mal’ ora nacqui?
Quindi nate sono le interjezioni dolenti ,
oimè sopr’ accennato, e l’ oisè del Boccaccio
g. 8. n. 6. Oisè, dolente se, che il porco gli
era stato imbolato .
Talvolta nelle espressioni suddette di con-
tentezza , e d’ afflizione si tace l’ interjezio-
ne . Dante Purgat. cant. 26. Beato te, che
delle nostre marche , Rincominciò colei , che pria
ne chiese , Per viver meglio esperienzia im-
bar-
/ BEGIN PAGE 396 /
barche . Boccacc. g. 3. n. 6. Io , misera me, già
sono otto anni , ti ho più , che la mia vita
amato .
Talora , singolarmente nelle espressioni di
dolore , dopo l’ addiettivo , che accenna la
miseria , si pone la persona in dativo , per
proprietà di linguaggio. Bocc. g. 3. n. 7. La
qual morte io ho tanto pianta , quanto dolente
a me . Firenz. Lucid. Oh poverino a me, ch’ io
non sarò mai più buono a nulla.
AH, AHI .
Queste interiezioni vagliono lo stesso, che
le sopraddette ; anzi da ahi si forma ahimè ,
che è lo stesso , che oimè . Solo ci è di par-
ticulare , che fra ahi, e me si frappone tal-
volta alcuna voce dinotante maggiore affet-
to. Bocc. g. 2. n. 5. Ahi lafla me, ch’ assai
chiaro conosco, com’ io ti sia poco cara !
DEH .
Interiezione deprecativa , la quale perciò
suole aver dopo il vocativo. Bocc. n. 2. Deh
amico mio , perchè vuo’ tu entrare in questa
fatica ?
GUAI.
Interiezione di minaccia, o di dolore , che
ha dopo di se il dativo . Moral. S. Gregor.
Guai al peccatore , il quale va per due vie .
Passav. f. 65. Guai a me, che mi mancò quel-
lo , che più m’ era di bisogno .
CO-
/ BEGIN PAGE 397 /
COSI‵
Si adopera a modo d’ interiezione , e in
buona, e in cattiva parte. Petrar. son. 116.
Così cresca il bel lauro in fresca riva . E
canz. 45. E così vada, s’ è pur mio destino .
CAP. XVII.
Della costruzione della congiunzione .
NElla costruzione delle congiunzioni non
si tratta del caso , perchè le congiun-
zioni non ne regolano alcuno , ma si cerca ,
qual modo del verbo esiga ciascuna congiun-
zione , o pure con qual’ ordine , e corredo
debbano porsi le congiunzioni ; il che breve-
mente , e partitamente vedremo .
Delle congiunzioni sospensive ,
e condizionali.
SE . Vale caso che , posto che , dato che , o
verificata la condizione che . Può portare
all’ indicativo , e al congiuntivo , secondo che
esige la sua ipotesi . Boccacc. n. 2. Io son del
tutto , se tu vuogli , ch’ io faccia quello , di
che tu m’ hai cotanto pregato , disposto ad an-
darvi . E ivi n. 10. E se voi il faceste , io
sarei colui , che eletto sarei da voi.
Talora è congiunzione dubitativa , e vale
l’ u-
/ BEGIN PAGE 398 /
1’ utrum de’ Latini . Bocc. Introd. Non so, se
a voi quello se ne parrà , che a me ne par-
rebbe .
Purchè ha forza di se , ma porta seco un
certo che di maggiore efficacia , e ama il
soggiuntivo. Bocc. g. 3. n. 8. La medicina da
guarirlo so io troppo ben fare , purchè a voi
dea il cuore di segreto tenere ciò , che io vi
ragionerò .
Sì veramente vale con patto , con condizio-
ne , e si trova e coll’ indicativo, e col sog-
giuntivo . Bocc. n. 2. Io sono disposto a farlo,
sì veramente , che io voglio in prima andare
a Roma.
Quando si usa in senso di se , o purchè ,
e manda al soggiuntivo Bocc. n. 3. Pensossi
costui avere da poterlo servire, quando vo-
lesse. E g. 2. n. 6. Io voglio alle tue angosce,
quando tu medesimo vogli, porre fine.
Per tal convenente vale purchè . Bocc. g. 4.
n. 2. Io ti perdono per tal convenente, che tu
a lei vada come prima potrai .
Delle congiunzioni indicanti contrarietà .
Ci sono alcune congiunzioni , le quali in-
dicano contrarietà , cioè accennano difficul-
tà in ordine a qualche cosa , la quale poi
da altra susseguente congiunzione vien tolta
via . Ecco le più usitate .
Quan-
/ BEGIN PAGE 399 /
Quantunque vale quamvis , e vuole il sog-
giuntivo . Bocc. g. 8. n. 7. Tu ti se’ ben di me
vendicato , perciocchè , quantunque di Luglio
sia , mi sono io creduta questa notte assiderare .
Benchè ama per lo più il soggiuntivo .
Dante Parad cant. 2. Benchè nel quanto tan-
to non si stenda La vista più lontana .
Trovasi alcuna volta coll’ indicativo . Bocc.
g. 2. n. 10. Benchè a me non parve mai, che
voi giudice foste .
Si noti , che abbenchè , voce da alcuni usa-
ta , è barbara , non trovandosi in alcuno
Scrittore autorevole .
Ancorchè ama parimente il soggiuntivo .
Bocc. g. 9. n. I. Alessandro , ancorchè gran
paura avesse , stette pur cheto .
Si trova coll’ indicativo . Bocc. Teseid. 12.
E tu sacra Diana , e Citerea , Delli cui cori
il numero minore Far mi conviene , ancor’ io
non volea .
Comechè manda similmente al soggiuntivo,
particolarmente se egli corrisponde con non-
dimeno , pure , e altre simili particelle ; ben-
chè talora senza tali corrispondenze si ado-
peri ; non solamente come in parentesi , ma
nel principio, e nel fine del periodo ezian-
dio . Bocc. g. 4. n. 10. Ella , che medica non
era, comechè medico fosse il marito, senz’ al-
cun fallo lui credette esser morto . E ivi n. 3.
L’ ira in ferventissimo furore accende l’ anima
no-
/ BEGIN PAGE 400 /
nostra ; e comechè questo sovente negli uomi-
ni avvenga, nondimeno già con maggior dan-
ni s’ è nelle donne veduto .
Si trova pure talvolta coll’ indicativo .
Bocc. g. 2. n. 8. La sanità del vostro figliuolo
nelle mani della Giannetta dimora , la quale
il giovane focosamente ama , comechè ella non
se ne accorge per quello , ch’ io vegga .
Contuttochè ama il soggiuntivo, ma riceve
talvolta l’indicativo. Bocc. g 7. n 8. Era Arri-
guccio, contuttochè fosse mercatante , un fie-
ro uomo , ed un forte . Gio. Vill. Si ricominciò
la guerra contro agli Aretini, contuttochè nel
segreto tuttora rimasono gli Aretini in trat-
tato d’ accordo co’ Fiorentini .
Avvegnachè vuole il soggiuntivo, ma pur
talvolta riceve l’ indicativo . Bocc. g. 9. n 3.
Darele tante busse , ch’ io la romperei tutta ,
avvegnachè egli mi stea molto bene. E g. 8.
n. 7. I lavoratori erano tutti partiti da’ cam-
pi per lo caldo , avvegnachè quel dì niuno ivi
appresso era andato a lavorare .
Se si trova usato in senso di benchè. Bocc.
g. 4. n. 8. Si dispose , se morir ne dovesse, di
parlarle esso stesso.
CON-
/ BEGIN PAGE 401 /
CONGIUNZIONI , CHE TOLGONO
LA CONTRARIETA‵ .
SOno nondimeno , contuttociò , tuttavia , tut-
tavolta , pure , e simili , le quali corri-
spondono alle congiunzioni di contrarietà so-
praddette ; e quando non le hanno innanzi,
hanno però alcuna cosa contraria , di cui
tolgono la contrarietà. Bocc. g. 2. n. 2. Anzi
con gli altri insieme gridavano , che ’l fosse
morto, avendo nondimeno pensiero tuttavia
come trarre il poteßero delle mani del popolo.
Ecco coloro pensavano di liberar Martelli-
no , a che è contrario il domandar la sua
morte , e questo contrario è tolto dalla con-
giunzione nondimeno , la quale accenna ciò
non ostare alla vera intenzione di liberarlo.
DELLE CONGIUNZIONI
DI CAGIONE.
SOno quelle , che accennano cagione, e le
più frequenti sono =
Acciocchè dinota cagion finale , e vuole il
soggiuntivo . Bocc. g. 2. n. 2. E perciò, accioc-
chè egli niuna sospezion prendesse , come uomini
modesti, e di buona condizione , pure di oneste
cose, e di lealtà andavano con lui favellando.
Talora fra la particella acciò, e la che si
C c frap-
/ BEGIN PAGE 402 /
frappone alcuna parola. Passav. f. 74. Acciò
dunque , che per ignoranza non si scusino &c.
Acciò per acciocchè assai usato volgarmen-
te, non è di troppo buona lega , benchè si
trovi talvolta anche negli autori del buon
secolo .
Affinchè lo stesso che acciocchè . Gio. Vill.
Lasciò in guato fuori di Messina con due capi-
tani duemila cavalieri , affinchè levata l’oste,
se que’ di Messina uscisson fuori , uscissono lo-
ro addosso .
Perchè si usa talora per acciocchè . Bocc.
g. 9. n. 9. Lo ’ncominciò a battere, perchè ’l
passasse .
Che talvolta si adopera per acciocchè . Boc-
caccio g. 2. n. 2. Cominciò a riguardare , se
d’ attorno alcuno ricetto si vedesse , dove la
notte potesse stare , che non si morisse di
freddo .
Le congiunzioni dinotanti le altre cagioni
non mandano determinatamente ad alcun mo-
do del Verbo , e perciò noteremo solo , e
con brevità, il loro uso.
Perchè è particella interrogativa, e vale:
per qual cagione ? E si adopera nello stesso
senso in risposta. Dante Purg. 5. Deh perchè
vai ? Deh perchè non t’ arresti ? Bocc. g. 3.
n. 8. E perchè cagione ? disse Ferondo. Diße
il monaco : perchè tu fosti geloso .
Si usa ancora senza interrogazione. Bocc.
g. 10.
/ BEGIN PAGE 403 /
g. 10. n. 3. Chi egli era, e perchè venuto , e
da che moßo interamente gli discoperse .
Ci sono congiunzioni , le quali per entro
il periodo indicano la ragione del detto avan-
ti , e sono perciò , per questo , perchè , però ,
posciachè, e simili. Altre si usano il più nel
principio del periodo, come imperciocchè ,
imperocchè , conciossiacosachè , per la qual co-
sa , e simili , che servono a render ragione
delle cose antecedentemente dette . Non oc-
corre parlare con maggior particularità di
queste congiunzioni, perchè non esigono mo-
do determinato di Verbo. Solamente è da
dire alcuna cosa di conciossiacosachè , concios-
siachè , conciofossechè , e conciofossecosachè .
Questi due ultimi , siccome includono il sog-
giuntivo , così vi mandano ancora . Passav.
f. 213. Conciofossecosach’ egli non avesse in se
altra bontà , per la quale potesse farsi nome .
Le altre precedenti congiunzioni talvolta han-
no l’ indicativo, talvolta il soggiuntivo . Pas-
sav. f. 96. Conciossiacosachè molti sono , che
lascerieno innanzi la confessione, che si confes-
sassero da’ proprj preti. E f. 146. Conciossia-
cosa adunque che l’ uomo sia tenuto di confes-
sare i peccati dubbj.
C c2 DEL-
/ BEGIN PAGE 404 /
DELLE CONGIUNZIONI
AVVERSATIVE.
SOno quelle , che accennano contrarietà ,
correzione, o limitazione delle cose det-
te . Ecco le più frequenti .
Ma . Boccacc. Introd. Ma non voglio per-
ciò , che questo di più avanti leggere vi spa-
venti .
Corregge talvolta , e vale anzi . Gio. Vill.
Nota, lettore , che le più volte , ma quasi sem-
pre avviene a chi si fa signore d’ aver sì fat-
ta uscita .
Ma che ? vale il sed quid ? de’ Latini . Boc-
caccio g. 8. n. 10. Ma che ? fatto è , vuolsi ve-
dere altro .
Se non che vale nisi . Petrar. canz. 18. Luci
beate , e liete, Se non che ’l veder voi stes-
se v’è tolto .
Pure . Boccaccio g. 4. n. 6. E comechè questo
a’ suoi niuna consolazion sia , pure a me , nel-
le cui braccia egli è morto , sarà un piacere .
E lo stesso senso, o poco diverso , hanno le
congiunzioni sopra notate , che tolgono la
contrarietà .
Anzi . Bocc. g. 2. n. I. Non ardivano ad
ajutarlo, anzi cogli altri insieme gridavano ,
che ’l fosse morto .
Dove, laddove si usano avversativamente .
Bocc.
/ BEGIN PAGE 405 /
Bocc. n. 2. Ritornasse alla verità Cristiana , la
quale egli potea vedere prosperare , ed aumen-
tarsi ; dove la sua in contrario diminuirsi , e
venire al niente poteva discernere . E n. I. Per
Ser Ciappelletto era conosciuto per tutto ; lad-
dove pochi per Ser Ciapperello il conoscieno .
DELLE CONGIUNZIONI COPULATIVE ,
E DISGIUNTIVE.
LE copulative sono quelle , che insieme
congiungono le parti del discorso .
E copula , la quale talvolta per fuggire
l’ incontro delle vocali riceve il d . Boccacc.
Proem. Essendo acceso stato d’ altissimo, e nobi-
le amore . E g. 8. n. 3. Ed ivi presso correva un
fiumicel di vernaccia .
Si replica leggiadramente la copula a cia-
scuna delle parole , che sono da essa con-
giunte . Petrar. son. 239. L’ acque parlan d’amo-
re , e l’ ora , e i rami , E gli augelletti , e i
pesci , e i fiori , e l’ erba .
Talvolta a tutte si tace . Petrar. son. 262.
Fior , frondi , erbe , ombre , antri , onde , au-
re soavi , Valli chiuse, alti colli, e piagge
apriche .
Anche , e in verso anco , ancora , di più ,
parimente, eziandio, altresì sono congiunzioni
copulative, che accennano continuazione .
Bocc. g. 2. n. 10. Anche dite voi , che voi vi
C c 3 sfor-
/ BEGIN PAGE 406 /
sforzerete, e di che ? Petrar. Di quanto per
amor giammai soffersi, Ed aggio a soffrire an-
co . Bocc. g. I. n. 10. Acciocchè , come per no-
biltà d’ animo dall’ altre divise sete , ancora
per eccellenza di costumi separate dall’ altro
vi dimostriate . E n. ult. Egli m’ ha comanda-
to , ch’ io prenda questa vostra figliuola, e che
io ; e non disse di più . E g. 3. n. 7. Trovò che
l’ aspettava , parimente disiderosa di udir buo-
ne novelle del marito . E n. ult. E come don-
na , la quale eziandio negli stracci pareva ,
nella sala la rimenarono . Gio. Vill. La detta
Città d’ Aurelia fu altresì distrutta per lo det-
to Totile .
Le congiunzioni disgiuntive sono quelle,
che disgiungono nel senso le parti del par-
lare .
O . Bocc. g. 6. n. 2. Io non so da me mede-
sima vedere , chi più in questo si pecchi ; o la
natura apparecchiando ad una nobile anima un
vil corpo ; o la fortuna apparecchiando ad un
corpo dotato d’ anima nobile vil mestiero .
Ovvero lo stesso , che o . Gio. Vill. Nem-
brotte il gigante fu il primo Re , ovvero ret-
tore , o ragunatore di congregazione di genti .
E lo stesso significano o pure , o veramente ,
e simili .
Nè di sua natura è negativa , ma è tal-
volta puramente disgiuntiva , come o . Bocc.
g. 5. n. 6. Nè oltre a due piccole miglia si di-
lun-
/ BEGIN PAGE 407 /
lungarono da essa. E g. 10. n 8. Io non cercai,
nè con ingegno , nè con fraude d’ imporre al-
cuna macola all’ onestà, e alla chiarezza del
vostro sangue . Petrar. canz. 40. Anzi la vo-
ce al mio nome rischiari , Se gli occhi suoi ti
fur dolci , nè cari .
DELLE CONGIUNZIONI
AGGIUNTIVE .
SOno quelle, che accennano aggiugnimen-
to alle cose dette , come anzi , di più ,
inoltre , oltracciò , oltrechè, appresso, ancora ,
altresì , di vantaggio , e simili , nell’ uso del-
le quali non solendo occorrere varietà nota-
bile , basterà averle accennate .
DELLE CONGIUNZIONI ELETTIVE.
QUelle sono, che accennano elezione di
una cosa , e sono le seguenti .
Anzi . Bocc. g. 9. n. 10. Io , il quale
sento anzi dello scemo , che no, più vi debbo
esser caro .
Più tosto , più presto . Boccaccio Laber. Già
tanto s’ era il mal radicato , che più tosto so-
stenere , che medicar si potea . Guicciardin.
Stor. lib. I. f. 60. Sarei stato Re più presto simi-
le ad Alfonso vecchio mio proavo , che a Fer-
dinando.
Cc 4 Pri-
/ BEGIN PAGE 408 /
Prima , e pria si usano in vece di piutto-
sto . Petrar. Ma pria fia ’l verno la stagion
de’ fiori, Ch’ amor fiorisca in quella nobil’ al-
ma .
Meglio si usa per più tosto . Gio. Vill. Pic-
coletto di persona , e brutto , e barbucino , pa-
rea meglio Greco, che Francesco.
DELLE CONGIUNZIONI
ILLATIVE .
SOno quelle , che accennano illazione di
una cosa dall’ altra, come le seguenti .
Adunque , dunque . Bocc. g. 3 n. 8. Adun-
que, disse la donna , debbo io rimaner Vedo-
va ? E g. 2. n. 2. Va , dunque , disse la don-
na , e chiamalo .
Ecco vale talvolta adunque . Petrar. cap. 11.
Ecco s’ un’ uom famoso in terra visse , E di
sua fama per morir non esce , Che sarà della
legge , che ’l ciel fisse ?
Onde . Petrar. La gola , e ’l sonno , e l’ ozio-
se piume Hanno dal mondo ogni virtù sban-
dita , Ond’ è dal corso suo quasi smarrita
Nostra natura vinta dal costume .
Quindi . Albertan. Savj pochi si trovano ,
onde ne’ partiti , che si fanno ne’ consigli, sem=
pre perdono , e quindi è , che ne’ partiti , che
si soglion fare ne’ consigli delle città , i consi-
gli seguiscono malo effetto.
Per-
/ BEGIN PAGE 409 /
Pertanto . Pecor. g. 3. n. I. Jeri , messere ,
toccò a me l’ andare pensoso , oggi pare, che
tocchi a voi , e pertanto io non voglio , che
pensiate più sopra questo fatto .
Ora si usa talora per adunque. Dante Inf.
cant. 2. Tu m’ hai con desiderio il cor disposto
Sì al venir con le parole tue , Ch’ i’ son tor-
nato nel primo proposto : Or va , ch’ un sol vo-
ler è d’ amendue .
In somma è congiunzione conclusiva . Dan-
te Inf. cant. 15. In somma sappi , che tutti fur
cherci , E letterati grandi .
DI VARIE ALTRE CONGIUNZIONI.
CIoè congiunzione dichiarativa delle co-
se precedenti. Bocc. g. 4. n. 3. E loro ,
che di queste cose niente ancor sapevano, cioè
della partita di Folco, e della Ninetta , co-
strinse a confeßare .
Cioè a dire vale lo stesso . Passav. f. 120.
La sesta condizione , che dee avere la confes-
sione , si è frequens ; cioè a dire, che si fac-
cia speßo .
Così vale talvolta adunque . Bocc. g. I. n. 10.
Il maestro ringraziò la donna , e ridendo , e
con festa da lei preso commiato , si partì . Co-
sì la donna, non guardando cui motteggiasse ,
credendosi vincere , fu vinta .
Che ha varj usi . Si adopera in vece d’ il
che,
/ BEGIN PAGE 410 /
che , ordinariamente nel far parentesi . Bocc.
Introd. L’ un fratello l’ altro abbandonava , e
( che maggior cosa è ) i padri , e le madri i
figliuoli .
E‵ interrogativo tacito , o espresso , e su-
stantivo, e addiettivo , e anche con casi , co-
me da’ seguenti esempj. Boccaccio g. 3. n. 6.
Che ha colei più di me ? g. 2. n. 2. E del buo-
no uomo domandò, che ne fosse . Passav. f. 69.
A che sarebbono date le chiavi a S. Piero ?
Bocc. g. 8. n. 7. E da che Diavol se’ tu più ,
che qualunque altra dolorosetta fante ? E n. I.
Che uomo è costui?
Che frequentemente vale l’ ut , e ’l quod
de’ Latini . Bocc. g. 7. n. 9. Voglio, ch’ ella mi
mandi una ciocchetta della barba di Nicostrato.
Nel senso predetto che manda al soggiun-
tivo , ma pur si trova ancora coll’ indicati-
vo. Passav. f. 92. Il peccatore così accommia-
tato , ne va scornato, e non contento . E puote
intervenire , che per lo sdegno si dispera , e
non va a confessarsi ad altro confessore .
Talvolta si tralascia , singolarmente met-
tendo in sua vece un non. Bocc. g. I. n. 10.
Questa ultima novella voglio ve ne renda am-
maestrate . E n. I. Dubitavan forte, non Ser
Ciappelletto gl’ ingannasse .
Talora vale se non. Bocc. g. 9. n. 6. Non
aveva l’ oste , che una cameretta assai piccola .
Vale ancora talvolta parte , tra. Boccacc.
g. 2.
/ BEGIN PAGE 411 /
g. 2. n. 9. Donolle , che in gioje , e che in va-
sellamenti d’oro , e d’ ariento , e che in da-
nari quello , che valse meglio d’ altre decimi-
la dobbre .
E in vece di perchè interrogativo . Bocc.
g. 3. n. 6. Che non rispondi, reo uomo ? Che
non dì qualche cosa ?
E in vece d’ imperocchè . Bocc. n. I. Dillo
sicuramente , ch’ io ti prometto di pregare Id-
dio per te .
E in vece di finchè . Bocc. g. 9. n. 8. E non
riposò mai , ch’ egli ebbe trovato Biondello .
In principio di clausula imprecativa vale
utinam . Bocc. g. 8. n. 3. Che maladetta sia
l’ ora , ch’ io prima la vidi .
Come vale in che maniera . Bocc. g. 3. n. 9.
Quello , che i maggiori medici del mondo non
hanno potuto, nè saputo, una giovane femmi-
na come il potrebbe sapere ?
Come ? E come? vale il quid de’ Latini. Bocc.
g. 4. n. 9. Come ? che cosa è questa , che voi
m’ avete fatta mangiare ? E g. 2. n. 6. E co-
me ? disse il prigioniero, che monta a te quel-
lo, che i grandissimi Re si facciano ?
E in vece di perchè interrogativo . Bocc.
g. 8. n. 4. Il quando potrebbe essere quando più
vi piacesse , ma io non so pensar il dove . Dis-
se il Proposto : come no? o in casa vostra . E
ivi n. 7. Come nol chiami tu , che ti venga
ad ajutare .
E per
/ BEGIN PAGE 412 /
E per quanto. Bocc. g. 3. n. I. Deh come
ben facesti a venirtene !
E per poichè . Bocc. g. 2. n. 10. Come a se-
dere si furon posti , cominciò M. Ricciardo a dire .
E per qualmente . Bocc. g. 8. n. 6. Tu sai,
Buffalmacco, come Calandrino è avaro , e co-
me egli bee volentieri, quando altri paga .
Talvolta contiene in se la forza del rela-
tivo. Bocc. g. I. n. 4. Io voglio andare a tro-
var modo , come tu esca di qua entro .
CAP. XVIII.
Della costruzione figurata .
RIcchissima è di modi figurati la lingua ,
Toscana , e perciò non essendo facile
il ridurli sotto un solo capitolo , senza farne
un lungo , e rincrescevol catalogo , gli ho
sparsi per entro l’ opera nelle appendici, se-
condo che esigeva la lor costruzione, riser-
bando a questo capitolo il dar l’ idea delle
figure gramaticali . Così ne verranno, se io
non mi lusingo, due acconci : e che i gio-
vani potranno imparare con qualche metodo
le Toscane eleganze : e che colla dottrina
di questo capitolo ne prenderanno , per così
dire , il filo, e conosceranno agevolmente ,
a qual figura ciascun modo appartenga .
Or cinque sono le figure gramaticali , che
sono più in uso, cioè l’ellissi , per cui si
tra-
/ BEGIN PAGE 413 /
tralascia qualche parte dell’orazione ; il pleo-
nasmo , per cui si mette nell’ orazione al-
cuna parola , che potrebbe dirsi superflua ;
la sillessi , per cui le parti dell’ orazione di-
scordano l’ una dall’ altra ; l’ ennallage , per
cui si mette una parte dell’ orazione in ve-
ce di un’ altra, che naturalmente v’ andreb-
be ; e l’ iperbato, per cui vien turbato l’ or-
dine naturale delle parti dell’ orazione . E
benchè tali modi sembrino errori contro le
leggi gramaticali, sono però errori fatti con
ragione, come dice Benedetto Fiorentino nel
principio dell’ egregia sua Opera della costru-
zione irregolare. Or questa ragione si è, o
la maggior brevità del parlare, o un certo
non so che di vaghezza, e di grazia , che
hanno alcuni modi di favellare fuori delle
regole più comuni. E di queste veneri, come
le chiamavano i Latini, o sieno maniere di-
sinvolte di parlare, abbondano gli scrittori
del buon secolo della nostra lingua, cogli
esempj de’ quali confermeremo quanto da noi
dovrà dirsi intorno alla costruzione irregolare
toscana.
DELLA ELLISSI .
USitatissima presso i nostri antichi maestri ,
e anche nel parlar famigliare Toscano
si è la figura ellisi , per la quale con va-
ghezza , e senza oscurità, si tace, or l’ una
or
/ BEGIN PAGE 414 /
or l’ altra delle parti dell’ orazione, come
brevemente vedremo .
Ellissi del nome sustantivo . E' frequentissi-
ma , ed eccone alquanti esempj . Boccacc.
g. 2. n. 5. Niuno male si fece nella caduta ,
quantunque alquanto cadesse da alto . Cioè
luogo . E g. 4. n. 2. Io ci tornerò, e darottene
tante , ch’ io ti farò tristo per tutto il tempo,
che tu ci viverai. Cioè buße . E quella usa-
tissima, di levarsi , tacendo del letto . Bocc.
g. 5. n. 4. Sopravvenne il giorno, e M. Lizio
si levò. E altre senza fine : ma non posso
tacerne una di Fra Giordano portata dal Vo-
cab. alla voce Assocciare , che dice : Assoccia-
no il bestiame con guadagno usurajo, ed il po-
vero soccio ne va per la mala . Cioè via .
Ellissi del nome addiettivo . Gli addiettivi
buono , abile , capace , e simili si sopprimono
con vaghezza . Bocc. g. 6. n. 2. E sempre poi
per da molto l’ ebbe , e per amico . E g. 2. n. 3.
Fu da tanto , e tanto seppe fare , ch’ egli pa-
cificò il figliuolo col padre . E g. 6. n. 10. Non
sospicò , che ciò Guccio Balena gli avesse fat-
to , perciocchè nol conosceva da tanto .
Quanto al segnacaso , e all’ articolo già
abbiamo detto quando si tacciano dove trat-
tammo della loro particolar costruzione .
Si trova talvolta l’ ellissi del sustantivo ,
e di ogni particella , che possa ad esso rife-
rirsi , come in quel luogo del Bocc. g. 5. n. 9.
Il
/ BEGIN PAGE 415 /
Il garzoncello infermò , di che la madre dolo-
rosa molto , come colei , che più non avea , e
lui amava quanto più si poteva , tutto ’l dì
standogli dintorno , non ristava di confortarlo .
Vuol dire , che colei non aveva altri figliuo-
li , oltre a quello , e perciò v’ è l’ ellissi , e
del nome figliuoli , e insieme di qualunque
altra parte, che si riferisca a’ figliuoli.
Ellissi del Verbo finito . Bocc. Introd. Il che
se dagli occhi di molti , e da’ miei non fosse
stato veduto , appena ch’ io ardissi di crederlo,
non che di scriverlo. Qui manca il Verbo su-
stantivo, e il senso è: appena è, ch’ io ar-
dissi &c. E g. 8. n. 6. Maraviglia, che se’ sta-
to una volta savio . Cioè : maraviglia è. Ma
sopra tutti è vaghissimo il luogo del Passa-
vanti f. 48., dove l’Albergatore di Malman-
tile domandato da S. Ambrogio di sua con-
dizione, risponde così : io ricco , io sano , io
bella donna , aßai figliuoli , grande famiglia :
nè ingiuria , onta , o danno ricevetti mai da
persona : riverito , onorato , careggiato da tutta
gente : io non seppi mai che male si foße , o
tristizia ; ma sempre lieto, e contento sono vi-
vuto , e vivo .
Ellissi del verbo infinito. Bocc. g. 7. n. 5. E
quivi spesse volte insieme si favellavano, ma
più avanti per la solenne guardia del geloso
non si poteva. Supplisci fare . E g. 10. n. 9.
Con poche parole rispose, impossibil, che mai i
suoi
/ BEGIN PAGE 416 /
suoi beneficj, e il suo valore di mente gli uscis-
sero . Cioè impossibil’ essere . E a questo capo
si riduce quel modo toscano, che altrove
abbiamo addotto , cioè andar per una perso-
na , o cosa, perchè v’ è ellissi dell’ infinito,
e vuol dire andare a chiamarla , o prenderla.
Ellissi del participio. Bocc. g. 9. n. I. O se
essi mi cacciasser gli occhi , o mi traessero i
denti, o mozzassermi le mani, o facessermi al-
cuno altro così fatto giuoco, a che sare’ io ?
Supplisci ridotto, o simile.
Ellisse della preposizione . E' molto frequen-
te negli Autori Latini , ma non egualmente
ne’ Toscani ; ma pure non ne mancano esem-
pj . E prima gli infiniti mangiare, bere, bec-
care retti dal verbo dare sempre, o quasi
sempre lasciano la preposizione da , purchè
sieguano al verbo dare immediatamente , o
almen non vi sia avverbio di mezzo . Bocc.
g. 2. n. 9. Al quale il Soldano avendo alcuna
volta dato mangiare , e veduti i costumi di
Sicurano , che sempre a servir l’ andava , e
piaciutigli, al Catalano il dimandò. E ivi n. 7.
Ordinò con colui , che a lei serviva , che di
varj vini mescolati le desse bere, il che colui
ottimamente fece . E g. 6. n. 2. S’ avvisò, che
gran cortesia sarebbe il dar lor bere del suo
buon vin bianco. E g. 9. n. 6. Nel pian di Mu-
gnone fu un buon’ uomo, il quale a’ viandanti
dava pe’ lor danari mangiare, e bere. E g. 3.
n. I.
/ BEGIN PAGE 417 /
n. I. Lusingalo , fagli vezzi , dagli ben da
mangiare . E g. 5. n. 10. Pareva pur Santa
Verdiana , che dà beccare alle serpi .
Parimente vostra mercè , sua mercè, e al-
tri sì fatti modi altrove accennati , conten-
gono l’ ellissi della preposizione per .
Può dirsi ancora , esservi l’ ellissi della pre-
posizione per , qualunque volta si usa che in
vece di perchè . Bocc. g. 9. n 10. Che non ti
fa’ tu insegnare quello incantesimo ?
Similmente si usa che in vece di nel qua-
le . Bocc. g. 10. p. 9. M. Torello in quell’ abi-
to , che era , con lo Abate se n’ andò alla casa
del novello sposo .
Ellissi dell’ avverbio . Sì usa ne’ relativi ,
tacendo uno degli avverbj di corrisponden-
za . Dante Inf. cant. 2. Al Mondo non fur mai
persone ratte A far lor pro , ed a fuggir lor
danno, Com’ io dopo cotai parole fatte . Cioè
talmente ratte . Bocc. Introd. Ora foßero essi
pur già disposti a venire, che veramente, co-
me Pampinea diße, potremmo dire la fortuna
eßere alla nostra andata favoreggiante . Man-
ca nel principio l’ avverbio così , e dovrebbe
dire : così fossero essi &c.
Può essere ancora ellissi di uno avverbio
in quel modo di dire usato dal Boccaccio
per asserire una cosa molto notabile , cioè :
io dico , ed è modo tolto da’ Franzesi , o da’
Provenzali. Bocc. g. 8. n. 2. Guarda che di
D d cosa,
/ BEGIN PAGE 418 /
cosa, che voglia mai, io dico s’ e’ volesse l’a-
sin nostro , non che altro , non gli sia detto di
no . E ivi n. 9. E’ vi sono tutte le Reine del
mondo ; io dico infino alla Schinchimurra del
Presto Giovanni .
Ellissi dell’ interiezione . Di questa abbiamo
parlato di sopra , dove trattammo delle in-
teriezioni, e portammo esempj di : misero me,
lasso me, beato lui, e simili modi, ne’ quali
si tace l’interiezione.
Ellissi della congiunzione . Si usa di rado .
In verso si tace la copula e, e alcuna volta
l’ avversativa ma . Petrar. son. 201. Real na-
tura , angelico intelletto , Chiar’ alma , pronta
vista , occhio cerviero , Providenza veloce ,
alto pensiero, E veramente degno di quel pet-
to . Dante Paradis. cant. 4. Ma or ti s’ attra-
versa un’ altro passo Dinanzi agli occhi tal ,
che per te stesso Non n’ usciresti , pria saresti
lasso . Supplisci : ma pria saresti &c.
La congiunzione che si tralascia , come di-
cemmo , mettendo in sua vece , non senza
vaghezza , la particella non , e ciò si fa sin-
golarmente ne’ dubbj. Bocc. g. 2. n. 7. Teme-
va forte , non sopra lei l’ ira si volgesse de’
parenti . E ivi n. 9. Suspicò , non costui in al-
cuno atto l’ avesse raffigurato .
Ellisi del pronome : Io, e tu si possono li-
beramente lasciare , perchè si rinchiudono
chiaramente nel verbo . Altri pronomi anco-
ra si
/ BEGIN PAGE 419 /
ra si tacciono, ma con giudicio, e sobrietà .
Dante Purg. cant. 15. Disse : che hai , che non
ti puoi tenere ? Ma se’ venuto più , che mez-
za lega Velando gli occhi , e con le gambe av-
volte , A guisa di cui vino , o sonno piega ?
Cioè : a guisa di colui , cui vino &c. Bocc.
g. 10. n. 9. Sperando, che, quando che sia , di
ciò merito ci debba seguire . Cioè quando che
ciò sia .
Ellissi della copula , la quale si tralascia
talvolta fra gli addiettivi continuati . Bocc.
g. 2. n. 9. Io sono la misera sventurata Zinevra .
E nella Concl. Continua fraternal dimesti-
canza mi ci è paruto vedere , e sentire .
DEL PLEONASMO .
FRequentissima è nella nostra lingua que-
sta figura , alla quale appartengono i ri-
pieni , de’ quali abbiamo già copiosamente
trattato. Aggiugneremo qui alcuni altri mo-
di di questa figura praticati dagli Autori del
buon secolo .
Il replicare senza necessità i pronomi è as-
sai frequente ne’ buoni Autori . Bocc. g. 10.
n. 3. Comechè ogni altro uomo molto di lui si
lodi , io me ne poßo poco lodare io . E g. 6.
nel princ. Vatti con Dio ; credi tu saper più
di me tu , che non hai ancora rasciutti gli oc-
chi ? E g. 3. n. I. Elle non sanno delle sette
D d 2 volte
/ BEGIN PAGE 420 /
volte le sei quello , ch’ elle si vogliono elleno
stesse .
Si replica la preposizione con , ponendola
innanzi a meco , teco, seco. Bocc. g. 3. n. 8.
Farete pure , che domane , o l’ altro dì egli
qua con meco se ne venga a dimorare . E
g. 8. n. 10. Spero d’ avere assai buon tempo con
teco . Ninf. Fiesol. La qual , mentre che tu
starai con seco , Sempre come figliuola le sarai .
E‵ frequente presso i Toscani il pleonasmo
nell’ aggiugnere qualche verbo non punto ne-
cessario al sentimento, ma per proprietà di
linguaggio . Ecco i più usitati .
Dovere . Bocc. g. I. n. 2. Richiese i cherici
di là entro , che ad Abraam dovessero dare il
battesimo . Cioè dessero . E g. 2. n. 5. S’ avvi-
so , questa donna dovere essere di lui inna-
morata . Cioè essere .
Venire cogl’ infiniti, co’ gerundj , e co’ par-
ticipj . Boccacc. n. ult. Il che quando venni a
prender moglie , gran paura ebbi , che non m’in-
tervenisse . E g. 8. n. 5. Tutto il venne consi-
derando . E g. I. n. 6. Gli venne trovato un
buono uomo . Cioè presi, considerò, trovò.
Andare co’ gerundj d’ altri verbi. Bocc.
Introd. A me medesimo incresce andarmi tanto
tra tante miserie ravvolgendo. E ivi. Van-
no fuggendo quello, che noi cerchiamo di fug-
gire .
DEL-
/ BEGIN PAGE 421 /
DELLA SILLESSI .
QUesta non è molto in uso , ma pur si
trova ne’ buoni Autori , e ne abbia-
mo addotti gli esempj nel cap. I. di
questo libro , dove trattammo della concor-
danza delle parti dell’ orazione .
DELL’ ENALLAGE .
QUesta figura è frequentissima nella no-
stra lingua , di cui è proprietà porre
in certi casi una parte dell’ orazione
per l’altra .
L’ infinito in vece del verbale alla Latina ,
come vivere per vita. Bocc. g. 8. n. 9. E da
questo viene il nostro viver lieto, che voi ve-
dete .
L’ addiettivo in vece dell’ avverbio. Bocc.
n. 2. Ora tutto aperto ti dico , che io per niu-
na cosa lascerei di Cristian farmi. Cioè aper-
tamente. E g. 2. n. 5. Ahi lassa me , che assai
chiaro conosco , come io ti sia poco cara. E Pe-
trar. son. 126. Chi non sa come dolce ella
sospira , E come dolce parla , e dolce ride .
Cioè dolcemente .
Il participio per l’ infinito . Bocc. g. 2. n. 5
Fece venire sue lettere contraffatte da Roma ,
e fece veduto a’ suoi sudditi , il Papa per
D d 3 quelle
/ BEGIN PAGE 422 /
quelle aver seco dispensato di poter torre al-
tra moglie . Cioè fece vedere .
Il preterito determinato in vece dell’ inde-
terminato dell’ indicativo . Nov. ant. 35. Io an-
dava per grande bisogno in servigio della mia
donna , e il Re fu giunto , e diße : Cavalie-
re , a qual donna se’ tu ? Cioè giunse . Bocc.
g. 2. n. 5. Alzata alquanto la lanterna , eb-
ber veduto il cattivel di Andreuccio . Cioè
veddero . Buonarroti cical. I. Avvisandomi ,
qualche scompiglio nel vicinato esser dovuto
succedere , alla finestra affacciatomi ebbi ve-
duto due , che &c. Cioè veddi.
Il congiuntivo per l’ indicativo . Bocc. g. 6.
in princ. Vedi bestia d’ uomo, che ardisce, do-
ve io sia , a parlare prima di me. Cioè sono ,
perchè Tindaro voleva rispondere allora alla
Reina , presente la Licisca, che parlava .
Il preterito in vece del presente dell’ indi-
cativo . Bocc g. 7. n. 7. Anichino gittò un gran-
dissimo sospiro . La donna guardatolo disse: che
avesti Anichino ? Duolti così , che io ti vinco ?
Cioè che hai ? E g. 7. n. 9. Or che avesti, che
fai cotal viso. Lo stesso .
L’ imperfetto per lo trapassato del sog-
giuntivo , maniera usata molto dagli antichi .
Nov. ant. 94. Alzò questi la spada , e fedito
l’ avrebbe, se non fosse uno , che stava ritto
innanzi , che lo tenne per lo braccio . Cioè non
fosse stato. E g. 8. n. 7. E se non fosse , ch’
egli
/ BEGIN PAGE 423 /
egli era giovane , e sopravveniva il caldo ,
egli avrebbe avuto troppe da sostenere . Cioè
non fosse stato .
L’ imperfetto per l’ indeterminato dell’ ot-
tativo . Bocc. n. I. Egli sono state assai volte
il dì, che io vorrei più tosto essere stato mor-
to , che vivo , veggendo i giovani andare die-
tro alla vanità . Cioè avrei voluto .
Un verbo per uno avverbio . Bocc. g. 8. n. 9.
Sie pur infermo , se tu sai , che mai di mio
mestiere non ti torrò un denajo . Cioè quan-
tumlibet .
Un verbo per una interiezione . Bocc. g. 9.
n. 10. Se m’ ajuti Iddio , tu se’ povero , ma
egli sarebbe mercè , che tu fossi molto più . E
g. 5. n. 10. Se Dio mi salvi , di così fatte
femmine non si vorrebbe aver misericordia .
Questi modi hanno forza d’ interiezione di
notante passione .
Simile è la frase : Iddio il dica per me ,
equivalente ad interiezione ammirativa , o
esaggerativa . Bocc. g. 2. n. 10. Come egli mi
conci , Iddio vel dica per me. E g. 7. n. I. Una
di quelle Romite , ch’ è pur , Gianni mio , la
più santa cosa, che Iddio tel dica per me.
Possono in qualche senso appartenere all’
enallage i verbi , i quali da’ Toscani ele-
gantemente si adoperano in vece de’ verbi
proprj , benchè in ciò spesso intervenga fi-
gura non gramaticale . Non pochi ne abbia-
D d 4 mo
/ BEGIN PAGE 424 /
mo addotti nelle appendici agli ordini de’
verbi ; ne addurremo qui alcuni altri a be-
nefizio degli studiosi .
Avere per riputare . Bocc. n. I. Gli diede
la sua benedizione , avendolo per santissimo
uomo .
Avere per ritenere . Bocc. g. 2. n. 4. Disse
alla buona femmina , che più di cassa non ave-
va bisogno, ma che, se le piacesse , un sacco
gli donaße, e avessesi quella.
Avere per intendere , o sapere. Bocc. g. 4.
n. 9. Donna, io ho avuto da lui, ch’ egli non
ci può eßere di qui domane . Gio. Vill. Per
lettere di nostri Cittadini degni di fede , ch’ e-
rano in que’ paesi , s’ ebbe , come a Sibastia
piovveno grandissima quantità di vermini.
Avere per procacciare . Nov. ant. 54. Che
ordinò questa gentildonna ? Ebbe uno cavallo ,
e da’ suo’ fanti il fece vivo scorticare .
Fare per proccurare. Bocc. g. 4. in princ.
Deh se vi cal di me, fate, che noi ce ne me-
niamo una colassù di queste papere .
Fare si usa in luogo di verbo precedente
nel discorso, e che altri non vuol replicare,
e ha la forza del medesimo verbo . Bocc.
g. 2. n. 6. Così lei poppavano, come la madre
avrebber fatto. Cioè avrebber poppato . E g. 4.
n. 8. Tu diventerai molto migliore, e più co-
stumato , e più da bene là , che qui non fare-
sti. Cioè diventeresti. E g. 6. n. 8. Per certo
M. Ge-
/ BEGIN PAGE 425 /
M. Geri mi manda pure a te . Al qual Cisti
rispose : per certo , figliuol, non fa. Cioè non
ti manda a me .
Farsi per isporgersi , o affacciarsi . Bocc.
g. 2. n. 4. Fattasi alquanto per lo mare , il
quale era tranquillo , e per gli capelli preso-
lo , con tutta la cassa il tirò in terra. E n. 5.
La vide in capo della scala farsi ad aspettar-
lo . E g. 3. n. 3. Nè poßo farmi , nè ad uscio ,
nè a finestra .
Farsi con Dio per restare , o andarsene .
Bocc. g. 7. n. 10. Meuccio fatti con Dio , che
io non posso più stare con teco . Franco Sacch.
nov. 157. Fatevi con Dio, e di me non fate
ragione .
Farsi a credere per semplicemente credere .
Bocc. Introd. Facendosi a credere , che quello
a lor si convenga , e non si disdica , che alle
altre .
Rendersi monaco , o frate per vestir l’abi-
to d’ alcuna Religione Gio. Vill. l. 2. c. 14.
n. 2. Ed elli si rendéo Monaco in San Marco
in Sansogna .
Portare in pace per sopportare . Bocc. g. 8.
n. 7. Ma sai, che è ? portatelo in pace .
Portare per esigere . Bocc. g. 10. n. 6. Ven-
nero le due giovanette in due giubbe di zen-
dado bellissime , con due grandissimi piattelli
d’ argento in mano pieni di varj frutti, secon-
dochè la stagione portava .
Sta-
/ BEGIN PAGE 426 /
Stare , o recarsi cortese per tenere le mani
al petto . Boccacc. g. 8. n. 9. Sempre tremando
tutto, si recò colle mani a star cortese . Fran-
co Sacch. n. 156. E detto questo , e fatto , re-
candosi cortese, diße .
Recarsi ubbía per avere ubbía . Franco Sacch.
n. 48. Per dilungarsi dal morto, e fuggir l’ ub-
bía, che sempre si recava de’ morti.
All’ enallage riduconsi alcuni nomi, che in
vece d’altri si usano .
Santa ragione val molto. Bocc. g. 7. n. 8.
Battutala adunque di santa ragione .
Bella, vecchia aggiunto a paura val gran-
de . Bocc. g. 8. n. 2. Per bella paura si rap-
pattumò con lui. Pulci Morg. cant. 5. st. 38. E
fece a tutti una vecchia paura .
Solenne l’ usa il Bocc. per grande , eccel-
lente , o magnifico , e l’ aggiugne a dono,
convito , uomo , giucatore , bevitore , vino &c.
Fatto per uomo , personaggio &c. Bocc.
n. 7. Qualche gran fatto dee esser costui , che
ribaldo mi pare .
DELL’ IPERBATO .
CInque sorte d’ iperbato distinguono i Gra-
Matici , delle quali tratteremo qui , ma
con brevità .
La prima si è l’ anastrofe , cioè trasposi-
zione, ed è, quando una voce, che dovreb-
be
/ BEGIN PAGE 427 /
be stare avanti , si mette dopo . N’ è pieno
il Boccaccio. G. 8. n. 5. in princ. E‵ ella tanto
da ridere , che io la pur dirò . E nel fine della
giornata : Madonna , io non so come piacevole
Reina noi avrem di voi , ma bella la pure
avrem noi . E in altri luoghi senza fine , nell’
imitare i quali molta circospezione usar fi
vuole .
Il mettere il sustantivo in mezzo a due ad-
diettivi fu molto usato dal Boccaccio . G. 2.
n. 6. Videvi due cavrioli , forse il dì medesi-
mo nati , i quali le parevano la più dolce co-
sa del mondo , e la più vezzosa . E g. 4. n. 2.
Un’ uomo di scelerata vita , e di corrotta , il
quale fu chiamato Berto della Massa . E ivi
n. 6. A piè di una bellissima fontana, e chia-
ra , che nel giardino era , a starsi se n’ andò .
La seconda è la tmesi , e si fa col dividere
una parola in due , e intramezzarla di un’ al-
tra parola . Di ciò abbiamo addotti esempj
nel decorso dell’ Opera, come quello : acciò
solamente che conosciate ; acciò dunque che per
ignoranza &c., e simili . Abbiamo ancora nota-
to , che gli avverbj non si spezzano , se non se
quando la prima parte dell’ avverbio ha sen-
so d’ intero avverbio : così il Boccaccio dice :
forte , e vituperosamente ; e ’l Passavanti : pri-
ma , e principalmente , perchè forte, e prima
vagliono lo stesso , che fortemente , e prima-
mente . Non già così può dirsi di quegli stron-
ca-
/ BEGIN PAGE 428 /
camenti , che udiamo talvolta : santa , e giu-
stamente ; chiara , e distintamente , e altri sì
fatti , perchè quel santa , e quel chiara di
per se sono nomi , non avverbj.
La terza si è la parentesi, ch’ è l’interrompi-
mento d’ alcun brieve periodo , senza il quale
può stare il rimanente dell’ orazione, e che
nella scrittura si racchiude il più delle volte tra
due lineette curve . Bocc. nell’ Introduzione.
A questa brieve noja ( dico brieve in quanto
in poche lettere si contiene ) seguirà presta-
mente la dolcezza , e il piacere .
Il comun sentimento de’ migliori Grama-
tici si è, che le parentesi non debbano esse-
re molto lunghe, nè troppo spesso adoperate ,
sicchè non sieno di noja a chi legge , o ascol-
ta , nè tolgano la chiarezza al discorso .
Quando l’interrompimento è molto breve,
si mette tra due virgole, lasciando i segni
della parentesi , come insegna il Salviati av-
vert. p. I. l. 3. cap. 4. partic. 23. Bocc. Fiamm.
c. 4. n. 25. Io opposi le forze mie, come Iddio
sa , quanto io potei .
La quarta è la sinchisi , cioè confusione
di costruzione nel periodo ; e la quinta si è
l’ anacoluthon , ed è quando si pone qualche
caso , per così dire, in aria , e senza filo
di costruzione. Di queste due figure non man-
cano esempj e ne’ Latini , e ne’ nostri Au-
tori , ma non si vogliono immitare, essendo
anzi
/ BEGIN PAGE 429 /
anzi errori , che no . Lasciò scritto un va-
lentuomo, queste figure essere pretesti inven-
tati da’ Gramatici per iscusare i falli , ne’
quali sono talvolta incorsi per umana fiac-
chezza anche i più celebri Autori .
DELLE PARTICELLE, E DEGLI AFFISSI.
LAsciando adunque star le suddette cose, per
compimento di quest’Opera parleremo del-
le particelle , e degli affissi , posciachè già gli
affissi appartengono, come vedremo, all’ iper-
bato , e vi possono appartenere anche le par-
ticelle spiccate, fecondo la loro varia col-
locazione. E tanto più, che avendo noi ad-
dotte al loro luogo le particelle, e accen-
nati ancora gli affissi, siccome cose di grand’
uso nella lingua Toscana , sarà utile, e pres-
sochè necessario il darne più piena notizia :
e tornerà bene il darla ordinatamente , e tut-
ta in una volta , perchè faccia maggiore, e
più distinta impressione .
Dodici adunque sono le particelle della
lingua Toscana , che il Varchi chiama pro-
nomi , perchè si usano co’ verbi in vece
de’ pronomi. Sei possono chiamarsi pronomi
primitivi, cioè mi, ti, si, ci, vi, ne, per-
chè , come a suo luogo abbiamo veduto,
si adoperano in forza di tali pronomi. Le
altre sei, cioè la, le, li, lo, il, le , che
sono voci degli articoli, si chiamano dal Var-
chi
/ BEGIN PAGE 430 /
chi pronomi relativi in questo senso, perchè
si riferiscono a cosa già nominata, e che
altri non vuol replicare. Così il Petrarca
canz. 4. 4. parlando di Madonna Laura , di-
ce : Poi la rividi in altro abito sola , Tal ch’ io
non la conobbi. Quel la si riferisce a M. Laura.
Nell’ accozzamento delle particelle primi-
tive colle relative ci ha molta diversità fra
l’ uso degli antichi, e quello , ch’ è più co-
mune fra’ moderni . Gli antichi, non già per
licenza , ma per uso costante del miglior se-
colo , ponevano i pronomi relativi innanzi
a’ primitivi , dicendo : io il vi dirò ; voi la
mi donerete ; il ti recherò , e simili, de’ quali
è superfluo addurre esempj , essendo cosa no-
tisima . I moderni soglion dire : Io ve lo di-
rò ; voi me la donerete , io te lo recherò &c.
Non so da qual delle due parti stia l’ iper-
bato , nè quale de’ due accozzamenti sia il
naturale . Non dee condennarsi l’ uso de’ mo-
derni , ma nè pur quello degli antichi è da
fuggirsi , del quale non pochi moderni , non
senza vaghezza , si servono.
Le suddette particelle si pongono sovente
alla fine de’ verbi , e ad essi si affiggono , e
allora si chiamano affissi , come abbiamo più
volte nel decorso dell’ Opera accennato .
Gli affissi altri sono scempj, altri doppj .
Gli scempj sono quelli, ne’ quali si affigge
al verbo una sola delle suddette particelle,
come
/ BEGIN PAGE 431 /
come amalo , prendila &c. I doppj son quelli,
ne’ quali si affiggono al verbo più particelle .
Così se vorremo rendere affissi gli accozza-
menti di particelle sopra addotti in esempio,
secondo gli antichi diremo così : dirollovi, do-
neretelami , recherolloti : e secondo i moderni
così : dirovvelo , doneretemela , recherottelo .
Ma intorno agli affissi è da osservarsi una
regola del Bembo l. 3. part. 27. cioè che
quando nel discorso ci è corrispondenza di
due, o più pronomi fra se, non si debbono
usare nè affisi, nè particelle, ma si hanno
a porre i veri pronomi , sicchè si rispondano.
Così il Petrar. son. 3. disse: Ferir me di saet-
ta in quello stato , E a voi armata non mo-
strar pur l’ arco . Se detto avesse ferirmi
avrebbe tolta la corrispondenza di me , e di
voi. E per la stessa ragione son. 201. disse:
Gli occhi, e la fronte con sembiante umano Ba-
ciolle sì , che rallegrò ciascuna , Me empiè
d’ invidia l’ atto dolce , e strano .
Si noti ancora , che talvolta 1’ affisso si
toglie dal suo verbo , e si pone innanzi a
un’ altro verbo , che non è suo , per pro-
prietà di lingua . Boccaccio g. 3. n. 3. Io gli
credo per sì fatta maniera riscaldare gli orec-
chi , ch’ egli più briga non ti darà. E g. 10.
n. 7. Se voi diceste , ch’ io dimorassi nel fuo-
co , credendovi io piacere, mi sarebbe diletto .
Rimane il dir qualche cosa di due affissi
pro-
/ BEGIN PAGE 432 /
pronominali , che ha la lingua Toscana , e
che possono usarsi di per se, e anche affig-
gerli a’ verbi , e sono gliele, e gliene .
Gliele composto di gli , e di le , frappo-
stovi per miglior suono l’ e, sempre indecli-
nabile, significa il dativo, e l’accusativo sin-
gulare, e l’ accusativo plurale in amendue i
generi. Bocc. g. 3. n. 3. Piena di stizza gliele
tolsi di mano , ed holla recata a voi, accioc-
chè voi gliele rendiate . E g. 2. n. 9. Portò
certi falconi pellegrini al Soldano , e presen-
togliele .
Gliene composto di gli , e di ne , per mi-
glior suono frappostavi l’ e, ha la forza, e
quasi lo stesso significato di gliele . Nov. ant.
59. Giunto Ipocras , trovando la madre morta,
gliene dolse duramente . Bocc. g. 3. n. 3. Io
per me non intendo di più comportargliene ,
anzi ne gli ho io bene per amor di voi sofferte
troppe . E g. 2. n. 6. Amenduni gli fece pigliare
a tre suoi servidori , e ad uno suo castello le-
gati menargliene .
Per ultimo non è da tralasciarsi una osser-
vazione del Cardinal Nerli il vecchio intorno
all’ uso degli affissi portata dal Salvini Pros.
Tosc. p. I. f. 186., ed è, che il verbo coll’
affisso si ponga , o cominciando il periodo,
o pure dopo la particella copulativa, quan-
do è andato innanzi altro verbo senza l’ af-
fisso . Del porre l’ affisso al principio del
perio-
/ BEGIN PAGE 433 /
periodo, non mancano esempj ben noti, e in
copia . Circa gli affissi per entro il periodo,
l’ osservazione si riduce a questo punto , che
quando vi sono due verbi corredati di parti-
celle, uno dietro l’altro, torna meglio , e
rende miglior suono , lasciare il primo verbo
sciolto , e del secondo fare affisso. Adduce il
Salvini l’ esempio del Boccaccio g. 6. n. 4.
Avendo una gru ammazzata , la mandò ad un
suo buon cuoco , e sì gli mandò , dicendo , che
a cena l’ arrostisse, e governassela bene . Si
osservi che il fare affisso solamente il primo
verbo non renderebbe buon suono: che a cena
arrostissela, e la governasse bene : e nè pur
tornerebbe bene il fargli amendue affissi : che
a cena arrostissela, e governassela bene. E mi
sovviene di un’ altro esempio del Boccaccio,
che conferma questa osservazione , ed è g. 2.
n. 10. Di dì, e di notte ci si lavora, e bat-
tecisi la lana. Sicchè e per questo, e per
altri modi, che cadono per mano nel com-
porre , è bene consultare , e l’orecchio, e la
pratica de’ valenti maestri.
Fine del secondo Libro .
Ee RE-
/ BEGIN PAGE 434 /
REGOLE
ED OSSERVAZIONI
Della Lingua Toscana .
LIBRO TERZO
Della maniera di pronunziare , e di
scriver toscano .
CAP. I.
Del valore , e della pronunzia delle lettere .
LE vocali si pronunziano come quelle dell’
Alfabeto Latino , salvo che l’ E , e l’ O ,
presso a’ Toscani, hanno ciascuna due diversi
suoni , l’ uno largo , ed aperto , l’ altro stret-
to, e chiuso . L’ E aperto si sente in mensa ,
remo , lo stretto in rese , cena ; l’ O aperto in
botta , il chiuso in botte .
Circa le consonanti , avendo noi maggior
copia di elementi , che di lettere , di una me-
desima consonante , o della stessa unione di
due consonanti siamo costretti a servirci per
rilevare più suoni .
Il C l’ adoperiamo per due sorte di suoni :
perchè posto innanzi alle vocali A O V ha il
suo-
/ BEGIN PAGE 435 /
suono aspro, e spiccato, come in capo , con-
ca , cura : e avanti alle vocali E , o I ha il
suono lene, o impaniato , come in cera, ci-
bo . E quando occorre di far fare quest’ ulti-
mo suono al C avanti ad A O V , vi si frap-
pone un I , che ne raddolcisca l’ asprezza ,
come in ciascuno , ciotto , ciuffo. E per fare,
che il C abbia il suono aspro avanti E I , vi
si frappone l’ H , come in, cheto , trabocchi .
Or questo CH posto innanzi all’ I può ave-
re due sorte di suoni, l’ uno rotondo, come
in fianchi , stecchi, fiocchi ; l’altro schiaccia-
to, come occhi, orecchi, chiave . Quattro re-
gole dà il Buommattei per conoscere , quan-
do il Chi presso a’ Toscani si pronunzj ro-
tondo , e quando schiacciato. La prima si è,
che il pronome chi, con tutti i suoi compo-
sti ; chiunque , chicchesia &c. è schiacciato. La
seconda , che le voci , le quali cominciano
dalla sillaba chi , sono , anche ne’ composti,
schiacciate , come chiamare , richiamo , chi-
nare , inchinare . La terza, che le voci, le
quali nel singulare finiscono in chi con dit-
tongo , sono in ambedue i numeri di suono
schiacciato , come vecchio , vecchi : purchè
però non abbiano la S innanzi al dittongo ,
perchè in tal caso si pronunziano rotonde ,
come maschio, maschj . La quarta , che quelle
voci , It quali nel numero del meno non
hanno in fine il dittongo, e nel numero del
E e 2 più
/ BEGIN PAGE 436 /
più finiscono in chi , si pronunziano roton-
de , come Monarca , Monarchi .
La G ha parimente due suoni ; l’ uno ro-
tondo avanti A O V , come in gallo, gota , gu-
sto ; l’ altro dolce avanti E I, come in gente ,
giro . E per diffalta di proprio carattere ,
quando vogliamo, che la G abbia suono
dolce avanti A O V , le pogniamo dopo un’
I , come in giallo , giogo , giusto : siccome
quando ha ad aver suono rotondo avanti ,
E I , le aggiugniamo l’ H, come in gherone,
ghiro .
Due suoni similmente ha il G H , se dopo
ne siegue l’ I ; l’ uno rotondo , schiacciato
l’ altro . Il Buommattei assegna sopra ciò due
regole . La prima si è , che quando il ghi è in
principio di parola con dittongo , ha suono
schiacciato, e il ritiene ancor ne’ composti ,
come ghiado, agghiadare : e se è senza dit-
tongo ha il suono rotondo , anche ne’ compo-
sti, come ghigno, sogghignare . La seconda ,
che le voci, le quali terminano in ghi con
dittongo, si pronunziano schiacciate in ambe-
due i numeri, come vegghia , vegghie : e
quelle, che nel numero del meno finiscono
senza dittongo , e nel numero del più ter-
minano in ghi, hanno suono rotondo ; così
intrigo ha nel numero del più intrighi di ro-
tonda pronunzia .
GLI ha parimente due suoni, l’uno duro,
l’ al-
/ BEGIN PAGE 437 /
l’ altro molle. Due regole sopra ciò stabi-
lisce il Buommattei . La prima che i prono-
mi egli , eglino , quegli , e il pronome, e
articolo gli, e da se solo , e ancor quando
è affisso, come dagli , agli, concedegli , sono
di molle pronunzia. La seconda , che gli con
dittongo ha suono molle, anche nel plurale,
o in persona diversa di verbo , come vaglio,
vagli, voglio, vogli. Fuori di questi casi gli
ha duro suono, come in Angli, negligenza,
e simile a quello , che ha gl avanti le altre
vocali, come in gladiatore, negletto , glorio-
so. E qui è da notarsi l’ errore di coloro, i
quali scrivono l’ articolo gli apostrofato avan-
ti le parole , che cominciano da vocale di-
versa dall’ I, gl’ amori, gl’ abusi &c., doven-
dosi scrivere disteso, gli amori, gli abusi, al-
trimenti si dovrebbe pronunziar duramente ,
dicendo : glamori , glabusi &c.
GN non ha presso di noi quel duro suo-
no , che usano gli Oltramontani nelle voci
Latine magnus , dignus , dicendo quasi macnus ,
dicnus , ma solamente ha quel molle suono ,
che in Italia si usa, come in degno , compagno.
L’ H presso i Latini serviva per aspirazio-
ne , cioè per ringagliardire la pronunzia : on-
de per esempio le voci habeo , homo essi le
pronunziavano con forza, e con ispignimen-
to di fiato : ma noi, non avendo simili pro-
nunzie aspirate , non ci serviamo del’ H a
E e 3 quest’
/ BEGIN PAGE 438 /
quest’ uso . Due usi però ha presso di noi l’ H ;
l’ uno di mezza lettera, quando la pogniamo
dopo il C , o ’l G per rilevare il suono ro-
tondo ; l’ altro di carattere distintivo di alcu-
ne parole, e per tor via qualche equivoco .
Così secondo il costume comunemente rice-
vuto , e approvato dall’ Accademia della Cru-
sca , si pone l’ H innanzi alle seguenti quat-
tro voci del verbo sustantivo, e scrivesi : ho
per distinzione da o particella separativa , o
avverbiale ; hai per toglier l’ equivoco con
ai articolo affisso al segno del terzo caso ;
ha per distinguere da a preposizione : e han-
no, perchè col nome anno scambiar non si
possa . Nelle altre parole, siccome l’ H nulla
opera , così inutilmente si scrive .
La S ha due suoni ; il primo più gagliar-
do , come in casa , asse , spirito ; l’ altro più
rimesso, come in rosa, sposa, accusa, sden-
tato , svenato .
La Z ha due principali suoni , uno gagliar-
do , come in prezzo , carezze , zana , zio ;
l’ altro alquanto rimesso , come in vezzo , or-
zo , zanzara , zelo . Se la Z è tra due voca-
li , delle quali la seconda non sia I con dit-
tongo, ha suono molto gagliardo , come in
pazzo , carrozza, ammazzare : che se la se-
conda vocale è I con dittongo, la Z si scri-
ve scempia , perchè ha men gagliardo suono,
come in vizio, letizia, equinozio. Il servirsi
poi
/ BEGIN PAGE 439 /
poi in quest’ ultimo caso del T in vece della
Z , scrivendo per esempio oratione, è ito me-
ritamente in disuso .
CAP. II.
Dell’ Accento, e dell’ Apostrofo.
L’Accento comunemente preso è una po-
sa, che fa la voce sopra una sillaba , mag-
giore di quella, ch’ ella fa nelle altre .
Due sono gli accenti, il grave, e l’acuto.
Il grave è quello, che si fa sopra l’ ultima
sillaba , e segnasi con una lineetta trasversale
dalla sinistra alla destra di chi scrive, come
in andò , aprì , e simili . L’ accento acuto è
quello, che si fa sopra le altre sillabe, e se-
gnasi con una lineetta trasversale all’ oppo-
sto del grave, come in gía , balía , e altri sì
fatti . Il segno dell’ accento grave si mette
sempre ; ma quello dell’ acuto non si suol
mettere, e si lascia alla discrezione di chi
legge il far la posa dov’ ella va : se non se
in caso, che potesse nascere equivoco , per-
chè allora si pone l’ accento, come per esem-
pio nel nome frequentativo stropiccío, che po-
trebbe prendersi per lo verbo stropiccio ; e ne-
gli esempli di sopra gía, balía, che scam-
biar si potrebbono da già , balia, e in altri
molti casi , che non di rado occorrono .
E e 4 I mo-
/ BEGIN PAGE 440 /
I monogrammi , come a, e, i, o non vo-
gliono segni sopra capo, non potendosi far
in essi se non una sola posa : si eccettua
nondimeno è terza persona singolare del di-
mostrativo del verbo essere , la quale, se
non vi si ponesse l’ accento , potrebbe pren-
dersi per e congiunzione.
I monosillabi, che non hanno dittongo,
come Re , fe , su , sta , qui , e gli altri , non
si segnano con accento, perchè dicono il
medesimo a esservi, o non esservi. Si segnano
contuttociò per necessità di distinzione i se-
guenti monosillabi, cioè dì nome per differen-
za da di particella : dà terza persona singo-
lare del verbo dare , per non confonderla
con da segno dell’ ultimo caso ; sì, e là av-
verbj, per non iscambiarli con si potenza di
verbo, e con da articolo ; nè particella nega-
tiva, per distinguerla da ne particella riem-
pitiva , o avverbiale ; lì avverbio di luogo,
per riconoscerlo da li articolo, o pronome ;
e altri, se pur ve ne sono.
Que’ monosillabi , che hanno dittongo , si
voglion segnar coll’ accento , perchè altri-
menti potrebbono pronunziarsi col dittongo
sciolto: e perciò scrivesi : già , ciò, può , piè ,
e simili .
I Dittonghi altri si tolgono, quando vie-
ne il caso di portare più oltre l’ accento, e
chiamansi dittonghi mobili, e si tolgono per
non
/ BEGIN PAGE 441 /
non far la posa in due luoghi . Così di fuoco
si forma infocato ; da tuono tonare, e tonerà ;
e così discorrendo . Altri non si tolgono, ben-
chè vada oltre l’ accento, e si chiamano fer-
mi. Così piego fa piegare , piegherò ; piano fa
pianissimo ; pieno pienissimo ; piovere pioverà ;
fiato fiatare ; fiero fierezza ; mietere mietito-
re ; pietà pietoso ; lieto lietissimo , ma non lie-
tizia , e simili .
Passando all’ apostrofo , diremo essere un
contrassegno di mancamento di lettera , quan-
do per isfuggire alcun tristo suono, o per
maggiore speditezza togliesi una vocale, talo-
ra colle sue consonanti, dal fine di una pa-
rola , nel qual caso si scrive accanto all’ ul-
tima lettera , che rimane , un piccolo c vol-
to a ritroso, come in questi esemplj : l’ arte
per la arte ; que’ Signori per quelli Signori.
CAP. III.
Delle stroncature delle sillabe .
QUando una voce non capisce tutta inte-
ra nel verso , conviene stroncarla , e
portare il restante al capoverso , che
siegue ; e perciò è d’ uopo dividere la voce
fra sillaba, e sillaba : e conviene perciò ben
conoscere a qual sillaba appartenga qualun-
que consonante, per non metterla fuor di suo
luogo, e dove punto non rilevi .
Tre
/ BEGIN PAGE 442 /
Tre regole si possono assegnare per tali
stroncamenti, cavate dal Salvini Disc. Acad.
tom. 3. disc. 31.
Regola prima . Niuna sillaba dee comin-
ciarsi da due medesime consonanti , come da
due ss, da due ll, da due mm, e va discor-
rendo , perchè non rilevano , e la prima di
esse appartiene alla sillaba antecedente. Così
la voce asse non si compita a-sse, ma as-se.
Regola seconda . Non dee cominciarsi la
sillaba da due consonanti diverse , che non
rilevino ; così la voce mente non si compita
me-nte , perchè nt non rilevano, ma men-te .
Che se delle due consonanti la seconda sarà
liquida, ovvero la prima sarà S , ch’ è let-
tera assai vivace, potrà la sillaba cominciare
da due, e nel secondo caso anche da tre con-
sonanti, e rilevare ottimamente, come si ve-
de nella voce infrascritto, la quale si com-
pita così : in-fra-scritto, e nelle voci degno ,
figlio , che si compitano : de-gno , fi-glio .
Regola terza . Quando una sillaba è già
da se perfettamente scolpita , e ad essa sie-
gue una consonante , e una vocale , questa
consonante rileva colla seguente vocale , so-
pra cui vibra, e non appartiene alla sillaba
antecedente . Così la voce mora non si com-
pita mor-a, ma mo-ra , perchè la sillaba mo
è da se dintornata, e finita, e quell’ r appar-
tiene all’a, sopra cui getta la sua vibrazione .
Per
/ BEGIN PAGE 443 /
Per ultimo avverte il Salvini, che sareb-
be bene lo sfuggire di finire il verso con vo-
ce apostrofata , come sarebbe per esempio ,
se si scrivesse dell’ amore , facendo dell’ in un
verso, e amore nell’ altro .
CAP. IV.
Dello accrescimento delle parole.
NElla Lingua Toscana sovente si accre-
scono le parole in principio, o in fine,
o per togliere l’ asprezza , che nasce dall’ in-
contro di alcune consonanti, o per empiere
l’ iato, che risulta dal concorso delle vocali.
Eccone le regole più necessarie .
Regola prima .
Quando la parola finisce in consonante, e
quella , che le viene appresso, cominci da S,
a cui seguiti un’ altra consonante , si accre-
sce la seconda parola in principio d’ un I, e
talvolta d’ un’ E, per raddolcir la pronunzia .
Boccaccio . Voi mi avete colto in iscambio =
Niuna cosa in casa sua durar poteva in ista-
to = Per non ismarrirle , o scambiarle , fece
lor fare un certo segnaluzzo = Di scoglio in
iscoglio andand o, marine conche con un coltello
dalle pietre spiccando , s’ avvenne in un luogo
fra gli scogli riposto = Le forze della penna
sono troppo maggiori , che coloro non estima-
no ,
/ BEGIN PAGE 444 /
no , che quelle con conoscimento provato non
hanno .
Eccezione.
I Poeti non di rado trascurano questa re-
gola . Petrar. Ricorditi che fece il peccar no-
stro Prender Dio , per scamparne, Umana carne
al tuo virginal chiostro . Dante: Perch’ io m’ a-
diri, Non sbigottir , ch’ i’ vincerò la pruova.
Regola seconda .
Le particelle A E O innanzi a parola , che
cominci da vocale , si sogliono talvolta ac-
crescere di un D ; e le particelle su , e in su
in simil caso si accrescono di una R . Bocc.
Vi cominciarono le genti ad andare , e ad ac-
cender lumi, e ad adorarlo = Ed ivi presso
correva un fiumicel di vernaccia = Senza far
motto ad amico, od a parente, fuorchè ad un
suo compagno , il quale ogni cosa sapea, andò
via = Tesorett. Brun. Trovai uno scolajo Sur
un muletto bajo . Segni Stor. Radunare ogni
mese la banda del suo quartiere in sur una
piazza . Abbiamo ancora presso gli Antichi :
benched ella , ched egli, sed egli è troppo, ned
altro ; ma oggi non sono in uso.
Regola terza .
I Poeti accrescono talora le voci, che han-
no l’ accento in sull’ ultima , di un’ E , o di
un’ O , per far più sonoro il verso . Dante :
In che si vede , Come nostra natura a Dio s’ u-
nio = Ed ecco più andar mi tolse un rio, Che ’n
ver
/ BEGIN PAGE 445 /
ver sinistra con sue picciole onde Piegava l’ er-
ba, che ’n sua ripa uscío = Voi vigilate nell’
eterno díe = Petrarca : Come fior colto langue ,
Lieta si dipartìo, non che secura = Che quasi
un bel sereno a mezzo ’l díe Fer le tenebre mie.
CAP. V.
Quando le parole si possano scemare
in principio .
SOgliono scemarsi non di rado le parole in
principio, ma con le seguenti regole .
Regola prima .
In principio si scemano le sole parole, che
cominciano per I seguito da una di queste tre
liquide L M N . Bocc. g. I. n. 5. Chi ’l saprà ?
egli nol saprà persona mai = e Amet. Se me-
desimo mira , quasi dubbio tra ’l sì, e ’l no di
acquistarla = E g. 2. n. 9. Il domandò , se lo
’mperadore gli avea questo privilegio più , che
a tutti gli altri uomini conceduto = Trasorier
di Madama la ’mperadrice di Costantinopoli =
Gli spiccò dallo ’mbusto la testa = Lo ’ngan-
natore rimane a’ piè dello ’ngannato = Le pa-
role adunque , che da altre vocali comincia-
no , o che dopo la prima vocale hanno altre
consonanti , non si accorciano , nè si dice per
esempio : lo ’more per l’ amore ; o patto ’norato
per patt’onorato ; o la ’dolatria per l’ idolatria.
Re-
/ BEGIN PAGE 446 /
Regola seconda .
Perchè possa farsi tale accorciamento , la
liquida seguente all’ I dee avere dopo di se
una consonante diversa ; onde se avesse una
vocale , o pur una consonante simile a se ,
non potrebbe farsi l’ accorciamento . Si noti
l’ osservazione di questa regola negli esem-
pli della regola precedente . Non può adun-
que dirsi : la ’liade per l’ iliade ; la ’mitazione
per l’ imitazione ; fu ’nabile per fu inabile:
lo ’lluminato , lo ’mmortale , molto ’nnanzi per
l’ illuminato , l’ immortale , molto innanzi .
Eccezione .
Le parole innamorato , innamorare negli Au-
tori del buon secolo si trovano talvolta tron-
cate . Dante : Ma nostra vita senza mezzo spi-
ra , La somma beninanza, e la ’nnamora = E
parimente la voce innalzare . Dante : Poiché
’nnalzai un poco piu le ciglia, Vidi ’l maestro
di color , che sanno .
Regola terza .
Le parole, che hanno l’ accento, o posa
in sulla prima sillaba , non si troncano, nè si
dice per esempio : lo ’mpeto per l’ impeto ; la
’nclita per l’ inclita .
Regola quarta .
Quando la parola antecedente finisce in
consonante, la susseguente, benchè abbia i
requisiti delle regole precedenti, non si tron-
ca, nè si dice, per cagion d’ esempio : per
’ mpe-
/ BEGIN PAGE 447 /
’mperio , in ’ngegno in luogo di per imperio,
in ingegno .
CAP. VI.
In quanti modi poßano le parole scemarsi
in fine .
LE parole della Lingua Toscana finiscono
tutte in vocale, da alcuni pochi mono-
sillabi in fuori : con, in, non, per, ed. Quin-
di è , che sovente , o per togliere alcuna
asprezza di suono, o per rendere più conca-
tenata, e robusta l’ orazione, si troncano le
parole in fine, e segnansi di apostrofo, che
ne dinoti il troncamento . Ma ciò si vuol fare
con grande avvertenza, osservando le seguen-
ti regole .
Regola prima .
Le parole ultime de’ periodi, de’ membri,
e degl’ incisi non si troncano, perchè la voce
in esse alcun poco si trattiene, non potendosi
in su una parola tronca fare agevolmente la
posa .
Eccezione .
I Poeti moderni, e fra questi il Chiabrera ,
con molta vaghezza finiscono talvolta i loro
versi con parole tronche , come : amor, dolor ,
timor, e simili. Chiabr. tom. 2. canz. 34. Mi-
sera vergine ? Sue membra nobili Belva diven-
nero : Ah gran dolor !
Re-
/ BEGIN PAGE 448 /
Regola seconda.
Le parole, che hanno l’ accento in sull’ ul-
tima, non si troncano , nè si dice per esem-
pio : and’ in villa per andò in villa, ovvero
far’ bene per farò bene . Più tosto si farà il
troncamento della prima vocale della parola
seguente , dicendo : andò ’n villa, nel qual
caso la vocale ultima della prima parola
avrà due segni, cioè l’ accento grave, e l’a-
postrofo .
Eccezione .
La parola che con tutti i suoi composti ,
benchè, perchè, e le altre, benchè abbiano
l’accento grave, pure sogliono talvolta tron-
carsi . Bocc. Pregandolo, che se per la salute
di Aldobrandino era venuto, ch’ egli s’ avac-
ciaße = g. 8. n. 4. Bench’ ella fosse contraffatta
della persona , ella era pure alquanto malizio-
setta = Petrarca : Qui son secura , e vovi dir
perch’ io Non , come soglio , il folgorar pa-
vento .
Regola terza .
Le parole, che hanno il dittongo nell’ ul-
tima , come cambio, doppie, empio , nebbia ,
graffio &c. non si troncano.
Eccezione .
Alcune parole, che finiscono col dittongo
io , a cui preceda una N , sogliono da To-
scani troncarsi , dicendo , e scrivendo : An-
ton Maria, Anton Francesco ; Demon per de-
mo-
/ BEGIN PAGE 449 /
monio ; e ancora testimon per testimonio, di-
ce il Buommattei, ma l’ esempio di testimon
del Petrarca, che egli adduce, può essere ac-
corciato da testimone , voce spesso adoperata
dagli Autori del buon secolo, onde non ap-
partiene di certo a questa eccezione .
Regola quarta .
Le parole, che finiscono in A innanzi a vo-
cale si possono troncare, dicendo per esem-
piò rob’ unta, all’ erba, sopr’ atto, e simili :
ma innanzi a consonante non si troncano ,
singolarmente se finiscono in Ra ; nè si dice :
alcun’ gente per alcuna gente ; nè una sol vol-
ta, che pur odesi tuttodì , ma una sola vol-
ta, nè fier’ novella per fiera novella. E' ve-
ro che si sente da’ Toscani talvolta : fuor di
Casa, fuor che noi &c. , ma nota il Buom-
mattei, che in buona lingua trovasi più spesso
fuori che fuora, e perciò dell’ I, non dell’ A
viene ad essere tale accorciamento .
Eccezione prima .
L’ avverbio ora, con tutti i suoi composti,
o simili , si può innanzi a consonante troncare
dell’ultima vocale . Bocc. Or bene , come fare-
mo ? = Petrarca : Allor che fulminato , e morto
giacque Il mio sperar = Talor sua dolce vista
rasserena = Bocc. g. I. n. 2. Sono più tanto an-
cor migliori, quanto essi son più vicini al pa-
stor principale.
Ff Ecce-
/ BEGIN PAGE 450 /
Eccezione seconda .
Il nome di Suora , benchè , quando sta per
sustantivo, non possa troncarsi, quando però
sta per aggiuntivo, si può troncare, e in-
nanzi a vocale , e innanzi a consonante .
Passav. Non intendo , disse la Suora, se più spe-
cificatamente non parlate. Firenzuola Nov. 5.:
Vide correre Suor Appellagia alla sua cella =
Regola quinta .
Le parole, che finiscono in e non accen-
tuata , possono innanzi a vocale troncarsi :
Bocc. Non era sì poco , che oltr’ a dieci mila
dobbre non valesse = Petrar. Qua’ sono stati gli
anni , e i giorni , e l’ ore = Bocc. Io mi cre-
do, che noi n’ avremmo buon servigio = Dan-
te : S’ io dissi falso, e tu falsasti il conio .
Eccezione prima .
Quando l’ultimo e della parola ha avanti
di se il C , o il G , non si toglie, se non se
in caso, che la seguente parola cominci pa-
rimente da e. Per esempio non può dirsi lanc’
antiche per lance antiche , altrimenti dovreb-
be pronunziarsi aspramente , come se fosse
scritto lancantiche . Bocc. Teseid. Fra Gelia ,
e Nisa nelle piagge amene = Petrar. Dolce
mal, dolce affanno, e dolce peso.
Eccezione seconda .
Le voci dell’ infinito non sogliono innanzi
a vocale troncarsi , nè si costuma dire : cer-
car’ altrui, legger’ alto, super’ aßai, fuggir’ in-
sieme
/ BEGIN PAGE 451 /
sieme &c. E negli Autori del buon secolo rade
volte s’ incontrano simili troncature .
Regola sesta .
Innanzi a consonante possono troncarsi le
parole , che finiscono in e senz’ accento ; pur-
chè l’ultima consonante , che rimane , tolto
via l’ e , sia una di queste liquide L N R . Bocc.
Datole mangiare pan lavato = Buonarroti :
Non ci bisogna su, nè sal , nè olio = Petrar.
E che ’l mobile ingegno, che dal Cielo Per gra-
zia tien dell’ immortale Apollo = Passav. At-
tenda il confessore di tener segrete , e celate
le cose, ch’ egli ode in confessione = Bocc. Co-
mare egli non si vuol dire = Teseid. Ma non
gli parve via ben ben sicura = Presala for-
te , la cominciò a portar via = Quello , ch’
egli avea risposto , non veniva a dir nulla =
Dante : Onde si muovono a diversi porti Per lo
gran mar dell’ essere = Quand’ io conobbi quel-
la ripa intorno &c. Esser di marmo. Bocc. Se
vi cal di me, venite meco infino a palagio.
Eccezione prima .
Quando la seconda parola comincia da S ,
a cui sieguano una , o due altre consonanti ,
non si toglie l’ E dal fine della prima paro-
la . Bocc. Essendo una mattina il marito di lei
cavalcato in alcun luogo per dovere stare al-
cun giorno = Ovid. Pist. Questa tua faccia non
lasciare sfiorire . I Poeti contuttociò si pren-
dono talvolta la licenza di fare simili tron-
F f 2 ca-
/ BEGIN PAGE 452 /
camenti. Petrar. citato dal Buom. Più ch’ al-
tra, che ’l sol scalde, o che ’l mar bagne .
Eccezione seconda .
I plurali de’ nomi, che finiscono in E non
si troncano , nè si dice per esempio : pen’
gravi, cantin’ fresche per pene gravi , canti-
ne fresche .
Eccezione terza .
L’ avverbio come , e la voce nome innanzi
a consonante non si troncano , per isfuggire
l’ asprezza . Pure il troncò alcuna volta , per
licenza, il Petrarca ; benchè non senza du-
rezza: O nostra vita, ch’ è sì bella in vista,
Com’ perde agevolmente in un mattino Quel ,
che ’n molti anni a gran pena s’ acquista .
Regola settima .
Le parole, che finiscono in I , si possono
non di rado della stessa lettera troncare , e
innanzi a vocale , e innanzi a consonante .
Bocc. Attento a riguardare le pitture , e gl’
intagli del tabernacolo = Si cominciarono ad
avere in odio fuor di modo .
Eccezione prima .
La parola ogni, per sentimento de’ miglio-
ri, non ammette troncamento , nè si dice :
ogn’ altro , ogn’ uno , ogn’ erba , ma ogni al-
tro , ogni uno , ogni erba , e simili ; quando
però non si facesse di due parole una, come
ognaltro , ognuno .
Ecce-
/ BEGIN PAGE 453 /
Eccezione seconda .
Gli innanzi a vocale, che non sia I , si scri-
ve intero , perchè se si scrivesse per esem-
pio : gl’ amori, gl’ eredi , gl’ occhi, gl’ uficj ,
gli perderebbe il suono suo schiacciato .
Eccezione terza .
I plurali de’ nomi , che finiscono in Li ,
come pali , veli &c., è quelli, che finiscono
in Ni, come immagini , cammini &c., non si
troncano. Quindi è , che nel Decamerone
sempre si vede, per cagion d’esempio : gen-
tili uomini , valenti uomini &c. E‵ vero che
nel Petrarca si trova : E ’n poca piazza fe
mirabil cose = e nell’Ariosto : Seguendo l’ ire,
e i giovenil furori ; ma sono licenze poetiche .
Eccezione quarta .
Le parole, che finiscono in Ci , e in Gi in-
nanzi a vocale, che non sia I , non si tronca-
no , altrimenti non farebbero quel suono im-
paniato , che debbono fare . E così non si dice :
dolc’ amplessi , preg’ onorati , ma dolci amplessi,
pregj onorati. E può dirsi dolc’ imenei, preg’
illustri &c.
Regola ottava.
Le parole, che finiscono in O , si possono
innanzi a vocale troncare, onde si dice per
esempio buon’ uomo , tropp’ eminente , quant’
ogni altro &c.
Eccezione .
Innanzi A costumano i migliori di scri-
F f 3 verle
/ BEGIN PAGE 454 /
verle intere, onde nel Boccaccio si trova spes-
so : lo Abate , uno anno , uno animale &c.
Regola nona .
Innanzi a consonante si troncano dell’ ul-
tima vocale molte parole finienti in Lo, Mo,
No , Ro , So . Petrar. La sera desiare , odiar
l’ aurora Soglion questi tranquilli , e lieti aman-
ti = Bocc. Elle si vorrebbon vive vive met-
ter nel fuoco = Dante : Andiam, che la via
lunga ne sospigne = Bocc. Dovendo a man de-
stra tenere = Dant. Lo Ciel poss’ io serrare ,
Come tu sai = Petrar. Qual mi fec’ io , quan-
do primier m’ accorsi Della trasfigurata mia
persona . = Bocc. Io trovai l’ uom tuo , che an-
dava a Città = Questo farò io volentieri, sol
che voi promettiate &c.
Eccezione prima .
Le prime persone singulari degl’ indicativi
presenti, che finiscono in O, ed hanno 1’ ac-
cento sulla penultima , come consolo, ragio-
no, amo , chero , confesso, e simili non si tron-
cano , e perciò fu criticato nel Tasso quel
famoso verso : Amico hai vinto , io ti perdon ,
perdona. La prima persona contuttociò del
verbo essere , cioè sono , ha il privilegio di
poter essere accorciata. Bocc. g. 8. n. 9. E
oltre a ciò son Dottore di medicine . Petrar.
son. 261. I’ son colei, che ti diè tanta guerra .
Eccezione seconda .
Le voci pessimo , nero , riparo, velo, e simili
non
/ BEGIN PAGE 455 /
non si trovano presso a’ buoni Autori troncate .
Regola decima .
Le parole, che finiscono in O , innanzi a
cui sieno due L , o due O , e l’ accento sia nella
penultima, la di cui vocale non sia I , nè O ,
si trovano spesso troncate dell’ ultima voca-
le , e di una delle consonanti . Petrar. Padre
m’ era in onore , in amor figlio , Fratel negli
anni = Questi fu quel , che ti rivolse , e strinse
Spesso come caval fren, che vaneggia = Bocc.
Bel giovane, e grande della persona = Dante
Inf. cant. I. Vagliami il lungo studio , e ’l gran-
de amore , Che m’ han fatto cercar lo tuo volu-
me . E così fanno, danno, andranno, e simili
voci di verbi si troncano , in particolare da’
Poeti .
Ma per contrario palla , sella , collo , spillo,
e simili non si troncano , o perchè non fini-
scono in O , ovvero perchè la penultima vo-
cale è I , ovvero O . Contuttociò nelle pa-
role composte , le quali così terminano per
conto dell’ affisso, si ammette il troncamento .
Dante ( presso il Buomm. ) E udil nominar Geri
del Bello = Bocc. Provi il peso della sollecitu-
dine insieme col piacere della maggioranza .
Eccezione prima .
Le voci corallo , cristallo , ballo , fallo , snello
dice il Buomm. se non aver mai viste tronche .
Eccezione seconda .
La voce Santo, benchè le sue ultime con-
F f 4 so-
/ BEGIN PAGE 456 /
sonanti sieno diverse, siccome innanzi a vo-
cale si tronca dell’ ultima vocale, così innan-
zi a consonante si tronca dell’ ultima sillaba ,
purchè stia per aggiuntivo, e stia innanzi im-
mediatamente al suo sustantivo, e questo sia
nome proprio : ma se stesse per sustantivo, o
stelle bensì per aggiuntivo, ma non già in-
nanzi al suo sustantivo, o questo fosse nome
appellativo, non si tronca. Bocc. Venutosene
per lo corso degli Adimari infino a San Gio-
vanni = Salvin. Pros. Tosc. p. I. pag. 2. Uno
antichissimo nostro Vescovo, e Cittadino, Zeno-
bio il Santo . Bocc. g. 3. n. 4. Tutto ’l tuo de-
siderio è di divenir Santo = Vit. SS. Pad. Il
suo Padre , e Maestro Sant’ Antonio = Bocc.
Andiam noi con esso lui a Roma ad impetrare
dal Santo Padre &c.
Eccezione terza .
La voce grande innanzi a consonante perde
l’ ultima sillaba , quando parimente sta per
aggiuntivo, e precede immediatamente al suo
sustantivo, e non in altro caso. Bocc. Gli con-
venne fare gran mercato di ciò, che portato
aveva = Fu, oltre ad ogni altro , grande, e
presto verificatore = .
Eccezione quarta .
Similmente la voce Frate troncasi dell’ ul-
tima sillaba innanzi a consonante , purchè sia
aggiuntivo, e preceda immediatamente il suo
sustantivo , e non in altro caso. Bocc. Fra Puc-
cio
/ BEGIN PAGE 457 /
cio non andava mai fuor della terra = Si fece
Frate Minore, e fecesi chiamare Frate Alber-
to da Imola .
Appendice .
Ne’ Poeti toscani è scorso un’ uso, a imi-
tazione de’ Provenzali , di valutare per una
sola sillaba le due sillabe finali ajo, oja, ojo .
Dante Purg. cant. 14. Nello stato primajo non si
rinselva . Bocc. g. 6. canz. Onde ’l viver m’ è
noja , nè so morire . Dante Par. cant. 15. Non
era vinto ancora Monte malo Dal vostro Uccel-
latojo ; che com’ è vinto Nel montar su, così sa-
rà nel calo . Nel pronunziar tali versi , ( dice
il Salvini nelle note al Buomm. tr. 7. cap. 18. )
si toglie l’ ultima vocale , e si apostrofa la j ,
dicendo primaj’ , gioj’ , uccellatoj’ , e così il
verso va bene .
Regola undecima .
Meglio, voglio , mali , quali , mezzo, egli, per
un certo vezzo toscano, si troncano dell’ ul-
tima sillaba . Dante: Se’ savio, e intendi me’,
ch’ io non ragiono = Bocc. Ora non ti vo’ dir
più = Firenzuola Trinuz. Pian barbiere , adagio
a’ ma’ passi = Petrar. Dentro alle qua’ peregri-
nando alberga Un Signor valoroso = Bocc. E co-
sì andando s’ avvenne per me’ la cesta = Di-
rem noi , perciocchè e’ nuoce a’ febbricitanti,
ch’ e sia malvagio ? = Menati i gentiluomini
nel giardino, cortesemente gli domandò , chi e’
fossero .
Re-
/ BEGIN PAGE 458 /
Regola duodecima .
Fratelli, belli, alli, dalli, delli , nelli, pel-
li, colli perdono l’ ultima vocale con tutte le
consonanti precedenti. Allegri : Lo stare in
Corte , e l’ essere ammalato Mi pajon, come dir ,
frate’ carnali = Bocc. Egli assai di be’ costumi,
e di buone cose aveva apprese = Queste donne il
dissero a’ mariti = Ristrette da’ voleri, da’ pia-
ceri, da’ comandamenti de’ padri = La rigidez-
za delle matrigne ne’ figliastri non dico, perciocchè
è manifesta ogni giorno = Dove gli uomini , e le
femmine vanno in zoccoli su pe’ monti = Il non
saper tra le donne, e co’ valenti uomini favel-
lare = Alcuni usano di non apostrofare le
suddette voci, ma di aggiugnere sul fine un
I , dicendo: ai , dai , dei , nei , pei , coi, ma
gli Scrittori toscani più esatti scrivono sem-
pre , e pronunziano tali voci coll’apostrofo ,
come appare dalle opere del Salvini, e dal
Vocabolario medesimo della Crusca .
CAP. VII.
Delle parole composte .
Osservazione prima .
USano i Toscani, per meglio esprimere la
loro pronunzia , di unire insieme nella
scrittura due parole , formandone una sola pa-
rola . Or in questo non può darsi regola af-
fatto
/ BEGIN PAGE 459 /
fatto sicura , nè de’ ciascuno prendersi l’ arbi-
trio di fare simili composizioni , ma usar so-
lamente quelle , che sono ammesse , e poste
in uso . Scrivesi adunque : ognuno , gentiluo-
mo , sottovoce, sottomano , nondimeno, trentot-
to , nulladimeno , sottovoce, e simili.
Osservazione seconda .
Quando la prima delle voci componenti
finisce in vocale, e la seconda comincia da
consonante, sogliono spesse volte i Toscani
pronunziarle con maggior forza, e perciò
raddoppiano la prima consonante della se-
conda parola, scrivendo : dello , allo , collo ,
colassù, laggiù, appiè , accanto , addosso , amol-
lo , udillo , acciò, sopracciò, ognissanti, sopran-
nome, addietro, giammai, oltracciò , colaggiù ,
e altre sì fatte .
Le voci composte de’ monosillabi ri, e ra
sono diverse in questo , che la pronunzia è
più forte in ra che in ri, e perciò in quel-
lo , non in questo si fa il raddoppiamento, on-
de si dice per esempio : raddirizzare , e ri-
dirizzare .
Osservazione terza .
Talvolta la prima delle parole componenti
perde l’ultima vocale con tutte le consonan-
ti, e si raddoppia la prima consonante della
seconda parola, come in sotterra , soggolo ,
soppanno, sozzopra, e simili .
Os-
/ BEGIN PAGE 460 /
Osservazione quarta .
Negli affissi quando la parola ha l’ ultima
sillaba accentata , si raddoppia la consonante
della particella affissa , purchè ella non abbia
dopo di se altra consonante . Così si dice
dammi , dirotti , sallo , e simili : non già di-
roggli , perchè la particella ha doppia con-
sonante , onde si dice : dirogli . Ma se la pa-
rola , a cui s’affigge la particella , perde nell’
affisso l’ ultima vocale , la consonante della
particella non si raddoppia ; onde dirai, fa-
rai, e simili , nell’ affisso fanno dirálo , fará-
ne, e simili. Bocc. g. 4. n. I. Faráne questa
sera un soffione alla tua servente , col quale
ella raccenda il fuoco . Vedi il Bartoli nel
Torto, e diritto num. 32.
Oßervazione quinta .
In alcune parole per facilità di pronunzia,
si muta alcuna consonante, ponendo per ca-
gion d’ esempio avanti la b , ch’ è lettera la-
biale , in vece della n , la m , ch’ è lettera la-
biale: o pure avanti alla C in vece della M , si
pone la N per miglior suono , come in pam-
bollito, amianci, farenlo, e simili.
CAP.
/ BEGIN PAGE 461 /
CAP. VIII.
Delle lettere maggiori, e minori, e quali
sieno le regole del loro uso .
IL Cavalier Salviati Avvertim. I. p. lib. 3.
cap. 4. partic. 22. e 23. stabilisce le seguen-
ti regole intorno all’uso delle lettere majusco-
le, e delle minori, le quali sono dal miglior
uso ricevute .
Prima . Sopra le lettere majuscole non si
pone verun segno di accento, di titolo, o di
apostrofo, e così si è sempre praticato .
Seconda . I nomi proprj di qualunque per-
sona , o cosa particolare, i soprannomi, e i
cognomi vogliono la prima lettera majusco-
la, onde si scrive : Piero, Pampinea , Italia,
Primavera , Sabato , Bologna , Arno , Mate-
matica ; lo Stramba &c.
Terza . I nomi delle nazioni posti sustan-
tivamente voglion lettera majuscola , onde si
scrive per esempio : i Franzesi fecero guerra :
ma posti addiettivamente voglion lettera mi-
nore , e però li scrive : mercatante franzese .
Quarta . I generi , e le spezie espressi co-
me tali voglion majuscola , onde si dice :
l’ Uomo è la più nobile delle inferiori creatu-
re ; il Cavallo è utile alla guerra : ma non
già quando si addattano agli individui, onde
scri-
/ BEGIN PAGE 462 /
scrivesi : questi è un buono uomo : ecco un bel
cavallo .
Quinta . Gli appellattivi , che stanno in
vece de’ nomi proprj voglion la majuscola,
e così si scrive : il Padre , il Medico , il Mae-
stro &c. quando si parla di singular persona.
I pronomi contuttociò egli, ella, colui, co-
lei , costui , costei, e simili, benchè accenni-
no particular persona , non si scrivono con
lettera maggiore, perchè già di propria na-
tura stanno in vece de’ nomi proprj, e così
non hanno bisogno di tal contrassegno .
Sesta . Tutti i nomi delle dignità, de’ gra-
di, e degli onori voglion lettera maggiore,
e si scrive : Papa , Imperadore , Re , Vescovo
&c. e anche quando sono uniti co’ nomi pro-
prj, o a quelli della loro giurisdizione, on-
de si scrive : il Re Luigi , il Re di Francia &c.
Settima . Ne’ principj de’ periodi la prima
lettera è sempre majuscola .
CAP. IX.
De’ punti , e delle virgole.
I Punti sono stati inventati da' Gramatici
per contrassegnar le fermate, o sieno pau-
se del parlare , e sono cinque .
Il punto fermo, o sia finale, che si mette
alla fine del periodo, e dimostra, la senten-
za essere totalmente perfetta .
Il
/ BEGIN PAGE 463 /
Il mezzo punto , che dinota una pausa
mezzana, quale è fra un membro , e l’ altro
del periodo , e si fa con due punti uno so-
pra l’altro. E si suole adoperare ancora quand’
altri riferisce nel discorso le parole precise
dette da un’altro , mettendo innanzi a tali
parole due punti .
Il punto, e virgola, che dinota quella mi-
nima pausa , ch’ è fra le parti di un mem-
bro del periodo .
Il punto interrogativo, che dinota interro-
gazione così ? , e il punto ammirativo , che
dinota ammirazione così !
La virgola si usa per dinotare l’ interrom-
pimento piccolo del discorso , e dee porsi
qualunque volta il discorso non è perfetta-
mente continuato , ma contiene qualche mo-
vimento , o passaggio, quantunque piccolo .
Ma veggiamo l’ esempio del mezzo punto,
e del punto, e virgola ; non già di scrittore
antico del buon secolo , perchè allora non
v’ era gran fatto l’ uso del punteggiare ; ma
di scrittore moderno . Monsignor della Casa
nel Galateo num. 23. dice : Quando si favella
con alcuno , non se gli dee l’ uomo avvicinare
sì , che se gli aliti nel viso : perciocchè molti
troverai, che non amano di sentire il fiato al-
trui ; quantunque cattivo odore non ne veniße .
Ecco dopo la parola viso si mettono i due
punti , perchè ivi termina un membro del
perio-
/ BEGIN PAGE 464 /
periodo : e dopo la parola altrui si mette pun-
to, e virgola , perchè ciò , che siegue , non
è membro , ma parte di membro , e la pausa
non è grande .
E nel suddetto Galateo num. 152. si dice :
Si fece una roba di sciamito cremisì ; e dinan-
zi al petto un motto a lettere d’ oro : egli è
come Dio vuole : e nelle spalle di dietro simili
lettere , che diceano : e’ sarà come Dio vorrà .
Si noti , che dopo le parole oro , e diceano si
mettono due punti, perchè ciò , che siegue,
riferisce precisamente le parole di quel motto .
Del punto interrogativo non accade ad-
durre esempio , essendo cosa notissima , che
questo punto va messo al fine delle parole
interrogative . Contuttociò, se queste son mol-
te, qualche circospezione usar si vuole ; cioè ,
che quando le parole sono continuate , nè
ci è pausa d’ importanza , si metta un solo
interrogativo in ultimo ; ma quando ci è qual-
che notabil pausa , si metta ivi uno interro-
gativo, e un’ altro all’ ultimo . Potranno ser-
vire a ciò mostrare due esempj del Salvini
Prose Toscane tom. I. pag. 5., dove dice : E
se ella in argomenti o pii , o morali , si eser-
citasse , come moltissime han fatto , quanto ne
verrebbe ella grata , e utile agli uomini , e
cara a Dio, ricca, e bella in se stessa, e agli
occhi del nostro amabilissimo Santo Protettore
infinitamente gradita ? E ivi pag. 6. Ora se la
leg-
/ BEGIN PAGE 465 /
leggiadria del suo stile da tutto il mondo , e
da tutte le nazioni ammirato, a savie cose,
e divote , come alcuno eccellente spirito di no-
stra patria felicemente fa, si rivolga ; quanto
la nostra lingua di pregio , e di venerazione
acquista, e vie maggiormente acquistar puote ?
e per questa ultima prerogativa rendersi più
amabile al nostro Santo, e in conseguenza più
da lui favorita ?
Il punto ammirativo si mette al fine delle
esclamazioni d’ ammirazione , di passione, o
d’ affetto . Petrar. p. 2. son. 65. Oh tempo, oh
ciel volubil , che fuggendo Inganni i ciechi, e
miseri mortali !
Intorno poi all’ uso delle virgole, il quale
è sì frequente nello scrivere, sarà ben fatto
mettere alcune brevi osservazioni confermate
da buoni esempj , affinchè altri possa aver
qualche norma di scrivere correttamente . E
gli esempj degli Autori del buon secolo, che
addurremo , dovranno valutarsi , non già se-
condo l’ ortografia degli Autori, o di quel
secolo, ma secondo quella, che ad essi dan-
no le buone edizioni , e ’l Vocabolario del-
la Crusca .
Osservazione prima .
Qualunque parola, union di parole, o pro-
posizione si trova in un periodo , che alla
costruzione di esso non appartiene , si mette
tra due virgole, oltre a quelle, che per en-
G g tro
/ BEGIN PAGE 466 /
tro di sua natura esige . Capricc. Bott. Fac-
ciam dunque a cotesto modo , ma con questo ,
vedi, che tu non ti parta da me . Bocc. g. 7.
n. 2. Ed io, misera me, perchè son buona, e
non attendo a così fatte novelle , ho male , e
mala ventura . E g. 3. n. 7. Questo peccato adun-
que è quello, che la Divina giustizia , la quale
con giusta bilancia tutte le sue operazioni me-
na ad effetto, non ha voluto lasciare impunito .
Osservazione seconda .
La copula e, e le disgiuntive o, e nè vo-
glion virgola avanti , come è noto, senza
che ne adduciamo esempj. Dee però notarsi,
che quando tali particelle si replicano , di-
modo che la prima stia come per ripieno ,
questa , secondo l’ uso migliore, non ha vir-
gola avanti . Salvin. Pros. Tosc. f. 41. Quanto
egli e nell’ una , e nell’ altra interpretazione si
segnalasse , non fa d’ uopo , ch’ io vi ridica . E
disc. Accad. f. 191. L’ uomo nobile si può consi-
derare in due maniere , pesandolo o colla sta-
dera del volgo , o colla bilancia del savio .
Bocc. g. 10. n. 8. Perciocchè nè nell’ una, nè
nell’ altra non intendo di partirmi .
Osservazione terza .
Il relativo che, il quale , o la quale esige
virgola avanti , perchè fa qualche interrom-
pimento, benchè piccolo. Pure quando vale
il quid , o l’ id , quod de’ Latini , si mette
senza precedente virgola, perchè non vi ap-
pare
/ BEGIN PAGE 467 /
pare interrompimento . Bocc. g. 2. n. I. Essen-
do tutta la gente attenta a vedere che di lui
avvenisse . E g. 3. n 3. Io il dirò al marito
mio , e a’ frate’ miei, e avvegnane che può .
Osservazione quarta .
Avanti alle congiuzioni si dee metter la
virgola, perchè esse inducono qualche inter-
rompimento . Anzi si pone la virgola anche
quando non v’ è la congiunzione , ma si sot-
tintende . Addurremo alcuni esempj, da’ quali
si potrà prender lume del come regolarsi in
altri simili casi. Passav. f. 99. Non sia ebria-
co , nè taverniere , non giucatore , non mas-
nadiere . Si sottintende la congiunzione e .
Boccacc. g. 3. n. 9. Al Conte significassero, lei
avergli vacua , ed espedita lasciata la posses-
sione . Si sottintende equivalentemente la con-
giunzione che . E così degli altri, come po-
trà vedersi negli esempj addotti nel secondo
libro , della costruzione figurata .
Osservazione quinta .
Quando le congiunzioni , e i modi avver-
biali sono replicati , e si corrispondono, al
primo di essi non si suole porre innanzi la
virgola . Bocc. g. 2. n. 9. Donolle che in gio-
je , e che in vasellamenti , e che in danari
quello, che valse meglio di altre diecimila dob-
bre. E g. 5. n. I. Era Cimone sì per la sua
forma, e sì per la nobiltà , e ricchezza del
padre , quasi noto a ciascun del paese .
G g 2 CAP.
/ BEGIN PAGE 468 /
CAP. X.
Delle sillabe lunghe, e brievi .
POco ci ha a dire delle sillabe lunghe , e
brievi, tra perchè la Lingua Toscana non
ha tante leggi di prosodia, come la Latina ;
e perchè a noi Italiani in gran parte è no-
to dove nelle parole si abbia a mettere l’ac-
cento acuto . Pure accenneremo alcune cose,
delle quali potrebbe nascer dubbio .
Le prime persone plurali de’ preteriti im-
perfetti de’ verbi da non pochi Italiani si
pronunziano colla penultima breve , amáva-
mo , udívamo &c. , ma ciò non dee ammet-
tersi , non solamente perchè i Toscani le pro-
nunziano colla penultima lunga, amavámo ,
udivámo &c., ma ancora perchè così le pro-
nunziavano gli Autori del buon secolo, co-
me da’ Poeti veder si può. Dante Purg. cant.
12. Già montavam su per gli scaglion santi .
E Parad. cant. 24. E quel baron , che sì di
ramo in ramo Esaminando già tratto m’ avea ,
Che a l’ ultime fronde appressavamo .
Anche presso di noi , come presso i Lati-
ni, la vocale, a cui sieguono due consonan-
ti, è lunga . Pure l’ uso de’ Toscani porta
in ciò qualche eccezione, come, per cagion
d’ esempio in árista, che significa schiena di
ma-
/ BEGIN PAGE 469 /
majale, e si pronunzia coll’ accento in sulla
prima. Così ancora , secondo l’ uso comu-
ne d’ Italia , si dice Ótranto , Táranto, Lé-
panto, nomi di Città, colla seconda sillaba
breve .
Parimente in Toscana fiócine , che signi-
fica la buccia dell’ acino dell’ uva ; e cérci-
ne , ch’ è quell’ involto usato da chi porta
pesi in capo ; e durácine , ch’ è aggiunto di
alcune frutte , che hanno durezza , si pro-
nunziano colla penultima breve .
Fine del terzo , ed ultimo Libro .
G g 3 TA-
/ BEGIN PAGE 470 /
TAVOLA
De’ Libri, e de’ Capitoli della presente Opera.
LIBRO PRIMO .
Delle parti della toscana orazione . carte 9.
Cap. I. DEl toscano Alfabeto . ivi .
Cap. 2. Delle sillabe . c. 12.
Cap. 3. Delle parole . c. 15.
Cap. 4. Quante , e quali sieno le parti della tosca-
na orazione . c. 16.
Cap. 5. Del nome sustantivo, e dell’addiettivo. c. 18.
Cap. 6. De’ nomi alterati . c. 20.
Cap. 7. De’ nomi partitivi , e de’ numerali. c. 23.
Cap. 8. Delle varietà , o sieno passioni del nome. c. 25.
Cap. 9. Del segnacaso . c. 29.
Cap. 10. Dell’ articolo . c. 31.
Cap. 11. Della declinazione de’ nomi. c. 34.
Cap. 12. De’ nomi indeclinabili . c. 36.
Cap. 13. De’ nomi eterocliti di doppia uscita. c. 38.
Cap. 14. De’ nomi eterocliti, che hanno un solo plu-
rale , ma con desinenza fuor di regola . c. 41.
Cap. 15. De’ nomi difettivi . c. 42.
Cap. 16. De’ pronomi , e prima del pronome IO . c. 45.
Cap. 17. Del pronome TU . c. 47.
Cap. 18. Del pronome SE . c. 49.
Cap. 19. De’ pronomi derivativi . c. 50.
Cap. 20. De’ pronomi dimostrativi di persona . c. 52.
Cap. 21. De’ pronomi dimostrativi di cosa . c. 66.
Cap. 22. De’ pronomi relativi . c. 67.
Cap. 23. De’ pronomi universali indeterminati . c. 71.
Cap. 24. Del Verbo . c. 86.
Cap.
/ BEGIN PAGE 471 /
Cap. 25. Delle variazioni del Verbo . c. 89.
Cap. 26. Alcune generali oßervazioni sopra le conjuga-
gazioni de’ Verbi . c. 91.
Cap. 27. Conjugazione del Verbo essere . c. 95.
Cap. 28. Conjugazione del Verbo avere . c. 100.
Cap. 29. Uso de’ Verbi essere , e avere nella conjuga-
zione degli altri Verbi : e quando avere si ponga
per essere . c. 104.
Cap. 30. Conjugazione del Verbo amare , ch’ è la pri-
ma regolare , co’ suoi anomali . c. 107.
Cap. 31. Conjugazione del Verbo temere , ch’ è la se-
conda regolare . c. 114.
Cap. 32. De’ Verbi anomali della seconda conjug. c. 118.
Cap. 33. Conjugazione del Verbo leggere , ch’ è la ter-
za regolare . c. 123.
Cap. 34. Verbi anomali della terza conjugaz. c. 129.
Cap. 35. Conjugazione del Verbo sentire, ch’ è la quar-
ta regolare . c. 134.
Cap. 36. Anomali della quarta conjugazione . c. 136.
Cap. 37. De’ Verbi difettivi . c. 140.
Cap. 38. De’ Verbi passivi , e degl’ impersonali. c. 142.
Cap. 39. Del participio . c. 144.
Cap. 40. Del gerundio . c. 149.
Cap. 41. Della preposizione . c. 150.
Cap. 42. Del ripieno . c. 154.
Cap. 43. Dell’ avverbio . c. 165.
Cap. 44. Dell’interiezione . c. 169.
Cap. 45. Della congiunzione . c. 170.
LIBRO SECONDO.
Della costruzione Toscana . car. 173
Cap. I. Idea generale della costruzione toscana . ivi.
Cap. 2. Della costruzione de’ Verbi attivi . c. 185.
Primo Ordine . ivi.
Secondo Ordine . c. 190.
G g 4 Terzo
/ BEGIN PAGE 472 /
Terzo Ordine . c. 193.
Quarto Ordine . c. 197.
Quinto Ordine . c. 199.
Sesto Ordine . c. 201.
Settimo Ordine . c. 203.
Cap. 3. Della costruzione de’ Verbi passivi . c. 207.
Cap. 4. De’ Verbi assoluti . c. 208.
Cap. 5. Della costruzione de’ Verbi neutri . c. 210.
Primo Ordine . c. 211.
Secondo Ordine . c. 212.
Terzo Ordine . c. 218.
Quarto Ordine . c. 224.
Quinto Ordine . c. 226.
Sesto Ordine . c. 230.
Settimo Ordine . c. 233.
Cap. 6. Della costruz. de’ Verbi neutri passivi. c. 235.
Primo Ordine . c. 236.
Secondo Ordine . c. 240.
Terzo Ordine . c. 245.
Quarto Ordine . c. 248.
Quinto Ordine . c. 249.
Sesto Ordine . c. 251.
Settimo Ordine . c. 253.
Cap. 7. Della costruzione de’ Verbi impersonali.c.255.
Primo Ordine . ivi.
Secondo Ordine . c. 256.
Terzo Ordine . c. 259.
Quarto Ordine . c. 260.
Quinto Ordine . c. 264.
Cap. 8. Della costruzione de’ Verbi locali . c. 265.
Stato in luogo . c. 266.
Moto da luogo . c. 272.
Moto per luogo . c. 273.
Moto a luogo . c. 275.
Moto verso luogo . c. 277.
Moto fino a luogo . c. 279.
Della
/ BEGIN PAGE 473 /
Della distanza d’ un luogo dall’ altro . c. 280.
Cap. 9. Di varj casi , che sono comuni a molti verbi .
c. 282.
Cap. 10. Della costruzione degl’infin. de’ verbi. c. 286.
Cap. 11. Della costruzione del gerundio . c. 297.
Cap. 12. Della costruzione del participio . c. 304.
Cap. 13. Della costruzione del nome . c. 308.
Cap. 14. Della costruzione della preposizione . c. 327.
Cap. 15. Della costruzione dell’ avverbio . c. 365.
Cap. 16. Della costruzione dell’ interiezione . c. 395.
Cap. 17. Della costruzione della congiunzione . c. 397.
Cap. 18. Della costruzione figurata . c. 412.
LIBRO TERZO .
Della maniera di pronunziare , e di scrivere
toscano . c. 434.
Cap. I. Del valore , e della pronunzia delle let-
tere . ivi .
Cap. 2. Dell’accento , e dell’apostrofo . c. 439.
Cap. 3. Delle stroncature delle sillabe . c. 441.
Cap. 4. Dell’ accrescimento delle parole . c. 443.
Cap. 5. Quando le parole si poßano scemare in prin-
cipio . c. 445.
Cap. 6. In quanti modi possano le parole scemarsi in
fine . c. 447.
Cap. 7. Delle parole composte . c. 458.
Cap. 8. Delle lettere maggiori , e minori , e quali
sieno le regole del loro uso . c. 461.
Cap. 9. De’ punti , e delle virgole . c. 462.
Cap. 10. Delle sillabe lunghe , e brevi . c. 468.
TA-
/ BEGIN PAGE 474 /
TAVOLA
Delle abbreviature, e degli Autori, da’ quali
sono tratti gli esempj citati in quest’
Opera .
Due sorte d’ Autori si citano in quest’Opera ; gli Autori
del buon secolo , e sono quelli , che scrißero dall’ An-
no 1300. fino al 1400., nel qual secolo era la lingua
toscana nel più bel fiore : e gli Autori moderni, quelli
cioè , che scrißero di qua dal buon secolo .
A
Autori del buon secolo .
ALbertan. Volgarizzamento di tre Trattati morali
di Albertano Giudice da Brescia . E‵ stampato in
Firenze nel 1610.
Amm. Ant. Ammaestramenti degli Antichi raccolti
da F. Bartolommeo da S. Concordio Pisano dell’ Ordi-
ne de’ Predicatori . E‵ stampato in Firenze nel 1734.
per Domenico Maria Manni .
Autori moderni .
Alam. Gir. Girone il Cortese Poema di Luigi Ala-
manni . E' stampato in Parigi nel 1548.
Allegri . Rime , e Prose di Alessandro Allegri stam-
pate in varj luoghi , e tempi .
Ambra Furt. Cofan. Il Furto Commedia in prosa , e
la Cofanaria Commedia in versi di Francesco d’Ambra ,
stampate in Firenze presso i Giunti, la prima nel 1564.,
l’ altra nel 1593.
Ariost. Fur. Orlando furioso Poema notissimo di Lo-
dovico Ariosto.
Autori
/ BEGIN PAGE 475 /
B
Autori del buon secolo .
Bocc. g. , n. , introd. , proem. , tit., canz. , concl.
princ. , fin. Decamerone opera famosa di M. Giovanni
Boccaccio , che contiene cento novelle raccontate in
dieci giornate . La g. significa giornata , e la n. novel-
la ; introd. accenna l’ introduzione al principio delle
giornate , proem. il proemio o di tutta l’opera , o di
ciascuna novella : tit. significa il titolo della novella ,
canz. la canzone posta al fine di ciascuna giornata ;
concl. la conclusione , ch’ è al fine del Decamerone .
Princ. accenna il proemio della giornata , e fin. le pa-
role , che sono sul fine di essa , dopo la decima novella.
Bocc., Amet. Ameto Opera di M. Giovanni Boccaccio
stampato in Firenze da’ Giunti nel 1521.
Bocc. Fiamm. Fiammetta Opera di M. Giovanni Boc-
caccio stampato da’ Giunti in Firenze nel 1594.
Bocc. Filoc. Filocolo di M. Giovanni Boccaccio stam-
pato da’ Giunti in Firenze nel 1594.
Bocc. Laber. Laberinto d’Amore , o sia il Corbaccio
di M. Giovanni Boccaccio stampato da’ Giunti in Firen-
ze nel 1594.
Bocc. Ninf. Fies. Ninfale Fiesolano Poema in ottava
rima di M. Giovanni Boccaccio .
Bocc. Vit. Dant. Vita di Dante Alighieri scritta da
M. Giovanni Boccaccio .
Bocc. Urbano. Urbano Opera comunemente attribui-
ta al Boccaccio , ma che non è altrimenti sua : è però
antica , onde se ne traggono talvolta alcuni esempj .
Bocc. Lett. Pin. Ross. Lettera scritta dal Boccaccio a
M. Pino de’ Rossi . E questa, e le altre prose del Boc-
caccio fuori del Decamerone sono state insieme raccolte,
e stampate in Firenze nel 1723. da’ Tartini , e Franchi ,
col titolo Prose di Dante , e del Boccaccio .
Bocc. Teseid. Teseide Poema in ottava rima di M. Gio-
vanni Boccaccio , stampato in Venezia nel 1528.
Brun.
/ BEGIN PAGE 476 /
Brun. Tesor., Tesoret. Due Opere di Ser Brunet-
to Latini , che fu Maestro di Dante ; l’ una intitolata
Tesoro , stampata in Venezia nel 1533. , l’altra intito-
lata Tesoretto , o sia Favolello , ch’ è una poesia a fog-
gia di Frottola, stampata in Roma dal Grignani nel 1642.
Buti Com: Comento di Francesco da Buti Pisano so-
pra la Commedia di Dante , testo a penna .
Autori moderni .
Bart.Tort. e diritt. Il torto, e ’l diritto del non si può
dato in giudicio sopra molte regole della lingua Italia-
na , opera di Ferrante Longobardi , cioè del Padre Da-
niello Bartoli della Compagnia di Gesù , stampato in
Roma presso il Varese nel 1668.
Bemb. Pros. Asol. Lett. Rim. Piero Cardinal Bembo
le seguenti Opere . Le Prose intorno alla volgar lingua;
gli Asolani Dialogo ; le Lettere volgari ; e le Rime .
Le Opere di questo gran Cardinale sono state raccolte
insieme , e stampate ultimamente in Venezia .
Borghin. Fir. disf. Opera di Don Vincenzio Borghi-
ni Fiorentino , se Firenze fu spianata da Attila . Le
Opere tutte di questo Autore furono da’ Giunti stam-
pate nel 1584.
Buonarr. Cical. Cicalate di Michelagnolo Buonarro-
ti il giovane impresse nel primo tomo della parte terza
delle Prose Fiorentine .
Burch. Sonetti di Mastro Domenico di Giovanni, per
soprannome il Burchiello , Poeta Fiorentino , e Bar-
biere in Calimala , stampati da’ Giunti nel 1552.
C
Autori del buon secolo .
Cavalc. specch. croc. Med. spir. Med. cuor. F. Dome-
nico Cavalca dell’ Ordine de’ Predicatori le seguenti
opere spirituali . Specchio della Croce . Medicina , o sia
Disciplina spirituale . Medicina del cuore .
Ciriff. Calvan. Ciriffo Calvane , e ’l Povero avve-
duto, Romanzo antico in prosa, testo a penna. Dee di-
stin-
/ BEGIN PAGE 477 /
distinguersi dal Ciriffo Calvaneo , Poema in ottava rima,
composto da Luca Pulci , e da Bernardo Giambullari .
Cron. Amarett. Cronichetta di Amaretto Mannelli
stampata in Firenze con altre Scritture nel 1733. per
Domenico Maria Manni .
Cron. Morell. Cronaca della famiglia de’ Morelli ,
stampata in Firenze dietro la Storia del Malespini da’
Tartini , e Franchi nel 1718.
Autori Moderni .
Capr. Bott. Capricci del Bottajo Dialoghi di Gio-
vambattista Gelli , stampati in Venezia nel 1548. , e
e nel 1551.
Castelv. Lodovico Castelvetro Modonese giunte alle
Prose del Cardinal Bembo .
Cecch. Stiav. La Stiava Commedia di Giovammaria
Cecchi , stampata in Venezia nel 1585.
Chiabr. Gabriello Chiabrera Savonese Rime .
Cinonio . Osservazioni della lingua Italiana divise
in due parti , la prima delle quali contiene il Trattato
delle particelle , il secondo quello de’ Verbi , raccolte
dal Cinonio Accademico Filergita, cioè dal Padre Mar-
co Antonio Mambelli della Compagnia di Gesù, e stam-
pate in Verona dal Berno nel 1722.
D
Autori del buon secolo.
Dant.Inf.Purg.Parad.cant.Conviv.Rim. Dante Ali-
ghieri Commedia divisa in tre parti , Inferno, Purga-
torio, Paradiso , ciascuna delle quali è divisa per canti.
Convivio , stampato in Firenze da’ Tartini , e Franchi
del 1723 , come sopra . Rime di Dante , stampate da’
Giunti in Firenze del 1527.
Dittam. Dittamondo , o sia Dicta Mundi Poema in
terza rima di Fazio degli Uberti . Si cita il testo a pen-
na , perchè le stampe sono scorrette .
Autori moderni .
Davanz. Tacit. Scism. Volgarizzamento di Corne-
lio
/ BEGIN PAGE 478 /
nelio Tacito , e Storia della Scisma d’ Inghilterra Ope-
re di Bernardo Davanzati, stampate in Firenze nel 1637.
presso il Nesti .
Deput. Decam. Annotazioni , e discorsi sopra alcuni
luoghi del Decamerone fatti da’ Deputati alla correzio-
ne di esso , e stampati in Firenze nel 1574.
E
Esp. Salm. Volgarizzamento delle Esposizioni de’
Salmi , opera del buon secolo , e testo a penna .
F
Autori del buon secolo .
Filipp. Vill. Aggiunta fatta da Filippo Villani alla
Storia di Matteo suo Padre , dal capitolo 61. fino alla
fine del libro undecimo , della stampa de’ Giunti di Fi-
renze nel 1577.
Fior. S. Franc. Fioretti di S. Francesco , della mo-
derna stampa de’ Tartini , e Franchi 1718.
Franc. da Barb. Francesco da Barberino Documenti
d’Amore , della stampa di Roma del Mascardi 1640.,
colle Annotazioni del Conte Federigo Ubaldini .
F. Giord. Pred. Prediche di F. Giordano da Ripalta
dell’Ordine de’ Predicatori . Testo a penna .
F. Jacop. B. Jacop. Poesie, o sieno Laudi spirituali del
B. Jacopone da Todi dell’Ordine di S. Francesco, stam-
pate in Venezia nel 1617.
Franco Sacch. Franco Sacchetti Novelle trecento ,
stampate nel 1724. colla data di Firenze . Opere diver-
se dello stesso , testo a penna .
Autori moderni .
Firen. Asin. , Disc. , Dial. bell. Donn. , Lucid. , Tri-
nuz., Rim., Nov. Agnolo Firenzuola Traduzione dell’
Asino d’oro d’ Apulejo ; Discacciamento delle nuove
lettere ; Dialogo delle bellezze delle donne ; i Lucidi ,
e la Trinuzia Commedie in prosa, e le rime . Le Opere
tutte di questo Autore furono stampate nel 1723. colla
data di Firenze, e in queste vi sono ancora otto Novelle.
Autori
/ BEGIN PAGE 479 /
G
Autori del buon secolo .
Gio. Vill. Storia di Giovanni Villani , stampata in
Firenze da’ Giunti nel 1587.
Grad. S. Girol. Volgarizzamento dell’ Opera intito-
lata Gradi di S. Girolamo , stampato dal Manni in Fi-
renze nel 1729.
Guid. G. Volgarizzamento della Storia della guerra
Trojana di Guido Giudice dalle Colonne di Messina ,
testo a penna .
Guitt. Lett. Lettere di F. Guittone d’Arezzo, stam-
pate di fresco in Firenze .
Autori moderni .
Galat. Casa. Galateo di M. Giovanni della Casa , li-
bro notissimo .
Gell. Circ. Sport. Giovambattista Gelli la Circe di-
visa in dieci Dialoghi , e stampata in Firenze nel 1549.
La Sporta Commedia in prosa , stampata in Firenze nel
1550. , e nel 1602.
Guicciard. Storia d’Italia di M. Francesco Guicciar-
dini .
L
Autori del buon secolo .
Lib. Astrol. Libro , o sia Trattato di Astrologia , te-
sto a penna .
Lib. cur. malatt. Volgarizzamento del Libro intito-
lato Cura di tutte le malattie , testo a penna .
Lib. mott. Libro di motti , testo a penna .
Lib. Sagr. Libro , o sia Trattato de’ Sagramenti , te-
sto a penna .
Liv. M. Volgarizzamento della prima , e della ter-
za Deca di Tito Livio, testo a penna .
Autori moderni .
Lasca Sibill. Spir. La Sibilla , e la Spiritata Comme-
die in prosa di Antonfrancesco Grazini detto il Lasca ,
le Opere del quale furono stampate in Venezia del 1582.
Lib.
/ BEGIN PAGE 480 /
Lib. Son., Raccolta di Sonetti di Matteo Franco, e di
Luigi Pulci , testo a penna .
Lor. de’ Med. Arid. Aridosio Commedia in prosa di
Lorenzino de’ Medici , stampata in Firenze presso i
Giunti nel 1595.
M
Autori del buon secolo .
M. Aldobr. Volgarizzamento di un Trattato di Me-
dicina di Maestro Aldobrandino da Siena fatto da Sere
Zucchero Bencivenni , testo a penna .
Maestruz. Volgarizzamento della Somma Pisanella,
detta il Maestruzzo , da alcuni attribuito a Don Gio-
vanni delle Celle , testo a penna .
Matt. Vill. Storia di Matteo Villani , che serve di
continuazione a quella di Giovanni suo fratello , stam-
pata in Firenze del 1567., e del 1581.
Mirac. M. Miracoli della Madonna , testo a penna .
Mor. S. Gregor. Volgarizzamento de’ Morali di San
Gregorio fatto da Zanobi da Strata , stampato in Roma
da’ Corbelletti nel 1714.
De’ Moderni .
Malmant. Malmantile racquistato Poema giocoso in
ottava rima di Perlone Zipoli , cioè di Lorenzo Lippi
Dipintore Fiorentino , colle note di Puccio Lamonì ,
cioè di Paolo Minucci , stampato in Firenze nel 1731.
Mann. Lez. Lezioni di lingua Toscana di Domenico
Maria Manni Accademico Fiorentino , stampate in Fi-
renze nel 1737.
N
Del buon secolo .
Nov. ant. Il Novellino , o sia Cento Novelle anti-
che , stampate nel 1724. colla data di Firenze .
O
Del buon secolo .
Ovid. Pist. Volgarizzamento delle Pistole d’Ovidio,
testo a penna.
Autori
/ BEGIN PAGE 481 /
P
Autori del buon secolo .
Passav. Specchio di vera penitenza di F. Jacopo Pas-
savanti dell’ Ordine de’ Predicatori , stampato in Fi-
renze dall’Accademia della Crusca nel 1725.
Pecor. Novelle cinquanta, divise in venticinque gior-
nate, di Ser Giovanni Fiorentino intitolato il Pecorone ,
stampate in Milano nel 1558.
Petrar. Canzoniere di M. Francesco Petrarca .
Pier. Cresc. Volgarizzamento del Trattato dell’ A-
gricoltura di Piero de’ Crescenzj Cittadino Bolognese ,
stampato in Firenze nel 1605.
Autori moderni .
Pulci Morg. Il Morgante Maggiore Poema di Luigi
Pulci , stampato nel 1732. colla data di Firenze.
Pros. Fior. Prose Fiorentine di diversi Autori , rac-
colte da Carlo Dati , e stampate in Firenze , e in Ve-
nezia.
R
Autori del buon secolo .
Rettor. Tull. Volgarizzamento della Rettorica di
Marco Tullio , stampato dal Manni in Firenze nel 1734.
Ricord. Malesp. Storia Fiorentina di Ricordano Ma-
lespini, stampata in Firenze del 1718.
De’ Moderni .
Redi Lett. Lettere famigliari di Francesco Redi,
stampate dal Manni in Firenze nel 1724., nel 1727.,
e in parte nel 1731.
S
Autori del buon secolo .
S. Grisost. Volgarizzamento di alcuni Opuscoli di
S. Giovanni Grisostomo , testo a penna .
Sen. Pist. Volgarizzamento delle Pistole di Seneca ,
stampato in Firenze nel 1717.
Stor. Ajol. La Storia , o sia la prodezze d’Ajolfo ,
Romanzo antico , testo a penna .
H h Stor-
/ BEGIN PAGE 482 /
Stor. Pistol. Storie Pistolesi , ristampate in Firenze
nel 1733.
Stor. Barl. Volgarizzamento della Storia di Bar-
laam, e Giosafat , testo a penna .
Autori moderni .
Sagg. nat. esper. Saggi di naturali esperienze fatte
in Firenze nell’Accademia del Cimento, descritti dal
Sollevato , cioè dal Conte Lorenzo Magalotti , e stam-
pati in Firenze nel 1692.
Salv. Avvert. Granch. Spin. Del Cavalier Leonardo
Salviati Avvertimenti della lingua sopra ’l Decamero-
ne , stampati in Napoli nel 1712. Il Granchio Comme-
dia in versi , e la Spina Commedia in prosa, stampate
in Firenze nel 1606.
Salvin. Pros. Tosc. Disc. Dell’ Abate Antommaria
Salvini Prose Toscane recitate nell’ Accademia della
Crusca ; e Discorsi Accademici recitati nella Accade-
mia degli Apatisti .
Segn. Stor. Storia Fiorentina di Bernardo Segni ,
stampata nel 1723. colla data di Augusta .
Sen. benef. Varchi . Traduzione de’ Libri de’ Benefi-
zj di Seneca fatta da Benedetto Varchi , e stampata in
Firenze nel 1574.
Serd. Stor. Traduzione della Storia dell’ Indie O-
rientali del P. Giampiero Maffei della Compagnia di
Gesù , fatta da Francesco Serdonati , e stampata in Fi-
renze nel 1589.
Stor. Eur. Storia d’ Europa di Pierfrancesco Giam-
bullari , stampata in Venezia nel 1566.
T
Autori del buon secolo .
Tav. rit. Volgarizzamento del Libro de’ Cavalieri
erranti , detto comunemente la Tavola ritonda , testo
a penna .
Tratt. gov. fam. Trattato del governo della fami-
glia , testo a penna .
Tratt.
/ BEGIN PAGE 483 /
Tratt. piet. Trattato della pietà , testo a penna .
Tratt. sap. Trattato di sapienza , testo a penna .
De’ moderni .
Tass. Gerusalemme liberata Poema famoso di Tor-
quato Tasso , le Opere del quale furono stampate tut-
te in Firenze nel 1724.
V
Autori del buon secolo .
Vit. Crist. Vita di Gesù Cristo , testo a penna .
Vit. Plut. Volgarizzamento delle Vite degli Uomi-
ni illustri di Plutarco , testo a penna .
Vit. S. Margh. Vita di S. Margherita , stampata in
Firenze dal Manni nel 1734.
Vit. SS. Pad. Volgarizzamento delle Vite de’ SS. Pa-
dri , stampato dal Manni in Firenze nel 1732.
De’ moderni .
Varchi Ercol. Ercolano , o sia Dialogo sopra le Lin-
gue di Benedetto Varchi ristampato in Firenze nel
1730.
H h 2 IN-
/ BEGIN PAGE 484 /
INDICE
Delle Materie , che si contengono in
quest’ Opera .
A
A Segno del dativo . carte 30. A preposizione . Sua
costruzione. c. 329. Serve all’accusativo in forza
dell’ad latino. ivi . Fa le veci di per , in , con , da ,
inverso . c. 330. 331. E del pro de’ Latini . c. 330.
Ha talora forza dell’ ablativo della Quinta de’ Neu-
tri de’ Latini . ivi. Vale anche a modo , a similitu-
dine . ivi . Talora a rispetto , a comparazione. ivi .
Incorporata coll’ articolo , e aggiunta a certi nomi
femminini, forma varj modi avverbiali. c.331. Si usa
elegantemente per in , significando tempo. ivi. Con-
giunta cogl’ infiniti dà loro la forza de’ gerundj La-
tini . ivi. E talvolta del soggiuntivo . c. 292. Ag-
giunta alla misura della distanza de’ luoghi vale in
circa . c. 282.
Abbenchè per benchè è voce barbara . c. 399.
Abbisognare impersonale vale opus eße. c. 256.
Accanto preposizione vuole il dativo . c. 361.
Accattare verbo assoluto val mendicare . c. 205. Atti-
vo della Settima val prendere in prestanza. ivi. Ac-
cattar parola vale impetrare . c. 206.
Accento che cosa sia , e di quante sorte . c. 439.
Acciocchè congiunzione dinota cagion finale , e vuole il
soggiuntivo . c. 401. Talora fra acciò , e che si frap-
pone alcuna parola . ivi . Acciò per acciocchè è voce
di non troppo buona lega . c. 402.
Accomandare si usa per legare . c. 200.
Accompagnanomi quali sieno . c. 162.
Accompagnaverbi quali sieno . c. 163.
Accon-
/ BEGIN PAGE 485 /
Acconciarsi vale accomodarsi . c. 252. Acconciarsi dell’
anima val prepararsi co’ Sagramenti alla morte.c.245.
Accontarsi vale accordarsi . c. 252.
Accordarsi a una cosa , cioè consentirvi . c. 245.
Accosto preposizione vuole il dativo . c. 361.
Adagiare si usa per somministrare . c. 192.
Addarsi vale accorgersi . c. 242.
Addosso preposizione vuole il dativo . c. 363.
Addurre Verbo anomalo . Sua conjugazione . c. 132.
Adunque congiunzione illativa . c. 408.
Aere è di genere comune . c. 26.
Affarsi val convenire . c. 246.
Affinchè è lo stesso che acciocchè . c. 402.
Affissi , e loro regole . c. 430. Quando raddoppino la
consonante . c. 460.
A fronte preposizione vuole il dativo . c. 362.
Aggiugnere si usa per arrivare . c. 228.
Aggradare , aggradire si usano per piacere. c. 220.
Ah , ahi interjezioni . c. 396. Talvolta si sciolgono ,
e vi si frappone qualche voce dinotante maggiore af-
fetto . ivi.
Ajo si fa da’ nostri Poeti di una sillaba sola . c. 157.
Ala ha tre singulari, e tre plurali . c. 39.
Alberi hanno il nome mascolino , detratti quercia , ed
elce ; e il nome del frutto è femminino . c. 28. 29.
Alcuno quando da se , o aggiunto a un nome significa
più cose indeterminate , ha plurale. c. 44.
Alcuno pronome indefinito , e sua declinazione , e suo
uso . c. 78. In vece di alcuno si può dire uomo . c. 79.
Alfabeto Toscano di quante lettere sia . c. 9.
Allato preposizione vuole il dativo. c. 361. Si usa ele-
gantemente per addosso . c. 363.
Alla volta si usa per verso . c. 278.
Allo ’ncontro preposizione vuole il genitivo , ma si tro-
va col dativo . c. 361.
Alquanto pronome vale qualcuno , alcuno &c. c. 80.
H h 3 Nel
/ BEGIN PAGE 486 /
Nel plurale si adopera a modo di sustantivo . ivi.
Sustantivamente , e neutralmente vale aliquid . ivi.
Avverbio . c. 368.
Alto avverbio significa altamente . c. 371. Col Verbo
fare significa fermarsi . ivi . Di per se significa l’eja,
e l’ age de’ Latini . ivi.
Altrettale pronome talora è lo stesso che tale . c. 82. Si
usa solo nel plurale. ivi .
Altrettanto pronome , e sua declinazione . c. 83. Di-
nota uguaglianza di numero , o di misura . ivi. Av-
verbio . c. 368.
Altri pronome , e sua declinazione . c. 83. Ammette
l’ articolo , fuorchè nel nominativo singolare . ivi .
Se possa usarsi ne’ casi obliqui . c. 84. Si usa talvolta
per io . ivi . Si usa ancora per uno , qualcuno &c.
Altri che , altro che vagliono fuorchè . c. 359.
Altrimenti , o altramente avverbio vale in altro modo.
c. 376. E‵ talvolta ripieno. c. 161.
Altro pronome addiettivo , e sua declinazione . c. 85.
Sustantivo , e sua declinazione . c. 86. Ha il solo sin-
golare. ivi. Fa talvolta intendere più di quello, che
dice . ivi .
Altronde avverbio vale da altro luogo . c. 273.
Altrove avverbio di stato in luogo. c. 270.
Altrui pronome , e sua declinazione . c. 84. Manca del
nominativo . ivi . Quando lasci il segnacaso . ivi , e
c. 317. Si trova coll’ articolo , ma non è suo. c. 84.
Si adopera talora sustantivo . c. 85. Se si trovi usato
in nominativo . ivi.
Al tutto avverbio vale il penitus de’ Latini . c. 371.
A luogo , e a tempo , modo avverbiale , vale opportu-
nè . c. 393.
Amare verbo . Sua conjugazione . c. 107. Amar meglio
si usa per voler piuttosto . c. 216.
A modo , maniera , guisa , foggia &c. preposizio-
ni , vogliono il genitivo , o pure una proposi-
zio-
/ BEGIN PAGE 487 /
zione , a cui preceda la particella che . car. 360.
Analogo nel plurale fa analogi , e analoghi . c. 42.
Anche , e in verso anco , congiunzione copulativa , che
accenna continuazione . c. 405.
Ancora congiunzione copulativa , oltre il noto signifi-
cato di etiam , vale nune quoque , e nondum. c. 377.
Ancorchè congiunzione ama il soggiuntivo , ma si
trova coll’ indicativo . c. 399.
Anello ha due plurali . c. 40.
Andare Verbo anomalo , e sua conjugazione . c. 112.
Sua costruzione . c. 226. Andare per riuscir male , e
sua costruzione . c. 227. Andare come si usi con pleo-
nasmo. c. 420. Andare una pena impersonale della
seconda . c. 258. E in tal senso si fa ancor della Ter-
za degl’ impersonali . c. 262. Andare per una perso-
na , o cosa vale andarla a prendere . c. 229. Andar-
sene si dice di cosa, che sia tolta via . c. 209. Andar-
sene in alcuna cosa vale risolversi . c. 250.
Anguilla è di genere promiscuo . c. 29.
Annighittire neutro passivo vale divenir neghittoso.
c. 238.
Annoverare val numerare . c. 195.
Anzi congiunzione avversativa . c. 404. Talvolta è
Elettiva . c. 407. Anzi che no, modo avverbiale , va-
le piuttosto che altro. c. 384.
A parte a parte avverbio vale particulatim . c. 385.
A posta di alcuno avverbio vale a suo piacimento. c. 374.
A posta fatta avverbio vale a caso pensato . c. 374.
Apostrofo che cosa sia . c. 441.
Appetto preposizione vuole il dativo . c. 362.
Appiè preposizione serve al genitivo . c. 360.
Appo preposizione ha ordinariamente 1’ accusativo , ma
si trova ancora col genitivo , e col dativo , c. 347. Si-
gnifica talvolta prossimità morale . ivi . Talvolta ac-
cenna puro stato in luogo . ivi .
Apporre vale incolpare a torto . c. 195.
H h 4 Apporsi
/ BEGIN PAGE 488 /
Apporsi vale indovinare . c. 238.
Apprendersi vale attaccarsi . c. 246.
Appresso preposizione suole aver l’accusativo, ma rice-
ve ancora il genitivo , e ’l dativo . c. 348. Significa
talvolta dopo . ivi . Avverbio . c. 372.
Apprestare vale apparecchiare . c. 195. Apprestarsi vale
apparecchiarsi . c. 247.
Appunto avverbio vale giustamente . c. 377. Si usa per
negare con disprezzo. ivi.
Aprire anomalo . c. 136. Si usa per manifestare. c.195.
Assoluto vale introdurre . c. 220.
A prova preposizione vuole il genitivo. c. 361.
Arbore è di genere comune . c. 26.
Ardire Verbo che suol’ esser della Seconda, è talora del-
la Terza de’ Neutri . c. 213.
Argomentare si usa per pensare . c. 215.
A rispetto , o per rispetto preposizione vuole il geniti-
vo. c. 361.
Arrecarsi vale condursi . c. 250.
Arma ha due singolari , e due plurali . c.39.
Arrogere Verbo difettivo , e sue voci . c. 141.
Articolo che cosa sia. c. 31. Quanti ne sieno . c. 32. Co-
me sia declinabile. ivi . Se dato l’articolo a un nome,
debba darsi anche al genitivo da esso dipendente .
c. 312. Se quando vi sono più nomi continuati, dato,
o non dato l’articolo al primo , debba corrisponden-
temente darsi , o sottrarsi agli altri . c. 314. Costru-
zione dell’ articolo. c. 308.
Aspettarsi impersonale vale l’attinet de’ Latini. c. 261.
Ascendere verbo non usato dal Boccaccio. c. 226.
A tempo, a tempi modo avverbiale vale ad ora opportu-
na. c. 393. Talora vale per alcun tempo . ivi .
Attenere vale oßervare la promessa . c. 194.
Attenersi della Terza de’ Neutri passivi si usa per aver
fede , per appartenere , e per essere parente . c. 247.
Attentarsi vale arrischiarsi. c. 243.
Attor-
/ BEGIN PAGE 489 /
Attorno preposizione vuole il dativo , c. 362.
Avanti preposizione vale ante , e riceve l’accusativo ,
e ’l dativo , e talvolta il genitivo, e l’ablativo. c.353.
Significa ancora alla presenza , col dativo , e coll’a-
blativo . ivi. Avanti avverbio , oltre il significato
di ante , riceve anche quello di potius . c.377.
Avere Verbo . Sua conjugazione . c. 100. Suo partici-
pio in che differente nella costruzione da quello di es-
sere . c. 103. Avere quando si adoperi nella conjuga-
zione de’ Verbi . c. 104. Quando si usi per eßere .
c. 105. Aver luogo della Quarta degl’impersonali va-
le esser necessario. c. 263. Avere per figura enallage
si usa per riputare , per ritenere, per intendere, o
sapere , o per procacciare. c. 424.
Avvegnachè congiunzione ama il soggiuntivo , ma pur
riceve l’indicativo . c. 400.
Avvenire impersonale si usa della Terza col genitivo .
c. 259
Avvenirsi della Terza de’ Neutri passivi si usa per ab-
battersi , per convenire , e per avere attitudine .
c. 247. Per incontrarsi è della Quinta de’ Neutri pas-
sivi . c. 250.
Avverbio che cosa sia . c.17. Di quante sorte . c. 165.
e segu. Come sia differente dalle altre parti . c. 168.
Avverbj si usano in vece de’ nomi comparativi. c. 22 .
Costruzione dell’ avverbio. c. 365. e segu.
Avvisarsi talora vale accorgersi, talora deliberare. c. 243.
Avvolgersi vale andar girando . c. 250.
B
Bastare della Terza de’ Neutri vale avere idoneità , o
tempo . c. 220.
Battere riceve il caso dell’ arme colla preposizione di.
c. 203.
Bello ripieno come si usi . c. 156. Bella aggiunto a pau-
ra val grande . c. 426.
Ben-
/ BEGIN PAGE 490 /
Benchè congiunzione il più ha il soggiuntivo , ma tro-
vasi coll’ indicativo. c. 399.
Bene avverbio si usa per molto . c. 377. E per afferma-
re o solo , o col sì . ivi. E per bensì. ivi . E per ap-
provare , co’ verbi essere , e stare . c. 378. E per es-
ser conveniente , col verbo stare . ivi . E per piena-
mente , perfettamente . ivi. E per eßer utile , col
verbo mettere. c.379. Bene ripieno come si usi.c.155.
Bere Verbo anomalo . Sua conjugazione secondo il mi-
glior uso. c. 133.
Bisognare impersonale vale opus esse . c. 256.
Braccio ha due plurali . c. 40.
Brigarsi vale ingegnarsi . c. 243.
Bucinarsi impersonale vale parlarsi di una cosa di sop-
piatto . c. 258.
Budello ha due plurali . c. 40.
C
C lettera quanti suoni abbia . c. 434.
Cadere anomalo , e sua conjugazione . c. 118. Neutral-
mente si usa per venire. c. 231. Impersonale vale ap-
partenere .c. 262. Cader per mano vale venir l’ occa-
sione . ivi. Impersonale colla preposizione in val ve-
nire, occorrere . c. 265.
Caggere Verbo difettivo , e sue voci . c. 141.
Calcagno ha due plurali . c. 40.
Calere Verbo difettivo , e sue voci. c. 141. Vale im-
portare. c. 262.
Canzone ha due singolari , e due plurali . c. 39.
Capere , o capire Verbo è sempre neutro . c. 231.
Carro ha due plurali . c. 40.
Casa , quando singolarmente significa patria , riceve
nello stato in luogo la preposizione a . c. 266. Stare
a casa usato dal Boccaccio per istar di casa . ivi . Si
usa senz’ articolo . c. 312. Quando si tolga , o no, il
segno al genitivo dipendente da casa . c. 315.
Casi
/ BEGIN PAGE 491 /
Casi di tempo. c. 283. D’ istromento , o di mezzo. ivi.
Di cagione . c. 284. Di fine . c.285. Di modo . ivi.
Di compagnia . c. 286.
Castello ha due plurali . c. 40.
Centinajo fa nel plurale centinaja . c. 41.
Cercine è mascolino . c. 27. Ha l’accento in sulla pri-
ma sillaba . c. 469.
Che quanti suoni abbia . c. 435.
Che pronome relativo di sustanza , e sua declinazione.
c. 68. Relativo di qualità , o di quantità . c. 69. Ri-
ceve l’ articolo , e ’l segnacaso . ivi . Si usa per nel
quale . ivi .
Che congiunzione si usa in vece d’ il che nelle parentesi.
c. 409. E‵ interrogativo tacito , o espresso . c. 410.
Vale spesso l’ut , e ’l quod de’ Latini , il più col sog-
giuntivo , è talvolta coll’ indicativo . ivi . Si trala-
scia alle volte , singolarmente mettendo in sua vece
un non . ivi . Si usa per se non , parte, tra , perchè
interrogativo , imperocchè , e finchè . c. 410. , e segu.
In principio di clausola imprecativa vale utinam.
c. 411. Si trova usato per acciocchè . c. 402.
Chi pronome relativo . Sua declinazione. c. 69.
Chiesa si usa talora senz’ articolo . c. 312.
Ci particella pronominale . c. 47. Quando si dica ce.
ivi . Serve spesso d’accompagnaverbo . c. 164. Nello
stato in luogo ci , e ce si adoperano per qui , e qua .
c. 268. Nel moto a luogo ci si usa per significare a
questo , o a cotesto luogo . c. 276. Nelle distanze de’
luoghi ci si adopera per accennarne il rapporto.c.281.
Ciascuno , ciascuna pronomi distributivi , che non han-
no plurale . c. 77. Si adoperano addiettivamente , e
sustantivamente . ivi . Colla particella per avanti ac-
cennano il contingente , che dee distribuirsi fra più
persone . c. 77. 78.
Ciglio ha due plurali . c. 40.
Ciò pronome dimostrativo di cosa . c.67.
Cioè
/ BEGIN PAGE 492 /
Cioè congiunzione dichiarativa. c.409. Cioè a dire vale
lo stesso . ivi .
Circa preposizione si trova col genitivo , col dativo, e
coll’ accusativo . c. 351. Non è troppo usata dal Boc-
caccio . ivi .
Città si usa talvolta senz’ articolo . c. 312.
Coglier cagione a uno vale accusarlo, incolparlo. c. 196.
Cognomi il più non hanno l’ articolo , ma pure alcuni
l’ hanno dall’ uso . c. 309. Quando hanno forza di
nome proprio hanno l’articolo . ivi .
Colà vale in quel luogo , o a quel luogo. c. 269. e 276.
Colui , colei pronomi , e loro declinazione . c. 62. Co-
lei si trova usato di persona ideale , e di cosa inani-
mata . ivi . Quando lasci il segnacaso . c. 317.
Come avverbio comparativo , e sua costruzione . c. 369.
Si usa in senso di quanto co’ Verbi essere , ed avere .
ivi . Assoluto si usa per quando , e per in qualunque
maniera . c. 379. Come prima vale tostochè . c. 387.
Come congiunzione vale in che maniera . c. 411. Coll’
interrogativo vale il quid de’ Latini . ivi . Si usa in
vece di perchè interrogativo . ivi . E per quanto, poi-
chè , qualmente . c. 412. Talvolta contiene in se la
forza del relativo . ivi .
Comechè congiunzione suole avere la corrispondenza di
nondimeno , pure &c. ma si usa ancora senza. c. 399.
Suol mandare al soggiuntivo , ma si trova coll’ indi-
cativo . ivi .
Comparativo , e sua costruzione . c. 324.
Comporre con uno vale restar seco in appuntamento .
c. 231.
Con preposizione accenna istromento , compagnia , e
modo , e serve all’ ablativo . c. 339. Si affigge a’
pronomi me , te , se, lasciando la n ; e ancora a noi ,
e voi , ma oggi solamente in verso . ivi .
Conciossiachè , conciossiacosachè &c. congiunzioni di ca-
gione , e loro costruzione . c. 403.
Con-
/ BEGIN PAGE 493 /
Condurre si usa per indurre . c. 200.
Confeßarsi è della Terza de’ Neutri passivi , ma talvol-
ta per proprietà di lingua riceve il caso colla preposi-
zione da . c. 246.
Confidarsi si trova col genitivo di persona . c. 252.
Confortarsi vale concepir fidanza . c. 243.
Congiunzione che cosa sia. c.17. Di quante sorte.c.170.
In che sia differente dalle altre parti . c. 171. Sua co-
struzione . c. 397.
Conoscere anomalo , e sua conjugazione. c. 133.
Conoscersi di una cosa vale intendersene . c. 243.
Consonanti , e loro pronunzia . c. 434.
Contado si usa spesso senz’ articolo. c. 312.
Contendere altrui una cosa vale impedirgliene il conse-
guimento . c. 195.
Contentarsi talora vale esser soddisfatto , talora accon-
sentire . c. 241.
Contra , contro , preposizioni dinotanti opposizione ,
ammettono il genitivo , il dativo , e l’ accusativo .
c. 356. Non è vero che col dativo debba dirsi contro ,
e non mai contra. ivi . Vagliono talvolta rincontro ,
a rimpetto . c. 357.
Contuttochè ama il soggiuntivo , ma si trova coll’ indi-
cativo . c. 400.
Convenire coll’ accompagnaverbo si fa della Sesta de’
Neutri. c. 231. Convenire impersonale . c. 257. Si
usa a modo di personale,ma col senso d’impersonale .
ivi . Talvolta vale eßer neceßario. ivi .
Conversare coll’ accompagnaverbo si trova della Sesta
de’ Neutri . c. 231.
Convertirsi una somma in una cosa vale essere erogata ,
o spesa . c. 253.
Convitare vale invitare a convito . c. 200.
Coprire anomalo. c. 136.
Corno ha due plurali . c. 40.
Correre si trova conjugato con essere, e con avere. c.105.
Cor-
/ BEGIN PAGE 494 /
Correre agli occhi , alla vista &c. vale abbattersi a ve-
dere &c. c. 223.
Corte si può talvolta usare senz’ articolo . c. 312.
Corvo è di genere promiscuo . c. 29.
Così avverbio ha spesso la corrispondenza di come , la
quale talvolta si tace con grazia . c. 379. Così fat-
tamente , così fatto sono modi avverbiali molto usi-
tati . ivi .
Così si adopera a modo d’ interiezione in buona , e in
cattiva parte . c. 397.
Così si usa per adunque congiunzione . c. 409.
Costì , costà vagliono in cotesto luogo , o a cotesto luogo.
Loro uso . c. 269. e 276.
Costruzione toscana. Sua idea generale. c. 173. Costru-
zione figurata . c. 412. , e segu.
Costui , costei pronomi , e loro declinazione. c. 55. Si
trovano usati di bestie , e di cose inanimate. ivi. Si
usano nel genitivo senza segno,e quando. ivi, e c.317.
Cotale lo stesso che tale . c. 82. Riceve l’articolo , e ’l
pronome dimostrativo . ivi . Si usa talvolta per un
certo . ivi .
Cotanto avverbio vale tanto . c. 372.
Cotesti , cotesta pronomi , e loro declinazione . c. 55.
Nel nominativo singolare cotesti si dice d’uomo, e
vale l’ uomo prossimo a chi ascolta . c. 56.
Cotesto pronome neutro , che si adopera sustantivo , e
addiettivo . c. 67.
Cotestui pronome , e sua declinazione. c. 56. Vale lo
stesso che cotesti . ivi .
Credere quando sia della Terza de’ Neutri . c. 213.
Crescere si usa attivo per allevare . c. 188.
Cui pronome relativo di persona , e sua declinazione.
c. 69. Talvolta in genitivo ha avanti l’ articolo , ma
non è suo. c. 70. Si usa per relativo di bestie , e di
cose inanimate. ivi. Quando lasci il segnacaso.
c. 317.
Da
/ BEGIN PAGE 495 /
Da segno dell’ablativo. c. 30. Preposizione , e sua co-
struzione . c. 332. Fa le veci di di , e di a . ivi. Co’
pronomi primitivi ha forza di solo . ivi . Talvolta ac-
cenna cagione , e vale ob . ivi . Talvolta la patria
particolare . ivi . Significa talora attitudine , o con-
venevolezza. c. 333. Vale alle volte in circa . ivi .
Coll’ infinito , o col nome vale di che, onde . ivi .
Cogli avverbj molto , poco , tanto , niente , bene , più
accenna abilità . ivi . Innanzi a verbo, o a nome può
dinotar convenienza , o necessità , e come. c. 324.
Ne’ giuramenti dinota convenienza alla qualità della
persona , che parla. ivi .
Da altra parte , o dall’ altra parte vale a rincontro
c. 385.
Da capo avverbio vale l’iterum de’ Latini . c. 379. E
alcuna volta da principio . ivi .
Dallato preposizione serve al dativo . c. 361.
Da ogni parte avverbialmente vale affatto . c. 386.
Da parte avverbio vale seorsim . c. 385.
Da per tutto avverbio vale ubique . c. 271.
Dappoi . V. Dipoi .
Da prima avverbio vale la prima volta . c. 387.
Dare anomalo, e sua conjugazione . c. 110.
Darsi a una cosa vale applicarvisi. c. 247.
Darsi in su una cosa vale lasciarsi andare dietro essa .
c. 251.
Dativo comune . c. 282.
Dattorno preposizione serve al dativo . c. 362.
Davanti preposizione vale alla presenza , e si usa col
dativo , coll’ accusativo , e coll’ ablativo, e di rado
col genitivo . c. 353.
Davanti è ancora avverbio di tempo. Bocc. Introd. Al-
quanti anni davanti nelle parti orientali incomin-
ciata .
Declinazioni de’ nomi . c. 34.
Degna-
/ BEGIN PAGE 496 /
Degnare val mostrar di apprezzare altrui . c. 215.
Deh interiezione deprecativa, che suole aver dopo il
vocativo . c. 296.
Dentro preposizione significa la parte interna , e ha or-
dinariamente il dativo , ma riceve anche l’ accusati-
vo , e si trova col genitivo , e coll’ ablativo. c. 340.
Desso , dessa pronomi hanno il solo nominativo. c. 63.
Talvolta non dimostrano persona , ma cosa . ivi . Si
usano per colui , colei. c. 64. Deßo neutralmente si
usa per così proprio , così appunto . ivi .
Deviare si usa per degenerare . c. 234.
Di preposizione , e sua costruzione . c. 327. Fa le veci
di a , da , con , per . ivi . Serve all’accusativo, e all’
ablativo in forza d’ ex , e d’ inter . c. 329. Talora è
segno di particolarità , e vale alcuni , alquanti. ivi.
Dinota talora figliuolanza . ivi . E‵ ancora contras-
segno , o titolo , ma incorporata coll’articolo . ivi .
Di segno del genitivo . c. 30.
Di ripieno , e suo uso. c. 161.
Dialogo fa nel plurale dialogi , e dialoghi. c. 42.
Dianzi avverbio vale poco fa . c. 372. Gli si aggiugne
talvolta poco . ivi .
Di contra , di contro preposizioni servono all’ accusa-
tivo . c. 364.
Di costa preposizione serve al dativo . c. 361.
Di dietro preposizione , lo stesso che dietro , e vuole il
dativo , ma si trova coll’ablativo. c. 355.
Dietro preposizione vale il post , e ’l retro de’ Latini , e
vuole il dativo . c. 355. Cogl’ infiniti de’ verbi sem-
bra avere l’ accusativo . ivi . Si trova coll’ ablati-
vo . ivi .
Di fuori preposizione , in senso di fuori , serve all’ a-
blativo . c. 365.
Di lungi preposizione serve all’ ablativo. c. 365.
Dimane per lo dì vegnente è mascolino, ma per lo prin-
cipio del giorno è femminino . c. 28.
Dimen-
/ BEGIN PAGE 497 /
Dimenticare si usa impersonale . c. 261.
Dimorare si usa coll’ accompagnaverbo . c. 231.
Dinanzi preposizione vale dalla parte anteriore,e serve
comunemente al dativo , benchè si usi ancora col ge-
nitivo , coll’ accusativo , e coll’ablativo. c. 354.
Vale talvolta alla presenza , appreßo . ivi . Si usa
avverbio in senso di avanti , contrario di dopo, e di
dietro . Dante Inf. cant. 20. Ed indietro venir gli
convenía , Perchè il veder dinanzi era lor tolto .
Dintorno preposizione serve al dativo . c. 362.
Di nuovo avverbio vale e iterum,e noviter. c. 379.380.
Dio quando si usi con articolo, quando no . c. 308. Ge-
nitivo dipendente da mercè , o grazia , quando lasci
il segnacaso. c. 316.
Di poco avverbio vale poco tempo avanti . c. 380. E va-
le talvolta per poco . ivi.
Di poi , e dappoi sono avverbj , che non sogliono ado-
perarsi in forza di preposizioni, ma si usa dopo. c. 386.
Questi avverbj ricevono dopo di se il che , ma nol ri-
ceve già la preposizione dopo . c. 387. Si trovano usa-
ti con iperbato . ivi . E con ellissi del poi . ivi . Di
poi avverbio val poscia . c. 386.
Diportarsi si usa per ricrearsi . c. 238.
Di presente avverbio significa subito , immantenente.
c. 372. Di presente che vale subito che . ivi .
Di presso preposizione serve al dativo . c. 363.
Di qua , di là preposizioni servono all’ ablativo.c.365.
Dire anomalo , e sua conjugazione . c. 129.
Dirimpetto preposizione serve al dativo . c. 362.
Dirincontro preposizione serve al dativo. ivi .
Dirsi con alcuno vale esser suo amico. c. 253.
Discosto preposizione si addatta al dativo , e all’ ablati-
vo . c. 350.
Disdire si usa per proibire . c. 195.
Disertarsi vale andare in rovina . c. 238.
Diservire val nuocere . c. 192.
I i Di
/ BEGIN PAGE 498 /
Di sopra preposizione si addatta al dativo , al genitivo,
all’ accusativo , e all’ ablativo . c. 363.
Di sotto preposizione ha il dativo , e talora il genitivo,
l’ accusativo , e l’ ablativo . c. 363.
Dispensare con uno vale disobbligarlo dalla legge comu-
ne . c. 232.
Distanza d’ un luogo dall’ altro che caso voglia. c. 280.
Distornare vale svolgere , distorre . c. 205.
Di su, o d’ in su preposizione serve all’accusativo.c.365.
Di tanto avverbio lo stesso che tanto . c. 372.
Ditello ha due plurali . c. 40.
Dito ha due plurali . c. 40.
Dittongo che cosa sia . c. 13. I Dittonghi altri sono di-
stesi , altri raccolti . ivi . Quando si tolga via il dit-
tongo . c. 440.
Divellere significa lo stesso che in Latino . c. 205.
Divenire per accadere si usa dal Boccaccio a modo di
personale della Prima de’ Neutri, ma il senso è d’im-
personale . c. 260.
Domandare si usa per interrogare , o per chieder di al-
cuna persona . c. 188.
Donde nel moto da luogo ha in se la forza del relativo .
c. 273.
Dopo preposizione serve all’ accusativo , e dimostra or-
dine di luogo , di tempo , o di azione , e vale post ,
retro. c. 355. Riceve ancora il dativo , e talvolta il
genitivo . c. 356.
Dormire si trova conjugato e con essere , e con avere .
c. 105.
Dote ha due singolari , e due plurali . c. 39.
Dove come si usi nello stato in luogo. c. 270. Rileva il
caso del moto per luogo , colla forza del relativo .
c. 274. Riceve senso avversativo . 381. E‵ talvol-
ta congiunzione avversativa . c. 404.
Dove sustantivamente significa luogo . c. 271.
Dovere anomalo , e sua conjugazione. c. 120. Si ado-
pera
/ BEGIN PAGE 499 /
pera nella formazione de’ futuri dell’ infinito degli
altri verbi. c.110. Come si usi con pleonasmo. c.420.
Dovunque , dovechè , dove che sia vagliono ubicunque .
c. 271.
Dunque congiunzione illativa . c. 408.
Durare si usa per sostenere, mantenere . c. 225.
E
E congiunzione copulativa . c. 405. Talvolta si replica
con tutte le parole da essa congiunte , talvolta si ta-
ce . ivi .
Eccetto preposizione vuole l’ ablativo . c. 358.
Ecclissi è mascolino . c. 27.
Ecco ripieno come si usi . c. 155.
Ecco avverbio ha dopo di se o un nominativo , o un’ in-
finito , o una proposizione , a cui talora precede la
particella che : e avanti di se non di rado ha la con-
giunzione e. c. 366. Riceve gli affissi dell’ articolo,
e de’ pronomi . c. 367. Posto irrisoriamente ha il
caso senz’ articolo . ivi. Eccoti si usa per ecco senza
relazione a persona . ivi .
Ecco si usa in forza di congiunzione per adunque. c. 408.
Egli pronome , e sua declinazione . c. 57. Accenna per-
sona , ma si trova usato di bestia , e di cosa inanima-
ta . ivi . Egli si trova in caso obbliquo . c. 58. Elli ,
ello , elli , ellino per voci d’ egli si trovano presso gli
Antichi . ivi .
Egli ripieno come si usi . c. 159.
Eleggere si trova col dativo ulteriore . c. 198.
Elemento del parlare che cosa sia, e di quante sorte.
c. 10.
Ella pronome , e sua declinazione. c. 59. Ella ne’ casi
obbliqui si trova negli Antichi. c. 60.
Ellissi figura come si usi . c. 413. e segu.
Enallage figura come si usi . c. 421.
Entrare quando riceva la preposizione ad . c. 227.
I i 2 Entro
/ BEGIN PAGE 500 /
Entro preposizione ha comunemente l’ accusativo , ma
riceve ancora il dativo . c. 340. Le si prepone , per
proprietà di lingua , la particella per . ivi .
Erede , benchè detto di femmina , si può far mascoli-
no . c. 198.
Esercitarsi si usa per passeggiare . c. 238.
Essere verbo , e sua conjugazione . c. 95. Suo partici-
Pio. c. 100. In che sia differente nella costruzione il
participio di essere da quello di avere . c. 103. Essere
quando si adoperi nella conjugazione de’ verbi .
c. 104. Si trova usato per avere . c. 106. Si trova
coll’ accusativo dopo . c. 211. Si trova singolare ac-
cordato col plurale . c. 112. Talvolta ha dopo di se
la preposizione ad . c. 229. Essere impersonale in si-
gnificato di trovarsi. 258. E in significato di esser ve-
ro . ivi . Essere colla particella a , congiunto coll’infi-
nito di altro verbo , rileva il significato di esso cor-
rispondente al modo , e al tempo di se . c. 291.
Essere al Mondo vale starsi, o collocarsi nel secolo. c.229.
Esser bene , o male di alcuno vale eßere in sua grazia ,
o disgrazia . c. 217.
Essere in su una cosa vale applicarvisi . c. 232.
Esso , eßa pronomi , e loro declinazione . c.62. Quan-
do sieno addiettivi , e quando sustantivi . ivi.
Eßo ripieno come si usi . c. 159.
F
Fallare impersonale per mancare. c. 262.
Fallir della promessa vale mancar di parola. 218.
Fare anomalo , e sua conjugazione . c. 111. Si usa per
riputare . c. 198. E per dar taccia . ivi . E per di-
sporre . c. 215. E per proccurare. c. 424. E si usa in
luogo di verbo precedente , che altri non voglia re-
plicare . ivi .
Fare impersonale vale importare . c. 262. E vale anco-
ra esser utile,coll’accusativo,e la preposizione per.ivi.
Far
/ BEGIN PAGE 501 /
Far forza impersonalmente vale importare . c. 259.
Far luogo impersonalmente vale abbisognare. c. 263.
Far vedere per dare ad intendere . c. 195.
Farsi a un luogo vale sporgersi, affacciarsi. c. 247. e 425.
Farsi con Dio come si usi per restare, o andarsene. c. 425.
Farsi a credere si usa per credere . ivi .
Fattamente avverbio, con avanti la particella sì, o così,
vale in tal modo . c. 372.
Fatto si usa per uomo , personaggio &c. c. 426.
Ferire riceve il caso dell’arme colla preposizione di .
c. 203.
Festa si usa talvolta senz’ articolo . c. 312.
Filo ha due plurali . c. 40.
Finchè , finattantochè avverbj servono al moto fino a
luogo , e come. c. 279.
Fine nome è di genere comune . c. 26.
Fine dell’ azione in che caso si metta . c. 285.
Fiocine è mascolino. c. 28. Ha l’ accento in sulla pri-
ma sillaba . c. 469.
Fondamento ha due plurali . c. 40.
Fronte è di genere comune . c. 26.
Fornire val provvedere . c. 192.
Forte avverbio vale ad alta voce . c. 380. E gagliarda-
mente . ivi . E profondamente . ivi . E molto . ivi .
E dinota talvolta vemenza d’animo . ivi .
Fra preposizione . Sua costruzione . Vedi Tra .
Fra me , fra se , fra loro accenna l’ interno della perso-
na . c. 346.
Fra si usa per di , o da nel primo termine d’uno spazio
di tempo , colla corrispondenza della preposizione e
nel secondo termine . c. 346.
Framettersi vale ingerirsi . c. 243.
Frate talora sustantivo, talora addiettivo. c. 18. Quan-
do è innanzi al suo sustantivo, scaccia l’articolo.c.311.
Frode ha due singolari , e due plurali. c. 39.
Fronde ha due singolari , e due plurali . c. 39.
I i 3 Frut-
/ BEGIN PAGE 502 /
Frutto ha tre plurali . c. 40.
Fuggire sua costruzione . c. 234. Si usa per trafugare .
c. 188. Fuggir l’ animo ad alcuno vale mancargli ,
venirgli meno . c. 222.
Fune è di genere comune . c. 26.
Fuora , fuori , fuore preposizione separativa vuole il
genitivo , o siasi ablativo , ma si trova ancora coll’
accusativo . c. 340. Si usa ancora in forza di prepo-
sizione eccettuativa , posponendole che , ovvero so-
lamente . c. 358.
Fuso ha due plurali . c. 40.
G
G lettera quanti suoni abbia. c. 436.
Garrire vale sgridare . c. 220.
Generi de’ nomi . c. 25.
Genesi è di genere comune . c. 26.
Gerundio che cosa sia , e delle sue proprietà. c. 149.
Fa talvolta le veci di caso del verbo . c. 178. Sua co-
struzione . c. 297. Dipende da un verbo , che lo de-
termini . ivi . Talvolta è indipendente da verbo , e
fa le veci del participio presente , ma col nominati-
vo . c. 298. Ha talora il nominativo avanti . ivi . Si
trova assoluto coll’ ablativo d’ egli , o d’ ella. c. 299.
Infinito col verbo mandare sta in vece dell’ infinito .
ivi . Si trova in caso obbliquo in vece del participio
presente , o di un modo finito del verbo. c. 300. Co’
verbi andare , e venire significa frequenza , e suc-
cessione di azione. Ivi. E in tal caso si trovano andare,
e venire fatti gerundj , e così doppio gerundio . ivi.
Il gerundio non riceve sciolte le particelle , ma affis-
se , se non se in qualche caso . c. 301. Talvolta lascia
del tutto l’affisso . ivi . Riceve avanti elegantemente
la particella in . c. 302. Col participio preterito di
avere , e di eßere , prende il senso di perfetto , o di
trapassato . c. 303. Il gerundio di essere co’ participj
de’
/ BEGIN PAGE 503 /
de’ verbi intransitivi può avere senso attivo. ivi . Se
il gerundio senza participio preterito si trovi usato
in senso passivo . c. 301.
Gesto ha tre plurali . c. 40.
Gh quanti suoni abbia. c. 436.
Già avverbio si usa per nondimeno. c. 380. E per for-
se . c. 381.
Già ripieno come si usi . 157.
Giammai avverbio vale unquam, C+ 381,
Ginocchio ha due plurali . c. 40.
Giovare si usa per dilettare , piacere . c. 220.
Giovarsi vale approffittarsi . c. 244.
Gire verbo difettivo . Sue voci . c. 140.
Gittarsi d’un luogo vale uscirne impetuosamente . c. 244.
Giù nello stato in luogo si adopera da se, e senz’ aggiun-
to . c. 270. Serve al moto da luogo , accennando la
parte più alta per primo termine . c. 273. Colla pre-
posizione in , e l’articolo innanzi , serve al moto ver-
so luogo . c. 278.
Giusta , giusto preposizioni di conformità vogliono l’ac-
cusativo , ma pur si trovano col dativo . c. 357.
Gli quanti suoni abbia. c. 436.
Gliele , gliene affissi pronominali indeclinabili . c. 431.
Gn qual suono abbia . c. 437.
Granello ha due plurali . c. 40.
Gravare attivo per affaticare . c. 192.
Guai interiezione di minaccia , o di dolore ha il dati-
vo . c. 369.
Guari avverbio significa molto , ma quasi sempre colla
negativa . c. 372. Si usa in forza di nome , e vale
molto. c. 373.
H
H da alcuni è chiamata mezza lettera , e perchè. c. 10.
Quale sia il suo uso nella nostra lingua . c. 437.
I i 4 Iddio
/ BEGIN PAGE 504 /
I
Iddio quando si usi con articolo , e quando no . c. 308.
Iddio il dica per me , modo equivalente ad interiezione
ammirativa . c. 423.
Importare impersonale, presso i Moderni vale eßer d’in-
teresse , o di cura . c. 261.
Imprima avverbio si usa per proprietà di lingua in vece
di prima . c. 388.
In preposizione . Sua costruzione . c. 334. S’ incorpo-
ra coll’ articolo, a cui talora si aggiugne . ivi. Si
usa in vece d’ a, per , con, sopra , dentro, contro ,
verso , intorno , nello spazio , a maniera &c. Si usa
co’ verbi e di stato , e di moto . c. 334. e segu. Di-
nota alcuna volta età indeterminata fra due termini
distanti . c. 336.
Incontro preposizione ha il dativo . c. 362.
Indi vale da quel luogo . c. 272. Vale anche per quel
luogo . c. 274.
In disparte avverbio vale seorsim . c. 385.
Infignersi val dissimulare . c. 215.
Infinchè , infinattantochè come servano al moto infino
a luogo. c. 279.
Infiniti de’ verbi come si costruiscano. c. 286. Dipen-
dono da un verbo finito , che li determini . c. 287.
Quelli de’ verbi attivi , senza variar la loro voce ,
ricevono il senso passivo . ivi . Quelli de’ neutri pas-
sivi , anche senz’ affisso , ricevono il senso neutro pas-
sivo . ivi . Quando l’ infinito riceva l’accusativo in-
nanzi alla latina . c. 288. Quando riceva il nomina-
tivo dopo . ivi .
Infinito colla particella di innanzi , o in forza del ge-
rundio in di de’ Latini , o per proprietà di lingua .
c. 289. Colla particella a innanzi rileva i gerundj , i
supini , i futuri , e i participiali latini , e talvolta è
proprietà di lingua . ivi , e segu. Colla particella da
innanzi rileva parimente gerundj , futuri , e partici-
piali
/ BEGIN PAGE 505 /
piali latini . c. 292. Colla stessa particella da rileva
il significato finito di un’ altro verbo . c. 293. Colla
particella per rileva diversi significati . c. 294. Con
altre particelle equivale al gerundio toscano. c. 295.
Dopo alcuni pronomi , e avverbj ha la forza del sog-
giuntivo . c. 293. Coll’ articolo singolare equivale
al gerundio nostro . c. 295.
Infinito in singolare si usa a maniera di nome , con arti-
colo , e senza . ivi . In vece dell’ articolo riceve tal-
volta per eleganza la preposizione a . c. 296. In plu-
rale ancora si usa a modo di nome . ivi . Sospeso si usa
da persona appassionata . c. 297.
Infra preposizione serve all’ accusativo . c. 364.
Inframettersi , intramettersi vagliono ingerirsi . c. 243.
In fuori vale eccetto , ma gli si prepone la cosa eccet-
tuata in ablativo colla preposizione . c. 358.
In mezzo preposizione vuole il genitivo , ma riceve an-
che l’accusativo . c. 360. e seg.
Innanzi preposizione di tempo , e di luogo , ha il dati-
vo , e l’accusativo . c. 354. Si usa per sopra, più che,
e alla presenza . ivi .
In prova avverbio vale apposta . c. 373.
In punto avverb. significa in prossima disposizione.c.373.
In quel torno, modo avverbiale, vale circa , e si dice or-
dinariamente di numero . c. 373.
In quanto, in questo, in quello, in quella modi avverbia-
li vagliono in questa , in quell’ora, in questo , in quel
punto . c. 373. Talvolta a tali avverbj si mette dopo
la particella che . ivi .
Insieme avverbio vuol 1’ ablativo con preposizione , a
cui si aggiugne talvolta meco , seco &c. c. 368.
In somma congiunzione conclusiva . c. 409.
Intanto posto assolutamente vale interim. c. 381. Corre-
lativo d’ in quanto vale per tale,o per tanta parte. ivi.
Interiezione che cosa sia . c. 17. Di quante sorte ne sie-
no . c. 169. Sua costruzione. c. 395.
Intop-
/ BEGIN PAGE 506 /
Intopparsi vale incontrarsi. c. 250.
Intorno preposizione serve al dativo . c. 362.
Intra preposizione serve all’ accusativo . c. 364.
Inverso preposizione . V. Verso .
In uno , in una , modi avverbiali , vagliono unà , si-
mul . c. 76.
Io pronome , e sua declinazione . c. 46. Particelle, che
ne fanno le veci . ivi .
Iperbato figura , e sue spezie . c. 426.
Ire verbo difettivo, e sue voci . c. 140.
Ivi vale in quel luogo . c. 270. Colla misura della di-
stanza in dativo , vale da quel luogo. c. 282.
K
K lettera in toscano si esprime col ch . c. 9. Si fa di ge-
nere mascolino . ivi.
L
La per ella non è da usarsi . c. 60.
Là avverbio vale in quel luogo. 269. Come abbia talora
la corrispondenza di qua, e qui . ivi . Di là significa
talvolta nell’ altro Mondo. c. 270.
Laddove avverbio vale purchè . c. 381. Riceve senso av-
versativo . ivi .
Laddove congiunzione avversativa. c. 404.
Lasciare stare val præterire . c. 189.
Leggere verbo , e sua conjugazione . c. 123.
Legno ha due plurali. c. 40.
Lei per ella è errore . c. 60. Lei si trova nel dativo sen-
za segno . ivi . Si trova riferito a bestia . ivi.
Lenzuolo ha due plurali . c. 40.
Lepre è di genere promiscuo . c. 29.
Lettere altre sono vocali , altre consonanti . c. 10. Vo-
cali come rilevino suono. c. 12. Consonanti di quan-
te sorte sieno . c. 11. Nomi delle consonanti come si
debbano pronunziare. ivi . Di qual genere sieno .
c. 12. Maggiori , e minori come si usino . c. 461.
Levare impersonale vale importare . c. 258.
Levare
/ BEGIN PAGE 507 /
Levare dal sagro fonte vale tenere al battesimo . c. 206.
Levarsi a romore , o in superbia . c. 250.
Levarsi diritto vale levarsi in piedi . c. 240.
Lode ha due singolari , e due plurali . c. 39.
Lontano si addatta agli stessi casi , che lungi , ed è usa-
to dal Boccaccio nel Decamerone . c. 350.
Lui per egli , loro per eglino è errore . c. 58. Lui per
egli si trova col verbo essere . ivi . E si trova talvolta
con altro verbo . ivi . Lui , loro quando lascino il
segnacaso . c. 317. 318.
Luccio è di genere promiscuo . c. 29.
Luna ha plurale . c. 44.
Lungi preposizione vuole l’ablativo , ma riceve ancora
il dativo . c. 349.
Lungo preposizione vuole l’accusativo , ma riceve an-
cora il dativo, e in verso talvolta il genitivo . c. 349.
Co’ verbi di moto accenna moto per lo verso della
lunghezza di una cosa . ivi .
M
Ma congiunzione avversativa . c. 404. Corregge tal-
volta le cose dette , e vale anzi . ivi . Ma che ? va-
le il sed quid ? de’ Latini . ivi .
Macina ha due singolari , e due plurali . c. 39.
Madama ha il suo sustantivo coll’ articolo . c. 311.
Maestro si usa e sustantivo , e addiettivo . c. 18. Sustan-
tivamente posto riceve l’ articolo ; posto addiettiva-
mente non suol riceverlo , ma pur talvolta l’ammet-
te . c. 311.
Mai ripieno come si usi . c. 157.
Mai avverbio vale unquam . c. 381. Per farlo negare
gli si aggiugne la negativa . ivi . Si trova in senso di
nunquam senza la negativa . c. 382. Quando il mai
precede alla negativa , amendue precedono al verbo;
ma quando la negativa precede al mai , questo si può
e antiporre , e posporre al verbo , benchè più spesso
si tro-
/ BEGIN PAGE 508 /
si trovi posposto . ivi . Mai si usa talora in vece di
sempre. ivi . Unito al sempre, gli accresce forza. ivi.
Male avverbio , oltre a malamente , vale ancora poco ,
difficilmente. c. 382.
Mancare vale destitui , deficere , carere . c. 216.
Margine per estremità è di genere comune ; ma per ci-
catrice è femminino. c. 28.
Medesimo , medesima pronomi , e loro declinazione.
c. 64. Il dir medemo , medema è errore . ivi . Medes-
mo è voce poetica . ivi . Medesimo coll’articolo , o
con pronome neutro vale illud , idem. c. 65. In ve-
ce di medesimo si dice talvolta uno . ivi .
Meglio avverbio ha ordinariamente il genitivo , ma si
trova col dativo, e coll’ accusativo . c. 368. Gli si
aggiugne talora l’articolo . ivi . Si usa elegantemen-
te per più , e piuttosto . c. 408.
Membro ha due plurali . c. 41.
Menare la vita , o i giorni . c. 225.
Menare smanie , menare orgoglio . c. 192.
Mendico fa nel plurale mendici , e mendichi . c. 42.
Meno avverbio ha talvolta il genitivo di materia. c.368.
Mercè si usa avverbialmente in senso di per grazia , per
cortesia ; e come si costruisca . c. 370. Si usa a modo
di sustantivo , e come. ivi .
Metodo è mascolino . c. 28.
Mettere si usa per isboccare . c. 228.
Mezzo in senso di metà non si accorda col femminino ,
di cui accenna metà . c. 181.
Mezzo avverbio si usa per quasi . c. 374.
Mi particella pronominale. c. 46. Quando si dica me .
c. 47.
Mi accompagnaverbo. c. 163.
Mica ripieno come si usi . c. 158.
Migliajo fa nel plurale le migliaja. c. 41.
Miglio fa nel plurale le miglia . c. 41.
Mio pronome , e sua declinazione, c. 50. Quando ri-
ceva
/ BEGIN PAGE 509 /
ceva , o lasci l’ articolo , o altro appoggio . ivi .
Modo in che caso si metta . c. 285.
Moggio fa nel plurale le moggia . c. 41.
Monsignore anticamente aveva il suo sustantivo coll’ar-
ticolo , ma oggi non è in uso . c. 311.
Montare impersonale vale importare. c. 258. Si usa del-
la Quarta degl’ impersonali . c. 263.
Morire anomalo , e sua conjugazione . c. 137. Ne’ pre-
teriti si usa attivo per uccidere. c. 190. E in tal sen-
so riceve elegantemente il caso d’ instromento colla
preposizione di . c. 203.
Morire di checchessia vale esserne fieramente innamora-
to . c. 217.
Morir di suo male significa morir di morte naturale .
c. 217.
Mostrare impersonale vale apparire . c. 259.
Moto da luogo vuol l’ablativo colle preposizioni da , o
di . c. 272. Gli avverbj di stato , aggiugnendovi le
dette preposizioni , servono a questo moto . ivi .
Moto per luogo vuole l’ accusativo colla preposizione
per . c. 273. Riceve talora in vece la particella vi .
c. 274. Quando il passaggio non è per un luogo, ma
vicino ad esso , si usa la preposizione da . ivi .
Moto a luogo vuol l’ accusativo colla preposizione a .
c. 275. Se però il termine del moto è un Regno, una
Provincia , o pure un luogo non chiaramente circo-
scritto , si usa la preposizione in . ivi . E questa par-
ticella altresì si adopera quando il moto a luogo ha
forza d’ ingresso nel luogo. c. 276. Come a questo
moto servano anche gli avverbj di stato . ivi .
Moto verso luogo vuole l’accusativo colla preposizione
verso , o inverso . c. 277. E tali preposizioni ricevo-
no talvolta il genitivo . c. 278. I Poeti usano ver , o
inver per verso , o inverso . ivi . In vece di verso i
Moderni dicono alla volta col genitivo . ivi . Su , e
giù, coll’articolo innanzi, servono a questo moto. ivi.
Moto
/ BEGIN PAGE 510 /
Moto infino a luogo vuol l’ accusativo colle preposizio-
ni fino , infino , o sino. c. 279. Le dette preposizio-
ni ricevono altri casi , e altre particelle . ivi . Fin-
chè , finattantochè , infinchè , infinattantochè ser-
vono a questo moto , e mandano al soggiuntivo . ivi .
Muovere si usa per andare . c. 210. E ancora per nasce-
re , cominciare , procedere , uscire . c. 234. E per
muoversi . c. 238.
Muro ha due plurali. c. 40.
Mutare si usa per toglier alcuna cosa da un luogo. c.205.
Mutarsi d’ un luogo vale partirsene . c. 254.
N
Ne particella pronominale . c. 47.
Ne accompagnaverbo . c. 165.
Nè d’ordinario è congiunzione negativa , ma talvolta
è solamente disgiuntiva . c. 406.
Niente , nulla negativi generali ammettono l’articolo,
il segnacaso , e le preposizioni , e sembrano prono-
mi . c. 74. Quando hanno altra negativa si sogliono
posporre al verbo , e preporre quando e’ non l’ han-
no . ivi . Quando si usano per via di domanda , o di
dubbio , ovvero colla particella senza , hanno senso
affermativo . c. 75.
Niuno , nissuno , nessuno pronomi negativi generali , e
loro declinazione . c. 73. Vagliono il nemo de’ La-
tini . ivi . Si adoperano addiettivi , e sustantivi .
ivi . Con altra negazione , o a modo di domanda , o
di dubbio , affermano , e vagliono alcuno . c. 73. 74.
Si adoperano solamente nel singolare . c. 73.
No , non avverbj negativi. c. 383. No ha talora la cor-
rispondenza del sì espressa, o sottintesa . ivi . Quan-
do la negazione si ha a porre due volte in un medesi-
mo ragionare , sempre una di esse e no , o si prepon-
ga , o si posponga all’ altra. ivi . No quando è caso di
verbo riceve il segnacaso , e l’articolo . ivi . Non se
ha a
/ BEGIN PAGE 511 /
ha a negare più cose innanzi a verbo , si aggiugne a
ciascuna di esse, ma non già al verbo. ivi. Se il verbo
va innanzi, ad esso si aggiugne la negazione, si aggiun-
ga poi , o non si aggiunga alle cose negate ; benchè
l’uso porti di aggiugnerla ad esse ancora . c. 384. Non
posto interrogativamente non niega , ma vi sta come
se non vi fosse . ivi .
Nome che cosa sia. c. 17. Di quante sorte. c. 18. , e
segu. Sua costruzione . c. 308. e segu.
Nome sustantivo che cosa sia . c. 18. Sua costruzione.
c. 318. Il Boccaccio usa di porlo in mezzo a due ad-
diettivi . c. 427.
Nome addiettivo che cosa sia . c. 18. Sua costruzione.
c. 320. Posto neutralmente da sustantivo riceve geni-
tivo dipendente . c. 319.
Nomi , che si adoperano ora sustantivi , ora addietti-
vi . c. 18.
Nome proprio qual sia . c. 19. Nomi proprj delle parti
del Mondo , de’ Regni , delle Province , de’ mari ,
de’ fiumi , de’ monti &c. si trovano coll’ articolo, e
senza , onde conviene attenersi all’uso . c. 310. De-
gli uomini non hanno articolo. ivi . Delle donne si
trovano coll’ articolo , e senza . ivi . Delle Città il
più non hanno articolo , ma pur l’hanno alcuni dall’
uso . ivi . Delle dignità, col titolo innanzi , presso
gli Antichi aveano l’articolo fra ’l titolo , e ’l nome ,
ma oggi non l’hanno più se non quelli , dov’ è il tito-
lo di Madama . c. 310. Nomi , i quali significano
cose singolari , ricevono non di rado l’ articolo per
uso . c. 309.
Nome appellativo qual sia . c. 19. Vuole l’articolo.
c. 309.
Nomi primitivi , e derivativi . c. 19.
Nomi aumentativi , e diminutivi . c. 20.
Nomi comparativi . c. 21. De’ formati quanti ne sie-
no . c. 22. In loro vece si usano talvolta degli avver-
bj .
/ BEGIN PAGE 512 /
bj . ivi . Al comparativo si aggiugne talora più . ivi .
Nomi superlativi . c. 21. Come escano. c. 22. Gli An-
tichi li formavano col tra , tras, o trans . ivi . Il po-
sitivo replicato ha talvolta forza di superlativo. ivi.
Nomi partitivi . c. 23. Loro costruzione . c. 326.
Nomi numerali . c. 23. Altri sono cardinali , altri or-
dinali , altri distributivi . ivi . I cardinali si adope-
rano in forza di distributivi . c. 24. Se i cardinali so-
no addiettivi , hanno il solo plurale , ma se sono su-
stantivi , hanno amendue i numeri con diversità di
terminazione c. 43. Tre , sei , dieci , e forse due ,
adoperati sustantivi , hanno amendue i numeri , ma
senza varietà di terminazione. ivi .
Nome quanti generi abbia. c. 25. Se la nostra lingua
abbia il genere neutro. ivi. Addiettivi finienti in e ,
e dinotanti qualità , sono di genere comune. c. 26.
Nomi di genere promiscuo quali sieno . c. 29.
Nome quante declinazioni abbia . c. 34. Nomi indecli-
nabili quali sieno. c. 36. Nomi forestieri, che nel sin-
golare finiscono in consonante , sono indeclinabili .
c. 37. Nomi , che hanno l’accento in su l’ultima , so-
no indeclinabili . ivi . Ma se a’ primi si aggiugne la
vocale in fine , e i secondi si fanno interi , sono de-
clinabili . ivi . Nomi finienti in i sono ordinariamen-
te indeclinabili. c. 38. Quali nomi escano nel plurale
in ci , o chi , e quali in gi , o ghi . c. 42.
Non ripieno come si usi in Italia . c. 161.
Non pertanto avverbio vale nondimeno. c. 374.
Non piaccia a Dio vale no. c. 263.
Nostro pronome , e sua declinazione . c. 50. Quando ri-
ceva , o lasci l’ articolo , ovvero altro appoggio. ivi ,
e segu.
Nozze ha il solo plurale. c. 43. Si usa talvolta senz’ar-
ticolo. c. 312.
Nulla più avverbio vale il nihil magis de’ Latini.
c. 374.
O , oh ,
/ BEGIN PAGE 513 /
O
O , oh, oi interiezioni . Per chiamare hanno il voca-
tivo. c. 395. Nelle esclamazioni hanno il nominati-
vo . ivi . Nell’espressioni di contento, o d’afflizione,
hanno l’accusativo. ivi . E indi si formano oimè, oisè.
ivi . E in simili espressioni si tace talora l’interiezio-
ne . ivi . Nell’ espressioni di dolore , dopo l’addiet-
tivo , che accenna la miseria , si pone la persona in
dativo , per proprietà di lingua . c. 396.
Ogni pronome , e sua declinazione. c. 71.
Ogni cosa si accorda neutralmente, ma riceve ancora
1’ addiettivo femminino. c. 71. e 181.
Ognuno vale omnis quisque. c. 72. In vece di ognuno di
si dice ancora ogni uomo. ivi .
Oja , ojo presso i nostri Poeti si fanno di una sillaba so-
la . c. 457.
Olire verbo difettivo , e sue voci. c. 141.
Oltre preposizione serve al dativo , e all’ accusativo .
c. 351. Vale plusquam , supra , e anche præter esclu-
sivo . ivi . Mare , monti , Arno , modo , misura si met-
tono dopo la preposizione oltre in accusativo , e so-
vente ad essa si affiggono. c. 252. Oltra è lo stesso che
oltre , ma è più del verso , che della prosa . ivi .
Onde nel moto da luogo ha in se la forza del relativo .
c. 273.
Onde avverbio mostra talora cagione , materia , origi-
ne . c. 384.
Onde congiunzione illativa . c. 408.
Ora ripieno come si usi . c. 160.
Ora congiunzione si usa per adunque . c. 409.
Orazione toscana . Quante , e quali sieno le sue parti.
c. 16.
Ordinare si usa per restar d’ accordo . c. 202.
Ordine è di genere comune , tanto in significato di dis-
posizione , quanto di congregazione di Religiosi. c. 27.
Orecchio ha due singolari , e due plurali. c. 39.
K h Osa-
/ BEGIN PAGE 514 /
Osare come si costruisca . c. 216.
Oßo ha due plurali . c. 41.
Oste per esercito è di genere comune . c. 27.
Ove avverbio di stato in luogo come si usi . c. 270. Si
usa talvolta fuori dello stato in luogo , per quan-
do , e a rincontro . c. 384.
Ovunque , ovechè , ove che sia vagliono ubicumque .
c. 271.
P
Pagare si usa per gastigare . c. 193.
Pajo fa nel plurale le paja . c. 41.
Palagio , intendendosi il principale del luogo , può
usarsi senz’ articolo . c. 312.
Pantera è di genere promiscuo . c. 29.
Papa quando riceva , o lasci l’articolo . c. 311.
Parecchi , e parecchie mancano del singolare . c. 43.
Parentesi nome è femminino . c. 27. Regole intorno
alle parentesi . c. 428.
Parere anomalo , e sua conjugazione . c. 119. Si usa
elegantemente per apparire. c. 208.
Parola che cosa sia , e di quante sorte . c. 15. Se nelle
parole toscane altri debba proccurare di discostarsi
dal Latino. c. 16. Parole come talvolta si accresca-
no , e regole sopra ciò. c. 443. Come si scemino in
principio , o in fine. c. 445. 447. Parole composte ,
e osservazioni sopra di esse. c. 458.
Parte avverbio negli Antichi si trova usato per in-
terim. c. 385.
Particelle della lingua Toscana quali sieno . c. 429.
Participio che cosa sia. c. 17. Di quante sorte . c. 144.
Sua costruzione . c. 304. Participio presente si tro-
va spesso ne’ casi obbliqui , ma di rado in nominati-
vo. ivi . Si trova in ablativo assoluto , e coll’ affis-
so . c. 305. Participj preteriti quando sieno retti da
essere , quando da avere , e varietà della loro costru-
zio-
/ BEGIN PAGE 515 /
zione . c. 306. Posti innanzi all’ infinito , con esso
sogliono accordarsi , non col nome . c. 307. Parti-
cipj preteriti assoluti , che hanno dopo di se l’ abla-
tivo, spesso si accordano col nome, e talvolta no . ivi.
Partire , e sua costruzione . c. 233. Si usa talvolta per
allontanare . c. 205.
Passar di vita vale morire. c. 217.
Passarsi di un fallo vale dissimularlo . c. 218.
Penare si usa per indugiare . c. 221.
Pendere si usa per inclinare . c. 228.
Pensare si usa talvolta per giudicare , talvolta per de-
terminare . c. 215.
Per preposizione , e sua costruzione . c. 336. Co’ ver-
bi di moto riceve l’ accusativo alla Latina . ivi . Co’
verbi di stato , in senso d’ in , riceve l’ablativo . ivi.
Fa le veci di a , da , con . ivi . Talvolta vale il pro
de’ Latini . c. 337. Ha talora forza di benchè , qua-
lunque &c. c. 338.
Per preposizione dinota alcuna volta cagione , mezzo ,
instromento , o fine . c. 336. 337. Aggiunta a’ no-
mi , benchè sovente quasi a maniera di ripieno , pu-
re può significare in luogo , in considerazione , co-
me , e simili . c. 337. Aggiunta a’ sustantivi , ac-
cenna , nell’ uso de’ Toscani , una particolar consi-
derazione . c. 338. Talvolta è nota di distribuzio-
ne . ivi . Accenna talora mezzo d’origine . ivi . Di-
nota alcuna volta tempo , e vale durante un tale spa-
zio. ivi . Si aggiugne a’ nomi dinotanti spazio , nu-
mero , o misura . ivi .
Per preposizione preposta all’ infinito , con avanti esse-
re , o stare , rileva la forza del participio futuro de’
Latini ; o pur significa essere in procinto , o peri-
colo di fare , o farsi una cosa. c. 337. Rileva talvol-
ta la forza del gerundio . c. 339.
Perchè congiunzione si usa per acciocchè . c. 402. E per
accennar cagione, o con interrogazione , o senza. ivi.
K k 2 Per
/ BEGIN PAGE 516 /
Per conto , col genitivo , vale per cagione. c. 285.
Periodo nome è mascolino . c. 28.
Persona , parlandosi di maschio , riceve l’ addiettivo
mascolino . c. 184.
Per tal convenente vale purchè . c. 398.
Pertanto congiunzione illativa . c. 409.
Per tempo , per tempissimo avverbj vagliono a buona ,
o a bonissim’ ora . c. 393.
Per tutto vale ubique . c. 217. 374.
Per tutto addiettivo non si accorda talvolta co’ sustanti-
vi femminini . c. 180.
Per tutto ciò , per tutto questo vagliono contuttociò .
c. 374.
Più si usa col genitivo di materia . c. 367. Assoluta-
mente , ma coll’ articolo innanzi , vale plerumque .
c. 375.
Più presto , più tosto congiunzioni elettive . c. 407.
Pleonasmo figura come si usi . c. 419.
Poi avverbio di tempo vale dopo , appresso , ed è con-
trario di prima . c. 386.
Pontare vale spignere con forza . c. 228.
Porre anomalo , e sua conjugazione . c. 130.
Porre si usa per deliberare . c. 215.
Porre cagione a uno vale accusarlo , incolparlo. c. 196.
Porre pena in una cosa vale impiegarvi fatica . c. 203.
Porsi in cuore val deliberare. c. 245.
Portare come si usi per esigere. c. 425.
Portare in pace val sopportare. c. 425.
Poscia avverbio è lo stesso che poi . c. 386.
Potere anomalo , e sua conjugazione . c. 121.
Pratico fa nel plurale pratici , e pratichi . c. 42.
Prendere vale fare innamorare . c. 202. E anche inco-
minciare . c. 221.
Prendersi dell’ amore di alcuno vale innamorarsene .
c. 245.
Preposizione che cola sia. c. 17. Di quante sorte. c. 150.
In
/ BEGIN PAGE 517 /
In che sia differente dal segnacaso . c. 153. Sua co-
struzione . c. 327., e segu.
Preßo preposizione ordinariamente ha il dativo , ma
può anche ricevere il genitivo , e l’ accusativo .
c. 346. Vale talvolta circa , intorno . c. 347. Si usa
per in comparazione , in paragone . ivi .
Presto eßere val pronto . c. 221.
Preteriti della Seconda conjugazione come si formino .
c. 116. E come quelli della Terza . c. 125.
Pria , e pria che sono il più voci poetiche . c. 388.
Pria congiunzione si usa in vece di piuttosto . c. 408.
Prima , e primachè avverbj . c. 388. Vagliono alcuna
volta potiusquam . ivi . Colla negativa prima vale
talvolta infinattantochè , talvolta subito che . ivi .
In forza di congiunzione si usa in vece di piutto-
sto . c. 408. Si usa talvolta in forza di preposizione
col genitivo, e vale avanti , innanzi . c. 355.
Progenie , prole non hanno plurale . c. 45.
Pronome che cosa sia . c. 17. Di quante sorte. ivi , e
segu. Sua costruzione . c. 326. Pronomi primiti-
vi , e relativi si chiamano le particelle , e come .
c. 429.
Prosciogliere vale aßolvere . c. 206.
Punti , e loro uso . c. 462.
Punto avverbio significa niente . c. 375. Si usa per
qualche poco . ivi . E per mica . ivi .
Punto ripieno come si usi . c. 158.
Purchè congiunzione ha forza di se , ma ha maggio-
re efficacia , ed ama il soggiuntivo . c. 398.
Pure avverbio vale almeno . c. 388. E certamente. ivi.
E finalmente . ivi . E solamente. c. 389.
Pure congiunzione avversativa . c. 404.
Pure ripieno come si usi . c. 156.
Putire come si usi per dispiacere . 220.
K k 3 Q da
/ BEGIN PAGE 518 /
Q da alcuni si chiama mezza lettera , e perchè . c. 10.
Qua come si adoperi nello stato in luogo . c. 267. E
nel moto a luogo . c. 276.
Quadrello ha due plurali . c. 41.
Qualche pronome indefinito, e sua declinazione . c. 78.
Serve invariato ad amendue i numeri . ivi . E‵ sem-
pre addiettivo . ivi .
Qualcuno , qualcheduno pronomi si regolano come al-
cuno . c. 79.
Quale pronome relativo . c. 67. Senz’ articolo dinota
qualità assoluta . c. 68. In vece di quale si dice tal-
volta onde . ivi . Quale vale talora chi distributivo .
c. 80. Talora chiunque . ivi . Se ha l’ articolo , con-
corda coll’ antecedente , ma s’ e’ non l’ha , e signi-
fica qualità, o somiglianza , concorda con ciò , che
siegue .
Qualunque, qualsisia , qualsivoglia , quando non espri-
mono la forza del relativo , vagliono ciascuno .
c. 78.
Quando avverbio di tempo . c. 389. Replicato vale
talora . ivi . Di quando in quando vale alle volte .
ivi. Quando che sia vale una volta finalmente , o
in qualche tempo . ivi .
Quando congiunzione si usa in senso di se , o purchè .
c. 398.
Quanto si usa in forza di preposizione coll’ accusativo .
c. 360. E in forza d’avverbio col dativo , e talvolta
col verbo essere . c. 370.
Quanto avverbio di quantità . c. 389. Ha la corrispon-
denza di tanto espressa , o sottintesa . c. 390. Trat-
tandosi di tempo vale quamdiu . ivi .
Quantunque congiunzione vuole il soggiuntivo .
c. 399.
Quasi avverbio vale ferè . c. 375. Si usa per veluti .
ivi . E per come se . ivi .
Quegli
/ BEGIN PAGE 519 /
Quegli pronome , e sua declinazione . c. 61. Si trova
in nominativo non riferito ad uomo . ivi . Quello
per quegli in nominativo si trova riferito ad uo-
mo. ivi . Quegli si trova ne’ casi obbliqui del singo-
lare riferito ad uomo . ivi .
Quella pronome , e sua declinazione . c. 62.
Quello pronome dimostrativo di cosa . c. 67.
Questa pronome , e sua declinazione . c. 54. E‵ ordi-
nariamente addiettivo , ma trovasi ancora sustan-
tivo . ivi . Questa , queste sustantivamente in nomi-
nativo vagliono questa donna , queste donne . ivi .
Questi pronome , e sua declinazione . c. 53. Questo in
nominativo per questi è errore . ivi . Questi in no-
minativo si trova non riferito ad uomo . c. 54.
Questo pronome dimostrativo di cosa . c. 66.
Qui quando si adoperi nello stato in luogo . c. 267.
E nel moto a luogo. c. 276. Qui, e di qua vaglio-
no talvolta in questo Mondo . c. 268.
Quinci vale da questo luogo . c. 272.
Quindi vale da quel luogo . c. 272. E ancora per quel
luogo . c. 274.
Quindi congiunzione illativa . c. 408.
Quivi vale in quel luogo . c. 270. E ancora a quel
luogo . c. 276.
R
Raccomandare si usa per legare . c. 200.
Racconciare si usa per rappacificare . c. 203.
Rasente preposizione vale tanto vicino , ch’ e’ si toc-
chi quasi una cosa . c. 349. Vuole l’accusativo, ma
riceve ancora il dativo . ivi .
Ratto avverbio val prestamente , e raddoppiato accen-
na prestezza maggiore . c. 375.
Re quando abbia articolo , quando no . c. 311.
Recare si usa per riferire . c. 195. E per indurre .
c. 201.
K k 4 Recarsi
/ BEGIN PAGE 520 /
Recarsi assoluto , e anche col caso , vale talvolta pren-
dere una offesa come fatta a se . c. 239. Vale talora
ridursi . c. 250.
Recarsi ubbia di una cosa vale averne ubbia . c. 426.
Recarsi cortese vale avvolgere insieme le braccia , e ap-
poggiarle al petto . c. 426.
Redine ha due singolari , e due plurali . c. 39.
Redire verbo difettivo , e sue voci . c. 141.
Rendere la grazia val perdonare . c. 196.
Rendersi si usa per farsi . c. 425.
Requie è indeclinabile . c. 38.
Ricercarsi impersonale vale opus esse . c. 256.
Richiamarsi vale dolersi . c. 244.
Riconoscere una cosa da uno vale confessare d’ averla
ricevuta per sua grazia . c. 205.
Ricoprire anomalo . c. 136.
Ricordare si usa per nominare . c. 188. Si usa anche
impersonale . c. 261.
Ricoverare si usa per rifuggire in senso neutro, e neu-
tro passivo . c. 228. e 252.
Ricredersi vale pentirsi . c. 244.
Ridere a uno val mostrarsegli amico per ingannarlo .
c. 221.
Rifarsi vale acquistare , farsi bello &c. c. 244.
Rifinare val desistere . c. 216.
Rilevare impersonale vale importare , ed è della
Seconda , ma si fa ancora della Quarta . c. 258.
e 263.
Rimanersi val cessare , o astenersi . c. 238 e 244.
Rimettere nell’ arbitrio di alcuno una cosa . c. 201.
Rimprocciare vale biasimar con ischerno . c. 193.
Rintuzzarsi l’ animo di alcuna cosa vale distorsene .
c. 245.
Ripararsi vale rifuggire . c. 252.
Ripieno che cosa sia , e di quante sorte . c. 154.
Ripigliare val riprendere . c. 193.
Ripo-
/ BEGIN PAGE 521 /
Riposarsi si usa per cessare . c. 239. c. 254.
Risentirsi si usa per isvegliarsi . c. 239.
Riserbarsi vale trasferire in altro tempo . c. 250.
Risieder bene vale convenire . c. 232.
Riso ha due plurali . c. 41.
Ritornar sopra capo vale ridondare in danno . c. 229.
Ritrarre vale svolgere , distogliere . c. 206. Ritrarre
da uno neutralmente vale somigliarlo . c. 234.
Ritrarsi come si usi per partire da un luogo , o per di-
stogliersi da una deliberazione . c. 254.
Ritrovarsi con uno vale esser con lui . c. 253.
Rompere assoluto , e rompere in mare vagliono far nau-
fragio . c. 208.
Rondine è di genere promiscuo. c. 29.
Rubare si usa per ispogliare . c. 188.
S
S lettera quanti suoni abbia . c. 438.
Sacco ha due plurali . c. 41.
Salire anomalo . c. 136.
Salvatico fa nel plurale salvatici , e salvatichi . c. 42.
Salvo preposizione riceve l’ ablativo , o sia quel caso ,
con cui rilevar sogliamo l’ ablativo latino . c. 359.
Santa ragione si usa per molto . c. 426.
Santo , Santa , avanti al loro sustantivo posti , scac-
ciano 1’ articolo . c. 311.
Sapere anomalo , e sua conjugazione . c. 119.
Saper grado vale professare obbligazione . c. 222.
Scarafaggio è di genere promiscuo . c. 29.
Scegliere anomalo , e sua conjugazione . c. 131.
Sceverare val separare . c. 205.
Sciogliere anomalo , e sua conjugazione . c. 130.
Scontrarsi gli occhi con uno vale vedersi reciprocamen-
te . c. 253.
Scoprire anomalo , e sua conjugazione . c. 136.
K k 5 Scor-
/ BEGIN PAGE 522 /
Scorgere uno val guidarlo . c. 200. Col verbo fare si
usa per burlare . c. 239.
Scure ha due singulari , e due plurali . c. 39.
Se pronome , e sua declinazione . c. 49. Come la par-
ticella si ne faccia le veci . ivi . Se posto sustan-
tivamente , e coll’ articolo , significa 1’ interno .
c. 50.
Se congiunzione condizionale porta all’ indicativo , o
al soggiuntivo, secondochè esige la sua ipotesi. c. 397.
E‵ talora dubitativa , e vale l’ utrum de’ Latini. ivi.
Si usa per benchè , c. 400.
Seco medesimo ha forza d’avverbio , onde si dice anche
di femmina . c. 339.
Secondo preposizione di conformità vuole l’ accusati-
vo . c. 357. Si usa in senso di per quanto comporta
l’ eßere , o la qualità di alcuna persona , o cosa , e
in tal caso ha l’accusativo , ma senz’ articolo , o pro-
nome . ivi .
Sedere anomalo , e sua conjugazione . c. 119. Si usa
per regnare . c. 208.
Segnacaso che cosa sia , e quanti ne sieno . c. 30. In
che sia differente dalla preposizione . c. 153. Si la-
scia talora in alcuno di più nomi continuati . c. 318.
Talvolta è affatto scioperato. ivi .
Sempre avverbio di tempo vale o senza intermissione ,
o ogni volta . c. 390. Semprechè vale ogni volta che.
ivi . E talvolta mentre che . ivi . Sempre mai sem-
bra avere maggior forza . ivi .
Se non che avverbio vale nisi , c. 391. E‵ ancora con-
giunzione . 404.
Se non se avverbio vale nisi , e talora il secondo se pa-
re che abbia forza di forse . c. 391.
Sentire verbo , e sua conjugazione. c. 133. Si usa per
conoscere . c. 188. E per credere . c. 198. E per aver
qualità . c. 217.
Sentire avanti vale penetrar colla cognizione . c. 209.
Sen-
/ BEGIN PAGE 523 /
Sentirsi, o sentir di se come si usino per aver senso.
c. 217. e 239.
Senza preposizione separativa , che ha l’ ablativo , o
siasi altro caso , che rileva il caso de’ Latini . c. 359.
Si usa talvolta per oltre . ivi . Riceve ancora l’ in-
finito , il participio , e ’l gerundio . ivi .
Senza che modo avverbiale vale præterquamquod , ov-
vero oltre che . c. 375. e 391.
Senza modo avverbiale vale smisuratamente . c. 376.
Senza più modo avverbiale vale solùm , dumtaxat .
c. 376.
Serbarsi a fare vale indugiare . c. 247.
Servire si usa per prestare , o dare . c. 192. E per re-
stituire . c. 195.
Se tu sai modo avverbiale , che vale il quantumlibet
de’ Latini . c. 376.
Si accompagnaverbo . c. 164.
Sì ripieno come si usi . c. 160.
Sì avverbio affermativo. c. 383. Quando è caso di
verbo , gli si prepone il segnacaso , o l’ articolo .
ivi .
Sì , avverbio di vario uso , si adopera per così . c. 391.
E per nondimeno . ivi . E per infinchè . ivi . Gli
corrisponde talora il che , o il come . ivi . Si trova
replicato in forza del tum de’ Latini . c. 392.
Sillaba che cosa sia . c. 12. Niuna comincia da due
medesime consonanti . c. 14. Sillabe come si tron-
chino , e regole sopra ciò . c. 441. Sillabe brevi ,
o lunghe , e qualche osservazioni sopra ciò . c. 468.
Sillessi figura gramaticale . c. 421.
Sinodo è mascolino . c. 28.
Sì veramente congiunzione vale con patto , con con-
dizione . c. 398.
Sofferir l’ animo , o ’l cuore vale aver animo , coraggio ,
e si usa negativamente . c. 217.
Solamente , solo avverbj limitativi . c. 392. Col che
dopo
/ BEGIN PAGE 524 /
dopo vagliono purchè . ivi . Non solamente è avver-
bio correlativo di ma . ivi . Sol tanto è lo stesso che
solamente . ivi .
Sole ha plurale . c. 44.
Solenne si usa per grande , eccellente , magnifico .
c. 426.
Solere verbo difettivo , e sue voci . c. 142.
Sopra preposizione il più ha l’ accusativo , non di rado
riceve il dativo , e talvolta il genitivo . c. 341. Si
adopera per di là da , oltre , più che . ivi . E per
contro , addosso , appresso , vicino . ivi . E in vece
di per , circa , intorno , innanzi , avanti . ivi , e
c. 342. Accenna talvolta pegno . ivi . Si usa elegan-
temente in vece di allato , addoßo . c. 363.
Sopra ciò accenna soprantendenza a qualche uficio .
c. 343. Sopracciò si usa a modo di nome , e signi-
fica il soprantendente all’ uficio , di cui si parla .
ivi .
Sopra parto , o sopra partorire vale in quell’ atto , o
poco dopo . c. 342.
Sopra sera vale già venuta la sera . c. 342.
Sopra se vale pensoso , o diritto in sulla persona , o non
appoggiato . c. 342.
Soprannomi femminini dati a maschio si trovano coll’
addiettivo mascolino . c. 181.
Soprastare si usa per indugiare . c. 221.
Sospirare si usa della Terza de’ Neutri per desidera-
re . c. 220.
Sostenere si usa per comportare , per permettere , per
arrestare. c. 189. E per reggere , resistere . c. 221.
Sotto preposizione ha d’ ordinario l’accusativo , ma ri-
ceve anche il genitivo , e ’l dativo. c. 343. Si ado-
pera talvolta in significato di con . ivi .
Spacciarsi vale spedirsi . c. 254.
Spegnere anomalo , e sua conjugazione . c. 132.
Sperare si usa per aspettare . c. 192.
Spe-
/ BEGIN PAGE 525 /
Spezie è indeclinabile . c. 38. Spezie per droghe ha il
solo plurale . c. 43.
Sposare una donna a moglie è maniera elegante del
buon secolo . c. 201.
Stajo fa nel plurale le staja . c. 41.
Stare anomalo , e sua conjugazione . c. 111. Si usa
della Terza de’ Neutri per toccare . c. 221. Si usa
ancora per essere . c. 212. E per consistere . c. 231. E
per costare . c. 232. Stare per alcuno val dipendere
una cosa da lui . c. 229. Stare congiunto coll’ infi-
nito di altro verbo , mediante la particella a , rile-
va il significato di esso secondo il suo tempo , e mo-
do . c. 292.
Star bene si usa per convenire , per meritare , e per es-
ser ben disposto . c. 222.
Star cortese vale tener le mani giunte, e appoggiate al
petto . c. 426.
Starsi quante significazioni possa avere . c. 239.
Stato in luogo vuol l’ablativo colla preposizione in .
c. 266. Negli Antichi si trova spesso colla preposi-
zione a . ivi .
Steßo , stessa pronomi . c. 65.
Stirpe non ha plurale . c. 45.
Su nello stato in luogo si usa da se , e senz’ aggiunto .
c. 270. Coll’ articolo innanzi , e la preposizione in ,
serve al moto verso luogo . c. 278.
Su preposizione , e suo uso . c. 364. Serve all’ accusa-
tivo . ivi . I migliori Autori dicono più volentieri
in su , che su. c. 365.
Suo pronome , e sua declinazione . c. 50. Quando ri-
ceva , o lasci l’ articolo , o altro appoggio. ivi ,
e segu.
Suora avanti al suo sustantivo scaccia l’articolo . c. 311.
Superficie è indeclinabile . c. 38.
Superlativi , e loro costruzione . c. 325.
Supplire si trova della Terza de’ Neutri . c. 220.
Tale
/ BEGIN PAGE 526 /
T
Tale si usa alle volte per qualcuno , alcuno in amen-
due i generi . c. 79. E anche per talmente avver-
bio . c. 376 .
Tale pronome di qualità , e sua declinazione . c. 81.
Ha spesso la corrispondenza di quale , cotale , o che ;
ma si usa talvolta senza . ivi . Posto neutralmente
dinota miseria. ivi . Nell’ uso riceve articolo , e
pronome . c. 82.
Tanto avverbio di quantità. c. 392. Segna lunghezza
di tempo . ivi . Ha la corrispondenza di che , o di
quanto . c. 393.
Tema per argomento è di genere comune. c. 27.
Temere verbo , e sua conjugazione . c. 114.
Tempo in che caso si metta . c. 283.
Tenere anomalo , e sua conjugazione . c. 120. Come si
usi per pigliare nello imperativo . c. 189. Si usa in
senso di vietar l’ ingresso. c. 196. E per giudicare .
c. 198. E per aver qualità. c. 215. E per aderire .
c. 232.
Tener credenza vale tener segreto. c. 196.
Tener favella vale restar di parlare ad alcuno per isde-
gno . c. 196.
Tenersi assoluto si usa per arrestarsi , o per avere opi-
nione di se . c. 240.
Tentato eßere di fare una cosa vale averne voglia .
c. 245.
Testè avverbio vale in questo punto , o poco avanti .
c. 376.
Ti particella pronominale . c. 48. Quando si dica
te . ivi .
Ti accompagnaverbo, e suo uso . c. 164.
Tirare si usa per aver la mira , l’ intenzione . c. 228.
Toccare impersonale vale talvolta l’ attinet , talvolta
l’ obtingit de’ Latini . c. 261. Attivamente si usa per
commuovere . c. 190.
Toglie-
/ BEGIN PAGE 527 /
Togliere anomalo , e sua conjugazione . c. 131. Si usa
per prendere , e per levare , aggiugnendogli la par-
ticella via . c. 189.
Toglier di vita , di terra , o del Mondo vagliono am-
mazzare . c. 206.
Tordo è di genere promiscuo . c. 29.
Tornare si usa per riporre . c. 203. E per riuscire .
c. 222. E per eßere di nuovo ciò, ch’ altri era. c. 212.
E per ridondare . c. 228.
Tornar bene vale essere di utile , o di piacere . c. 222.
Torre il capo , o la testa a uno vale infastidirlo .
c. 196.
Toße ha due singolari , e due plurali . c. 39.
Tosto avverbio vale subito. c. 376.
Tra preposizione , che significa in mezzo , vuole l’ac-
cusativo . c. 344. Congiunta con una sola cosa accen-
na rinchiudimento in quella ; e con due cose signi-
fica il comprendimento in mezzo ad amendue . ivi .
Vale talvolta per mezzo. ivi . Talora vale nella
conversazione , nel numero , nella compagnia . ivi .
Si adopera in vece d’ in . ivi . Accenna talora per-
plessità . c. 345. Si usa per addentro , fuori , oltre ,
sopra . ivi . Si usa per distinguere , e insieme con-
giugnere due cose , e ha sempre in corrispondenza
la congiunzione e . ivi .
Tramettersi vale ingerirsi . c. 243.
Trapaßare si usa per morire . c. 209.
Trarre assoluto , parlando di cavalli , muli &c., val
tirar calci . c. 209. Si usa ancora in significato di ac-
correre , concorrere . c. 210. E in tal senso si fa anche
della Quinta de’ Neutri . c. 227.
Trarsi si usa per condursi . c. 250.
Trasandare assoluto vale eccedere i termini del convene-
vole . c. 209.
Trasognare assoluto val farneticare . c. 209.
Tribolarsi di una cola vale affliggersene . c. 244.
Trit-
/ BEGIN PAGE 528 /
Trittongo che cosa sia . c. 13. In esso qual sia la princi-
pal vocale . c. 14.
Troppo avverbio è spesso usato dal Boccaccio per molto .
c. 394.
Trovare si usa per sentire . c. 198.
Tu pronome , e sua declinazione. c. 47. Particelle ,
che ne fanno le veci . ivi .
Tuo pronome , e sua declinazione . c. 50. Quando ri-
ceva , o lasci l’ articolo , o altro appoggio . ivi ,
e segu.
Tutto quando sia nome , quando pronome . c. 72. Sua
declinazione da pronome . ivi . Si adopera il più
nel plurale . ivi . Si usa però nel singolare co’ no-
mi collettivi . ivi . Accenna talora quantità virtua-
le . c. 73. Colle voci dinotanti numero vi si po-
ne la congiunzione e per proprietà di linguaggio.
ivi .
Tutto ripieno come si usi . c. 158.
Tutto quanto vale prorsus omnis . c. 73.
V
Valere si usa della Terza de’ Neutri per giovare. c. 220.
Si usa attivo per meritare , e come . c. 189. Si ado-
pera anche impersonale per giovare . c. 258.
Vanni per penne ha il solo plurale . c. 43.
Variare si usa neutro per essere differente . c. 235.
Udire anomalo , e sua conjugazione . c. 138.
Vecchia aggiunto a paura val grande . c. 426.
Vedere anomalo , e sua conjugazione . c. 122.
Vedi si usa per ecco , ed ha il caso senz’ articolo .
c. 367.
Venire anomalo , e sua conjugazione . c. 137. Si usa
talvolta per divenire . c. 212. E per incorrere. c. 228.
Impersonale , con qualche addiettivo , vale riusci-
re . c. 263. Venire da una cosa vale uscirne odore , o
puz-
/ BEGIN PAGE 529 /
puzzo . c. 264. Venire come si usi colla figura pleo-
nasmo . c. 420.
Venire a capo val conchiudere . c. 229.
Venire a grado val piacere . c. 222.
Venire il destro vale presentarsi l’opportunità . c. 263.
Venire in concio vale essere opportuno c. 222.
Venir meno una cosa a uno vale mancargli . c. 222. Ve-
nir meno a uno , dopo averle promesso alcuna cosa ,
vale mancar di parola. c. 223.
Ver , o in ver dicono i Poeti in vece di verso , e in ver-
so . c. 278.
Verbo che cosa sia. c. 17. Di quante sorte ne sieno .
c. 87. e 88. Variazioni del verbo . c. 89., e segu.
Osservazioni generali sopra le conjugazioni de’ ver-
bi . c. 91.
Verbi attivi , e loro costruzione. c. 185. Verbi passi-
vi , e loro costruzione. 207. Verbi assoluti quali
sieno . c. 208. Verbi neutri . c. 210. Verbi neutri
passivi . c. 235. Verbi impersonali . c. 143. e 256.
Verbi locali. c. 265.
Verso preposizione quando si dà al tempo , o al luogo
vuole l’ accusativo ; ma quando si dà a persona , ri-
ceve il genitivo. c. 351. Sì usa per in comparazio-
ne , in paragone . c. 350. E per intorno , circa . ivi .
Veruno per se è lo stesso che niuno . c. 74. Con altra
negativa , o colla particella senza, vale alcuno . ivi.
Veste ha due singolari , e due plurali. c. 39.
Vestimento ha due plurali . c. 41.
Vestirsi ha il caso dell’ abito o in accusativo , o in geni-
tivo , o siasi ablativo , colla preposizione di . c. 248.
Vi particella pronominale . c. 48. Quando si dica ve .
ivi .
Vi accompagnaverbo . c. 164.
Vi si usa per significare a questo, o a cotesto luogo .
c. 276.
Via ripieno come si usi. c. 159.
Via
/ BEGIN PAGE 530 /
Via ne’ moti a’ luogo significa andare altrove . c. 277.
Via , vie avverbj vagliono molto . c. 394. Via vale tal-
volta orsù . ivi . Via via si usa per subito . ivi .
Vicino preposizione serve al genitivo , e al dativo .
c. 348. Si usa per circa , intorno . c. 349. E anche
in vece del parum abest de’ Latini . ivi .
Vipera è di genere promiscuo . c. 29.
Virgola , e suo uso . c. 465.
Vivere si usa per nutrirsi . c. 216.
Uno , una sustantivi possono avere plurale . c. 44.
Uno affisso ad altro numero manca del plurale ; e il su-
stantivo , che l’ accompagna , se va avanti , si fa
plurale , se dopo , singolare. c. 44. e 45.
Uno , una , pronomi distributivi , e loro declinazione.
c. 76. Correlativo ad altro ha singolare , e plurale ,
e ammette l’ articolo . c. 77.
Uno , una , accompagnanomi in quanti modi si usino .
c. 162.
Un tempo avverbialmente vale per qualche tempo. c.394.
Vocali , e loro pronunzia . c. 434.
Volere anomalo , e sua conjugazione . c. 121.
Voler bene idiotismo per esprimere guastamento , o di-
sordine . c. 223.
Volersi impersonale si usa in varj modi per convenire .
c. 259.
Volgere anomalo , e sua conjugazione . c. 131. Si usa
per iscorrere di tempo . c. 209.
Vostro pronome , e sua declinazione . c. 50. Quando
riceva , o lasci l’ articolo , o altro appoggio . ivi ,
e segu.
Uovo fa nel plurale le uova . c. 41.
Usare si adopera per frequentare e coll’ accusativo , e
col dativo . c. 189. e 221. E per bazzicare . c. 209.
E per costumare . c. 216. E per conversare . c. 232.
Uscire anomalo , e sua conjugazione . c. 138.
X si
/ BEGIN PAGE 531 /
X
X si rileva in Toscano colla s semplice , o doppia .
c. 9. Talvolta si usa come carattere forestiero . ivi .
Z
Z quanti suoni abbia nella lingua Toscana . 438.
IL FINE.
—————————————————————
Vidit D. Paulus Philippus Premoli Clericorum Regu-
larium Sancti Pauli , & in Ecclesia Metropolita-
na Bononia Pænitentiarius pro SS. D. N. Benedi-
cto X1V , Archiepiscopo Bononia .
Die 27. Januarii 1745.
IMPRIMATUR
Fr. Jo: Franciscus Cremona Vicarius Generalis S. Of-
ficii Bononia .
DON
/ BEGIN PAGE 532 /
DON FRANCISCUS CAJETANUS
SOLA
Congregationis S. Pauli Præpositus
Generalis .
QUum librum , cui titulus est Regole , ed
Oßervazioni della Lingua Toscana ridot-
te a metodo per uso del Seminario di Bo-
logna a R. P. Don Salvatore Corticelli Con-
gregationis nostræ Præsbytero professo, ac
Provinciæ ætruriæ Præposito compositum
duo ejusdem Congregationis nostræ eruditi
Viri , quibus id commisimus, accurata le-
ctione, & gravi judicio recognoverint, &
posse in lucem edi probaverint : Nos, ut
typis mandetur , quantum in Nobis est ,
facultatem facimus. In quorum fidem has
fieri, sigilloque nostro muniri jussimus .
Dat. Mediolani ex Collegio SS. Apostolorum
Pauli, & Barnabæ tertio Idus Februarii An-
no salutis MDCCVL.
D. Franciscus Cajetanus Sola Præp. Gen.
Don Philippus Maria Brambilla Cancellarius .
/ BEGIN PAGE 533 /
Alcuni errori scorsi nella presente Opera .
Errata Corrige .
pag. 299. v. 16. E un tal modo dire. E un tal modo di
dire .
pag. 315. v. 20. Osservazione terza . Osservazione se-
conda.
pag. 317. v. 4. Ed abbiamo innan- Ed abbiano innan-
zi l’articolo . zi l’articolo .
Si noti , che pag. 99. manca l’ esempio di saria per
sarei . Il Cinonio nel Trattato de’ Verbi cap. 38.
dice , che il dir saria per sarei è voce poetica ,
benchè alcune volte nelle prose si legga , ma non ne
adduce esempio . Il Buommattei Tratt. 12. cap. 33.
parimente ne ammette l’uso , ma neppur egli ne ci-
ta esempio . Io non ho potuto trovarlo usato da buo-
no Autore , e perciò stimo giusto il sentimento del
Ruscelli nel Rimario , cioè , che la terminazione in
ia nelle terze persone dell’ imperfetto , e de’ pre-
teriti dell’ Ottativo si possa liberamente usare in
vece della uscita in ebbe : ma nelle prime persone ,
in vece della terminazione in ei, si voglia usar di
rado , o forse solamente in Verso , e per necessità
di rima .
Si noti ancora , che trovandosi per entro l’ opera sie-
gue , siegua , sieguono , sono parole scorse per inav-
vertenza , dovendosi in buona lingua dire segue ,
segua , seguono . E lo stesso dico di truovare , truo-
vato , e simili , dovendovisi fognare la u , come in
altri luoghi del libro si vede .
/ BEGIN PAGE 534 /
/ BEGIN PAGE 535 /
/ BEGIN PAGE 536 /