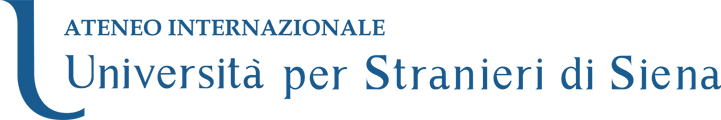Cuoricini d’oro
II. Libro di lettura per la seconda classe maschile e femminile Approvato dal Ministero per tutte le scuole d’Italia Nuova edizione riveduta e corretta Con illustrazioni dell’artista fiorentino Anichini Letture educative per le cinque classi elementari maschili e femminili secondo i nuovi programmi governativi del 29 Novembre 1894 e le ultime istruzioni ministeriali
Autore:
Emma Perodi | Perodi Emma
Indice
Indice
I [p. 5]
II, p. 6
III, p. 6
IV, p. 7
V, p. 8
VI, p. 8
VII, p. 9
VIII, p. 9
Emilia e Gino, p. 10
I capricci di Gino, p. 11
Gino riflette, p. 12
Il ritorno a scuola, p. 13
Amore verso i Maestri, p. 14
Amore verso i compagni, p. 15
La disgrazia di Bianca, p. 16
La cucina e i suoi arredi, p. 17
La lezione continua, p. 19
Buone amiche, p. 20
In casa di Bianca, p. 21
La visita a Bianca, p. 23
All’ospedale, p. 24
La mamma mia (poesia), p. 26
In giardino, p. 27
La vendemmia, p. 28
La festa della Maestra, p. 31
Una gioia meritata, p. 32
Le cose pericolose, p. 34
I consigli della maestra, p. 35
Il vaso rotto, p. 36
La moneta trovata, p. 38
All’Ufficio municipale, p. 40
Le monete, p. 42
A che cosa servono le monete, p. 44
La carità, p. 45
La preghiera interrotta, p. 48
Dio è presente ovunque (poesia), p. 51
Dal chicco al granaio, p. 51
Dal granaio al forno, p. 53
L’abbondanza (poesia), p. 55
I pettirossi, p. 56
La canzonetta delle stagioni (poesia), p. 58
Gli alberi, p. 59
Il legname, p. 61
Al giardino pubblico, p. 62
La pianta d’amorino, p. 66
I vegetali, p. 67
Le piante tessili, p. 69
L’albero di Natale, p. 70
Gli augurj di Natale (poesia), p. 73
Le paure di Sandrino, p. 73
L’orto della zia Balbina, p. 76
Un arrivo inatteso, p. 77
Come Rita e Gabriele passarono il capo d’anno, p. 79
Nel regno della zia Balbina, p. 81
Nel pollaio della zia Balbina, p. 83
Nella stalla della zia Balbina, p. 85
Per capo d’anno (alla mamma) (poesia), p. 88
La divisione dell’anno, p. 89
Tempo e stagioni, p. 91
Chi ha tempo non aspetti tempo, p. 93
Il 9 Gennaio, p. 95
Il cuore di Vittorio Emanuele II, p. 97
La patria, p. 100
L’Italia, p. 102
La bandiera d’Italia, p. 103
Italia (poesia), p. 106
I colori, p. 106
Un giorno di neve, p. 108
Il corpo umano, p. 111
L’arrivo del Re, p. 113
La bontà del Re Umberto, p. 114
A S. M. la Regina d’Italia (poesia), p. 116
La luce, p. 117
La luce artificiale, p. 119
Il cieco, p. 121
I sensi, p. 123
Il signor Versacci, p. 125
Maggio (poesia), p. 128
La scuola, p. 128
Il difetto di Lina, p. 132
Un’erba preziosa, p. 134
Le tre bambine, p. 134
Le case, p. 136
La casa imbandierata, p. 137
I mestieri, p. 141
Non mi sta bene, p. 143
Gli animali, p. 145
Tutti lavorano, p. 147
Voci degli animali (poesia), p. 150
I minerali, p. 151
Gli amici del contadino, p. 153
L’ultimo giorno di scuola, p. 155
Indice [p. 159]
Testo in formato elettronico
/ BEGIN PAGE [I] /
CUORICINI D’ORO
PER LA SECONDA CLASSE
MASCHILE e FEMMINILE
/ BEGIN PAGE [II] /
EMMA PERODI
CUORICINI D’ORO
LETTURE EDUCATIVE PER LE CINQUE CLASSI ELEMENTARI
maschili e femminili
Secondo gli ultimi programmi governativi 29 nov. 1894
Illustrate da cento artistici acquarelli di Anichini e Sarri
Approvate dal Ministero
per tutte le scuole d’Italia
(Bollettino Ministero Istruz. Pubb. 8 Sett. e 6 Ott. 1898)
Per le classi maschili e femminili
I. Sillabario, per la prima classe elementare (1° semestre) un
elegante volume illustrato … L. 0,20
I. Compimento al Sillabario, per la prima classe elemen-
tare (2° semestre) … " 0,20
II. Libro di lettura per la seconda classe elementare " 0,60
III. Libro di lettura per la terza classe elementare … " 1,00
|
PER LE CLASSI MASCHILI
|
PER LE CLASSI FEMMINILI
|
|
IV. Libro di lettura per la quar- ta classe elementare L. 1, 20 |
IV. Libro di lettura per la quar- ta classe elementare L. 1, 20 |
|
V. Libro di lettura per la quin- ta classe elementare L. 1, 50 |
V. Libro di lettura per la quin- ta classe elementare L. 1, 50 |
/ BEGIN PAGE [III] /
DI
Emma Perodi
Letture educative per le cinque classi elementari
MASCHILI E FEMMINILI
SECONDO I NUOVI PROGRAMMI GOVERNATIVI DEL 29 NOVEMBRE 1894
E LE ULTIME ISTRUZIONI MINISTERIALI
II.
LIBRO DI LETTURA
PER LA SECONDA CLASSE
MASCHILE e FEMMINILE
Approvato dal Ministero
per tutte le scuole d’Italia
Nuova edizione riveduta e corretta
Con illustrazioni dell’artista fiorentino Anichini
Casa Editrice
SALVATORE BIONDO
PALERMO
/ BEGIN PAGE [IV] /
PROPRIETÀ LETTERARIA
dell’editore SALVATORE BIONDO
È vietata la riproduzione e la contraffazione,
essendosi adempiuto a quanto le leggi prescrivono.
88 XX 27 7 900 –Stab. Tipografico SALVATORE BIONDO– Palermo
/ BEGIN PAGE [5] /
I.
Noi siamo bambini–I bambini hanno
bisogno di essere guidati – Senza gui-
da crescono irragionevoli, maleducati e
ignoranti–I genitori e i maestri si stu-
diano di rendere i bambini ragionevo-
li–Essi li educano e li istruiscono–
Per questo i bambini devono essere
grati ai genitori e ai maestri – Un
Pagina 6
bambino pulito, educato, istruito è la
gioia di tutti – Un bambino sudicio,
maleducato e ignorante è sfuggito da
tutti.
II.
Amate Iddio–Onorate la patria–
Vogliate bene ai vostri genitori–Ri-
spettate i maestri–Venerate i vecchi
–Consolate gli afflitti – Soccorrete i
poveri–Siate amorevoli con i fratel-
lini–Non dite mai bugie– Siate cor-
tesi con tutti – Mostratevi compia&
centi con i compagni–Fuggite l’ozio–
Siate sempre sinceri.
III.
Il babbo ha regalato una bambola a
Elisa e un fucilino a Enrico–Elisa si
balocca tutto il giorno con la bambola
e non studia–Enrico alterna lo studio
con i balocchi–Elisa non è una bimba
ragionevole–Ella dovrebbe studiare e
Pagina 7
lavorare e poi baloccarsi–Elisa rompe
subito la bambola per troppo maneg-
giarla–Elisa piange e si lamenta di
non aver piú balocchi–Ma Elisa ha
torto di piangere–Se si fosse baloccata
meno con la bambola, non l’avrebbe
rotta–Enrico non ha rotto i suoi ba-
locchi–Egli studia quando è tempo
di studiare–Soltanto nelle ore di ri-
creazione si diverte–I bambini ragio-
nevoli fanno come Enrico.
IV.
Mario era un bambino ghiotto – Un
giorno vide in cucina tante susine e le
mangiò tutte–Le susine gli guastaron
lo stomaco e Mario si ammalò–Il me-
dico gli fece prendere una medicina a-
mara per guarirlo–Mario soffrì molto
quando era malato–Egli disse che non
avrebbe più mangiato troppo per non
soffrire–E da quella volta Mario man-
giò soltanto quello che gli dava la
mamma.
Pagina 8
V.
Laura aveva il vizio di toccar sempre
le forbici–Un giorno, volendo tagliare
un burattino di carta, si fece un taglio
a un dito–Da quel taglio le spicciò
molto sangue e Laura s’impaurì e si
mise a piangere–La mamma corse u-
dendola piangere e le fasciò il dito–
Quando Laura si fu calmata, la mam-
ma le proibì di toccare le forbici ed i
coltelli–Forbici e coltelli sono oggetti
pericolosi nelle mani dei bambini.
VI.
Adolfo non aveva carità per gli ani-
mali – Egli si divertiva a molestare
Fido, che era tanto affezionato – Non
tutti i cani sono pazienti come Fido–
Un giorno Adolfo molestò un cane per
via – Quel cane gli si avventò e lo
morse–Da quel giorno Adolfo capì che
gli animali non vanno molestati – Essi
hanno modo di difendersi e possono
far male–I bambini buoni non mole-
stano gli animali.
Pagina 9
VII.
I bambini pregano ogni mattina Iddio
che li faccia esser buoni. Essi lo pre-
gano pure che tenga sani il babbo, la
mamma, i fratellini, i nonni e tutti i
parenti. Iddio è nel cielo, ma ascolta
le preghiere dei bambini. Iddio è il
Padre nostro ed il Creatore. Egli ha
creato noi, i nostri genitori, tutti gli
uomini e tutte le cose. Iddio ci assi-
ste nei nostri bisogni e vede tutto e sa
tutto. Un bambino potrebbe dire una
bugia al babbo o alla mamma senza
essere scoperto. Ma Iddio, che vede
tutto e sa tutto, saprebbe che il bam-
bino ha detto la bugia. Iddio vuol tanto
bene ai bambini buoni e li protegge
sempre.
VIII.
La mamma aveva proibito a Carlino
di affacciarsi alla finestra–Carlino in-
vece, appena la mamma non lo vedeva,
Pagina 10
si affacciava alla finestra – Una volta
Carlino si spenzolò troppo e cadde di
sotto–Nel cadere non si fece male,
perchè sotto la finestra c’era un ter-
razzo–Egli soffrì tanto vedendo la sua
mamma piangere, che le promise di non
affacciarsi più alla finestra–Carlino,
quando aveva promesso una cosa, la
manteneva, e non si affacciò più alla
finestra–I bambini buoni ubbidiscono
sempre.
Emilia e Gino
IN casa Bertini c’erano due bimbi soltanto, Emi-
lia e Gino; quella aveva otto anni e questo ne
avea sei.
La bimba peraltro pareva maggiore del fratel-
lino almeno di dieci anni.
Emilia avea giudizio superiore all’età sua;
Gino non ne possedeva neppure un briciolo.
Difatto la vigilia dell’apertura delle scuole, Emi-
lia era tutta contenta, e Gino faceva il broncio.
È vero però che Emilia sapeva, per aver
fatto la prima classe elementare, che la scuola è
una bella cosa.
Ella aveva imparato dalla sua maestra tante
nozioni utili, e aveva conosciuto tante care bam-
bine.
Pagina 11
Gino non sapeva ancora che cosa fosse la
scuola. Egli si figurava che la scuola fosse una
specie di luogo di castigo; che là non si ridesse
mai, e non si ruzzasse mai.
DOMANDE: Perchè Gino non voleva andare a scuola?
Che cosa si figurava che fosse la scuola? Che cos’è invece?
Chi mostra piacere di andare a scuola, è un
bambino ragionevole che fa sperare di non voler
rimanere ignorante.
I capricci di Gino
– Io, domani non voglio andare a scuola, no !
no ! – disse Gino.
La mamma lo udì e gli rispose:
– I bambini non possono dir la parola « vo-
glio ». I bambini sono irriflessivi e non debbono
aver volontà. Sta a tuo padre ed a me guidar-
ti. Noi abbiamo stabilito che tu vada a scuola, e
ci andrai.
Anzi, domattina cerca di esser pronto presto,
se no il babbo crederà che tu faccia il capriccio
di non voler andare a scuola. Egli allora ti ci
condurrà per forza, e ti farà fare una brutta
figura.
II babbo dirà al maestro la tua avversione per
la scuola. II maestro penserà che tu voglia ri-
manere ignorante, e non ti stimerà.
Pagina 12
Bisogna meritarsi la stima di tutti, e special-
mente dei maestri e dei superiori.
DOMANDE: I bambini possono dir « voglio » ? Chi li gui-
da ? Quali guai potrebbero capitare a Gino, se egli con-
tinuasse a non « voler » andare a scuola ?
I bambini non possono avere volontà perchè
non hanno il giudizio, che si acquista con l’età
e con lo studio.
Gino riflette
GINO pensò tanto alle parole della mamma,
che la mattina dopo era pronto prima del solito,
e non fece nessun capriccio per andar a scuola.
–Bravo–gli disse Emilia–vedendolo– « Il
peggior passo è quel dell’uscio ». Capisco the ti
dispiaccia lasciare i balocchi, ma l’applicazio-
ne è molto più dilettevole che l’ozio. Eppoi,
non sono tanto più carini i bimbi di carne e
d’ossa, che avrai per compagni, che i tuoi stu-
pidi pulcinelli ? Vieni, e conduciti bene.
Emilia e Gino si presero per mano e andarono
a scuola.
DOMANDE: Come mai Gino cambiò parere e andò a scuo-
la ? Quali consigli dava Emilia al fratellino ?
1 bambini buoni prestano sempre orecchio ai
consigli della mamma. La mamma è l’amica pri-
Pagina 13
ma di ogni bambino. Chi non sa ascoltare la voce
della mamma, ha il cuore indurito, e non vorrà
prestare orecchio a nessun consiglio.
Il ritorno a scuola
– BENVENUTI, bambini–disse la maestra, en-
trando in classe.
– Buon giorno, signora maestra.
– Buongiorno, cari. Noi non ci conosciamo
ancora, ma ho la speranza che presto faremo co-
noscenza.
Ne ho tante, a dire il vero, delle speranze, e
sta a voi di effettuarle.
Prima di tutto io spero che voialtri imparerete
a volermi bene.–
I bambini guardavano la maestra, che parlava
loro con tanto affetto. I loro occhi intenti e
scintillanti dicevano già che ella s’era acquistate
tutte le loro simpatie.
–Poi–riprese la maestra–spero che mi ub-
bidirete sempre. Sarebbe per me un dolore ve-
dervi disubbidire.
Tutto ciò che vi dico, ve lo dico per il vostro
bene. La maestra, in queste ore che siete a scuola,
fa le veci dei genitori; e voi avete verso di me
gli stessi obblighi che a casa avete verso di loro.
Quali siano, vi dirò domani. Per oggi basta.
DOMANDE– Come parlò la maestra ai bambini? Oltre
Pagina 14
che ai genitori, i bambini a chi devono ancora ubbidire?
Disubbidendo alla maestra, che cosa prova ella?
L’ubbidienza è la più bella virtù. Chi ubbidi-
sce, dà prova di dolcezza d’animo e di deferenza
verso i maestri e i genitori.
Amore verso i Maestri
LA mattina seguente, quando la maestra entrò
in classe, trovò tutti i bambini al loro posto.
Appena, la videro, si alzarono e, in coro, le die-
dero il buon giorno. La maestra restituì loro
affettuosamente il saluto, poi cominciò:
–Vi dissi dunque ieri, che nelle ore che state
qui, io faccio con voialtri le veci dei vostri ge-
nitori. Dovete dunque ubbidirmi.
Sono certa che nessuno di voi oserebbe disub-
bidire ai proprj genitori. Per questo non oserà
neppure disubbidire a me.
Ma il non disubbidire non basta.
Ogni bambino deve seguire gli ammaestra-
menti che io do. Egli deve pure imparare quello
che insegno.
Perchè io voglio che alla fine dell’anno scola-
stico siate tutti promossi.
Predicherei al vento se voi non teneste conto
di quello che dico.
DOMANDE– Che cosa disse la maestra? Basta essere ub-
bidienti? Che altro occorre ?
Pagina 15
I consigli dei maestri vanno impressi nel
cuore. Quanti infelici di meno vi sarebbero se
da piccoli avessero dato ascolto alle parole dei
maestri!
Amore verso i compagni
PIÙ tardi la maestra riprese :
– Queste non sono tutte le mie speranze : io
spero ancora che fra voi tutti nasca reciproco affet-
to. Dovete considerarvi come tanti fratelli, aiutarvi
tra voi di consigli, e fare a gara nella buona
condotta e nello studio.
In classe poi bisogna che abbiate riguardi, non
solo per la maestra, ma anche per i compagni. È
necessario che usiate buone maniere con tutti i
vostri condiscepoli ; che siate composti e silen-
ziosi per non distrarre la loro attenzione.
Mettetevi bene in mente queste massime, per-
chè io sarò buona con i buoni, e severa con i
disubbidienti, gli sguaiati ed i turbolenti.–
La maestra aveva parlato chiaro; stava agli
scolaretti l’appagare le speranze di lei.
DOMANDE – Come bisogna comportarsi coi compagni ?
Si debbono amare ? In classe, dopo la maestra, vi sono altre
persone a cui si devono riguardi ? Chi sono ? Come sarà la
maestra con gli sguaiati ? Coi disattenti ?
Un bambino buono è compiacente con i fra-
tellini e con i compagni di scuola.
Pagina 16
La disgrazia di Bianca
– CHE cos’ha la Bianca Lori, che non si ve-
de a scuola ? – domandò la maestra.
Questa domanda era rivolta a tutta la classe.
Elisa Serventi rispose:
– Signora maestra, Bianca Lori si è scottata
e soffre molto.
– Solite imprudenze fanciullesche ! – disse la
maestra.
– Nossignora – rispose l’Elisa – Bianca si è
scottata perchè era costretta a fare cose che non
poteva.
Bianca ha la mamma ammalata. Il babbo le
morì nell’estate. Bisognava che assistesse la mam-
ma, e facesse da mangiare ai fratellini. Nel to-
gliere una pentola col brodo di sul fornello, le si
rovesciò tutto il liquido sulle mani.
– Si capisce ; era piccina e non arrivava al
camino che sarà stato alto.
– Già – rispose – l’Elisa e ora soffre assai
perchè le scottature sono dolorose. Eppoi soffre
anche più, perchè non può assistere la sua
mamma.
– Poverina ! –dissero le scolarine che avevano
tanta simpatia per quella loro compagna.
– Andrò a visitarla –disse la maestra–e giac-
chè il fatto della Bianca ci ha portato a parlare
Pagina 17
della cucina, voglio insegnarvi i nomi degli og-
getti più usuali, che vi si trovano. Perchè le
donne, ricche o povere che siano , debbono oc-
cuparsi della cucina, che fa parte del governo
della casa.
DOMANDE – Quale disgrazia era accaduta a Bianca ?
Perchè? Quale è l’obbligo di una donna da casa ?
Amate i genitori. Essi sono gli amici vostri mi-
gliori. Siate pronti a qualunque sacrifizio per essi,
che darebbero la loro vita per voi.
La cucina ed i suoi arredi
– DUNQUE–continuò la maestra–sapreste dir-
mi che cosa si osserva in cucina ?
– Sissignora–rispose Elisa Serventi.–In cu-
cina c’è il camino...
– E sul camino i fornelli – suggerì un’altra
scolarina.
– Che cosa si mette sui fornelli quando il fuoco
è acceso?
– Le pentole, nelle quali si cuoce la carne, si
fa il brodo per la minestra, si cuociono i mac-
cheroni, i fagiòli, gli spinaci...
– Non ci sono altro che pentole per cuocer
le vivande ? – domandò la maestra.
Pagina 18
Elisa Serventi esitò un momento , e allora
l’altra bambina disse, franca franca :
– In cucina ci sono anche le teglie e i tegami
per fare le costolette, gli spezzatini di carne, e
le braciole.
– Vedo che t’intendi di cucina – disse la
maestra. – Enumera quello che v’è ancora in
cucina.
– Le cazzaruole, dove si fa l’arrosto morto e
l’umido; le padelle per il fritto; il girarrosto per
arrostire la carne, i polli o la cacciagione...
– Eppoi...?
– Eppoi la ghiotta, che si mette sotto lo spiede,
nel quale è infilato l’arrosto, per raccogliere il
sugo; la gratella per fare le bistecche; le forme
per fare i budini e gli sformati; le tortiere per le
torte.
– Saresti un po’ ghiottoncella ?–domandò la
maestra sorridendo.
La bambina arrossì e disse :
– Nossignora; ma in cucina aiuto la mamma
e da lei imparo il nome degli oggetti che si a-
doprano e delle pietanze.
DOMANDE–Che cosa si osserva in una cucina ? Quali
oggetti vi debbono essere ? Con che ordine debbon esser
tenuti ?
Pagina 19
La lezione continua
– GLI oggetti che la vostra compagna ha no-
minati–continuò più tardi la maestra – non
sono i soli che figurano in una cucina fornita di
tutto l’occorente.
In cucina è necessario anche il tagliere per bat-
tere e tagliare la carne con la mezzaluna; lo
spianatoio per far la pasta, e il matterello per
istenderla; il colabrodo per colare il brodo, il se-
taccio per passare i pomidoro e le patate; i
bricchi per iscaldar l’acqua; le caffettiere e le lat-
tiere; i mestoli per rimuginare le pietanze, i ra-
maioli per prendere i liquidi, il trinciante per
tagliare; lo scolatore per far scolare i maccheroni
e le erbe cotte; il macinino per macinare il caffè.
L’acquaio poi e i catini sono indispensabili per
lavare i piatti e gli oggetti di cucina. Una
buona madre di famiglia tiene la cucina pulita
come uno specchio, e non risparmia nè ranno,
nè sapone, nè acqua.
DOMANDE–Quali altri oggetti si osservano in cucina?
Quali sono i più indispensabili?
Una bambina deve aiutare la mamma nelle
faccende domestiche, e rispondere sempre cortese-
mente e con premura quando essa le affida qual-
che lavoro.
Pagina 20
Buone amiche
DOPO che Elisa Serventi ebbe narrato il triste
caso di Bianca Lori, tutte le bimbe della secon-
da elementare rimasero pensierose.
Esse volevano un gran bene a Bianca, fino dal-
l’anno precedente, perchè era stata per loro una
buona compagna. Ora la sventura che la colpiva
affliggevale troppo.
Ognuna tornò a casa propria e, poco dopo, quat-
tro di loro ne riuscivano insieme con la mamma
o con altra persona, per andare a casa dell’a-
mica.
Elisa Serventi vi giunse per la prima ed a-
spettava da un pezzo che le fosse aperto l’uscio,
quando fu raggiunta dalle altre compagne.
Elisa sonò una seconda volta, ma invano.
Finalmente fu aperto un altro uscio dirimpetto
sullo stesso pianerottolo, e comparve una donna.
–Come sta Bianca?–domandò Elisa.
–Poverina, l’hanno portata all’Ospedale.
–E la sua mamma?
–È in casa con i piccini. Se vogliono ve-
derla, ora apro. Non si può muover da letto.
Credano, che quella famiglia fa davvero compas-
sione.
–Non disturbiamo l’inferma– propose Elisa
Serventi alle compagne.
Pagina 21
–Anzi, sarà tanto contenta di sapere che
s’interessano della sua figliuola. Vengano.
DOMANDE–Dopo che Elisa Serventi raccontò il triste caso
di Bianca Lori, come rimasero le altre bambine? Perchè
quel caso le affliggeva tanto? Che cosa fecero quattro di
quelle bambine?
L’amore verso i compagni è cosa lodevole. Le
persone veramente affezionate si conoscono nella
sventura.
In casa di Bianca
LA donna, che aveva parlato con le visita-
trici, aprì l’uscio con la chiave, e introdusse le
bimbe in una camera grande e abbastanza ariosa.
Nel letto giaceva la vedova ; i suoi tre bimbi
erano seduti accanto al capezzale e uno dormi-
va con la testina reclinata sulle coperte.
–Siamo venute per aver notizie di Bianca–
disse Elisa.
–Povera Bianca! Soffre tanto e ha bisogno di
continua assistenza – rispose la madre con le
lacrime agli occhi.–Qui l’assistenza le manca-
va e il medico ha creduto necessario di farla
portar via.
Le disgrazie non vengono mai sole. Se io non
fossi stata inferma ella non si sarebbe scottata.
Pagina 22
–Potremmo vederla, la nostra cara amica?–
domandarono le bimbe.
–Domani, giovedì, è un giorno di visita all’Ospe-
dale, e le faranno un gran piacere–rispose la ma-
dre.–Diano un bacione per me, alla mia cara.
–E lei, ha bisogno di nulla? – domandò
Elisa timidamente.
–Di nulla, grazie. Quando sto bene, lavoro
in un negozio di biancheria. Ora, che sono
malata, il padrone mi manda la carne e tutto
quello che mi può occorrere. Questa buona pi-
gionale, poi, mi assiste. Vadano da Bianca, che è
sola–aggiunse la poveretta.
– Ci andremo, e dopo verrò a dirle come l’ho
trovata–rispose Elisa, ed uscì insieme con le
compagne.
DOMANDE–Perchè la madre di Bianca diceva che le di-
sgrazie non vengono mai sole? Perchè era commossa ve-
dendo le bambine? Perché voleva che vedessero Bianca?
Esser caritatevoli non significa soltanto dare
denaro a chi ne ha bisogno. La carità si può
fare in mille maniere, e spesso una attenzione,
una premura, una buona parola, confortano un
afflitto più che una elemosina. Non tutti possono
dar denaro, ma le attenzioni e le buone parole
sono carità che tutti possono fare.
Pagina 23
La visita a Bianca
LE amiche si erano riunite a casa di Elisa Ser-
venti, per recarsi tutte insieme a veder la Bianca.
Ognuna aveva un involtino contenente un pic-
colo regalo per la povera piccina.
La signora Serventi, che le accompagnava, disse
loro di lasciare gl’involti se contenevano dolci.
All’Ospedale occorre un permesso per portar roba
da mangiare agli infermi.
–No, sono balocchi– risposero le bimbe.
–Che cosa è un Ospedale?– domandò Elisa
alla mamma.
–È un ricovero fondato generalmente col dena-
ro delle persone benefiche. In esso si accolgono
quei malati che non potrebbero esser curati in
famiglia. La vostra compagna sarebbe stata mal
curata a casa sua. Qui invece ha una continua
assistenza: medici, medicine, bagni e tutto quanto
può occorrerle. Chi fonda un Ospedale, o dà una
somma per migliorarlo o ingrandirlo, è un bene-
fattore dell’umanità.
Mentre parlavano, erano giunte alla porta di
un grande fabbricato, nel quale, con loro, en-
travano molte persone.
Un guardiano era all’ingresso ed esaminava i
fagotti, che quasi tutte portavano.
Nell’aprire quelli delle bimbe, sorrise e le lasciò
passare.
Pagina 24
DOMANDE–Che cos’è un ospedale? Quale titolo meritano
le persone che contribuiscono a fondarlo? Perchè non è
permesso portare cose da mangiare agli ammalati?
Chi è ricco deve pensare a chi soffre.
La ricchezza procura gioie vere quando è im-
piegata a soccorrere le miserie altrui.
All’Ospedale
LA signora Serventi condusse le amiche di
Bianca nella corsìa delle bambine; quella corsìa,
portava il nome di « Margherita di Savoia » , per-
chè appunto era stata fondata dalla Regina.
Una monaca si fece loro incontro.
–Come sta Bianca Lori?–domandò Elisa.
– Soffre, ma è tanto paziente quella cara
bimba–rispose la monaca.–Vedano, è là, in quel
lettino ultimo, e ora riposa. Non dormiva nè giorno,
nè notte, e il medico le ha dato un medicamento,
che l’ha fatta assopire.
– Dunque, non possiamo parlarle? Eravamo
venute a farle animo, e a portarle questi regalini.
Elisa consegnò alla monaca il suo involto e le
altre bimbe fecero lo stesso.
– Siamo le sue compagne di scuola–disse
Elisa–Le portiamo un bacio della sua mamma.
–Torneremo–aggiunse un’altra.
– Mi raccomando, le dia la mia bambola–
pregò una terza.
/ BEGIN PAGE [25] /
– Siamo le sue compagne di scuola – pag. 24
Pagina 26
–Stiano tranquille. Bianca vedrà tutti questi
doni quando riaprirà gli occhi.
Le bimbe ringraziarono la suora e a malin-
cuore stavano per andar via.
– Da parte di chi debbo dire a Bianca che
le sono mandati questi doni?
Le bimbe si consultarono un momento, e poi
Elisa rispose :
–Dica pure che i doni provengono da tutta la
seconda classe.
–E dica anche a Bianca che le vogliamo un
gran bene, e che speriamo rivederla presto fra
noi–aggiunse un’altra.
–Care e buone piccine ! esclamò la monaca
accarezzandole.
DOMANDE–Come si chiamava la corsìa dove si trovava
Bianca Lori? Perchè portava quel nome? Che cosa disse-
ro alla suora le quattro donatrici?
Quando si fa una buona azione, non bisogna
menarne vanto. Chi si vanta di una buona azio-
ne, non è caritatevole. L’uomo veramente carita-
tevole è modesto.
La mamma mia
Quando mi sveglio, un angelo
Viene a baciarmi in viso;
Ma non ha l’ali d’oro,
Nè vien dal paradiso.
Pagina 27
Brillano di speranza
Quegli occhi tutt’amore,
Di gioia con un fremito
Mi stringe sempre al core;
M’insegna ad esser buono,
Sorregge i passi miei....
Oh ! chi sarà quell’angelo ?
O madre mia, tu sei !
V. Mangione
In giardino
ERA una mite giornata, sul finire di ottobre,
e la maestra, appena entrata in classe, disse :
– Bambini, oggi vi propongo di scendere in
giardino.
I bambini si alzaron tutti dai banchi, vispi e
allegri, ed a due a due uscirono dalla classe.
L’edifizio della scuola era un antico fabbricato
con un grande giardino, limitato dalle mura della
città.
Nel lato esposto al sole crescevano a spal-
liera, addossate alle mura, tante belle piante di
limone e d’arancio. Quelle e queste erano cari-
che di frutti. I limoni erano già ingialliti ; gli
aranci erano ancora verdi.
Nel centro del giardino, fra le aiuole delle dalie
e dei crisantemi, che sono fiori d’autunno, v’era
un lungo pergolato.
Pagina 28
Sotto di quello la maestra fece fermare gli
scolaretti.
Essi alzarono gli occhi ed esclamarono :
– Che bell’uva !
– Bella davvero – disse la maestra – È stata
lasciata sulla pianta perchè maturi meglio. Di-
fatto, vedete che bel color d’oro ha preso l’uva
bianca, come è cupa la nera ?
Andiamo qua, all’ombra e parleremo un poco.–
I bambini ubbidirono seguendo la maestra.
DOMANDE–Che cosa propose la maestra ai bambini in una
giornata di ottobre ? Com’era l’edifizio della scuola ? Com’era
il giardino ? Che vi si osservava ?
Studio e diletto sono due cose che i bambini
giudiziosi possono accoppiare. Chi non è studioso
non ha il diritto di divertirsi.
La vendemmia
QUANDO tutti i bambini furon raccolti intorno
alla maestra, ella incominciò :
– Mi sapreste dire come si chiama la pianta
da cui nasce l’uva ?
– Si chiama vite – rispose il Rossi.
– E dell’uva che cosa facciamo ?
– Il vino. Ma l’uva anche si mangia – e nel
dir così il Rossi dette una guardatina ai grap-
poli che pendevano dal pergolato.
/ BEGIN PAGE [29] /
…e li buttavo nelle bigonce pag. 30
Pagina 30
– Come vedete la vite ha bisogno di un so-
stegno per crescere bene. Talvolta si lascia ar-
rampicare la vite sugli alberi di pioppo, pianta-
ti a una certa distanza uno dall’altro. La si fa
anche arrampicare su canne o pioli incrociati.
Quando la si fa salire su una incanniciata come
questa, forma un pergolato o pergola.
– Nessuno fra voi è stato mai a vendem-
miare ? – domandò la maestra.
– Io – rispose, al solito, il Rossi.
– Ebbene, dimmi che cosa facesti.
– Mangiai tant’uva.
– Questo me lo figuro; ma non facesti altro ?
– Sissignora aiutai anch’io i vendemmiatori.
Era d’autunno, mi rammento, e faceva giorno
tardi; mi alzai col lume e andai nella vigna, e
volli un paio di forbici.
– Che cosa facevi con le forbici ?
– Tagliavo i grappoli e li buttavo nelle bi-
gonce. Quando queste eran piene, due contadini
le caricavano sul carro e le portavano alla tinaia
per empire i tini.
– Che cosa sono i tini ? – domandò timida-
mente un altro scolaretto.
– Sono certe specie di botti assai grandi, a-
perte da una parte, dove si getta l’uva dalle bi-
gonce e dove si pestano i chicchi per fare il mosto.
Quando il mosto ha bollito, si cambia in vino–
rispose la maestra.
Il vino si travasa dal tino per metterlo nelle
botti, che si tengono nelle cantine.
Pagina 31
Il vino è una bevanda utilissima all’uomo, pur-
chè questi ne usi con moderazione. Ma gli nuoce
se ne beve troppo. L’uomo allora perde la ragione,
cioè si ubbriaca, ed è capace di qualunque cat-
tiva azione.
DOMANDE – Che cosa produce la vite ? Quando si fa la
vendemmia ? Dove si porta l’uva vendemmiata ? Perchè
la maestra disse che il vino nuoce a chi ne beve troppo ?
Che cosa avviene a chi beve troppo vino ?
I bambini a tavola non debbono mai chieder
nulla , neppure se credono che la mamma o il
babbo abbiano dimenticato di servirli. A tavola
si sta composti, si mangia lentamente, ci si pu-
lisce la bocca prima di bere, e non s’imbratta la
tovaglia. Chi sta male in tavola dà a conoscere
di esser maleducato.
La festa della maestra
I bambini sapevano che la loro maestra si chia-
mava Caterina, e quando venne il giorno della
sua festa, essi vollero attestarle la loro gratitu-
dine con qualche piccolo dono di fiori.
Ne parlarono con quelli della terza classe, che
erano stati, l’anno precedente, alunni della loro
maestra.
– Guardatevi bene dal farle dei doni – dissero
Pagina 32
quelli.– La maestra se ne avrebbe a male; non la
conoscete. Cercate invece d’imparare bene le le-
zioni, di star buoni, e, se volete, fatele gli au-
gurj.
Gli scolari della seconda dettero retta al con-
siglio. I più ascoltati fra loro raccomandarono
agli svogliati di far eccezione per quel giorno,
ai turbolenti di non muoversi nè fiatare; e tutti
s’impegnarono a dare, in occasione di quella festa,
una consolazione alla maestra.
DOMANDE – Che volevano fare i bambini alla maestra
nel giorno dell’onomastico di lei ? Perchè stabilirono poi di
non farle ciò che volevano ?
Amate la vostra maestra. Dopo i vostri geni-
tori, la maestra è colei che ha maggior premura
per il vostro bene. Siate riconoscenti.
Una gioia meritata
APPENA i bambini scorsero la maestra, in classe
si udì un bisbiglio sommesso. Erano gli scola-
retti che ripetevano a mezza voce :
– Ecco la maestra ! ecco la maestra !
Ella entrò in classe come al solito.
Interrogó uno e rispose bene; l’altro, meglio, e
così di seguito.
Intanto nella classe regnava un gran silenzio,
e tutti i piccoli alunni tenevano gli occhi fissi
Pagina 33
sulla cattedra e le orecchie intente alle spiega-
zioni che dava la maestra.
Se qualcuno volgeva l’occhio o faceva un mo-
vimento, lo sguardo imperioso di un compagno
lo richiamava subito all’ordine.
La maestra non capiva; non aveva mai veduto
la sua classe così attenta e disciplinata come in
quel giorno, e, terminata la lezione, disse :
– Così vorrei vedervi sempre : mi avete dato
una grande consolazione.
Berto Carli si alzò allora e rispose :
– Signora maestra, sapevamo di farle cosa gra-
dita conducendoci in modo esemplare, oggi ch’è
giorno di festa per lei. Accetti i nostri augurj ,
e si assicuri che cercheremo di condurci sempre
bene. Se non ci riuscirà , sappia compatirci,
perchè siamo piccini e frugoletti.
La buona maestra era commossa da quelle
parole; quello fu per lei un vero giorno di festa
solenne.
DOMANDE–Invece di fare un regalo alla maestra , che
cosa stabilirono i bambini? Che cosa disse la maestra? Che
cosa disse Berto Carli ?
Non v’è miglior modo di attestare ai maestri
la propria gratitudine che quello di mostrarsi at-
tenti e disciplinati.
Pagina 34
Le cose pericolose
BIANCA Lori una mattina tornò a scuola. Era
pallida, magra, e aveva le manine ancora fasciate.
Soltanto le punte delle dita scappavano fuori
delle fasce.
– Come stai ? – le domandò la maestra.
– Sto benino , grazie. Ma ho sofferto tanto !
Però la monaca che mi assisteva cercava di far-
mi animo. Anche le mie compagne sono state
molto buone per me.
Nel dir questo Bianca volse uno sguardo per
tutta la classe. Elisa Serventi abbassò gli occhi
e arrossì ; le altre tre bimbe, che avevano portato
doni a Bianca all’Ospedale, fecero lo stesso.
– Ringrazia Iddio di esser salva, e di aver tro-
vato conforto nelle tue afflizioni – disse la mae-
stra.
Non è stato in seguito a un’imprudenza –
continuò la maestra – che Bianca si è scottata.
Anzi, ella è stata vittima del suo amor filiale.
Ma le bambine e i bambini sono spesso impru-
denti, perchè non capiscono il pericolo a cui vanno
incontro. E neppure calcolano quanti dolori ca-
gionano ai genitori con la loro imprudenza.
Vi darò più tardi, su questo proposito, alcuni
consigli, che dovrete tener bene a mente.
DOMANDE–Com’era Bianca Lori quando tornò a scuola?
Che cosa disse Bianca ? Le imprudenze dei bambini che
cosa cagionano ai genitori ?
Pagina 35
Ogni figlio deve evitare dolori ai proprj geni-
tori e deve sempre trattenere i fratelli minori
dal commettere imprudenze. Felice quel bambino
che puó dire a se stesso : io sono la gioia dei
miei genitori !
I consigli della Maestra
DOPO la ricreazione, la maestra riprese :
– Prima di tutto, i bambini debbono sempre
guardare dove mettono i piedi camminando e
correndo.
Questo li salverà dalle cadute.
I bambini non debbono mai affacciarsi alle fi-
nestre, e molto meno spenzolarsi dal davanzale
Si fa presto a precipitare nella strada.
Neppure dovrebbero prendere in mano lumi e
con quelli girar per le stanze. Non ci vuol molto
a dar fuoco a una tenda e ad appiccar l’incen-
dio a una casa.
Se poi si tratta di lumi a petrolio, debbon guar-
darli e lasciarli stare. Il petrolio è facile ad
incendiarsi. Non è prudente neppure maneggia-
re dei fiammiferi. I bambini, se non vi sono co-
stretti dalla necessità, come era il caso di Bianca,
non devono mai accostarsi al fuoco e molto meno
toccare le pentole, o altri vasi pieni d’acqua bol-
lente, che stanno sui fornelli.
C’è pericolo anche a baloccarsi con gli aghi e con
gli spilli, che possono rompersi nella carne e pro-
Pagina 36
durre ferite. Aghi e spilli non vanno mai messi
in bocca. Ingoiandoli si va incontro alla morte.
Forbici e coltelli sono oggetti che i bambini
non debbono maneggiare.
Molti altri consigli potrei darvi, ma per oggi
basta – disse la maestra.
DOMANDE – Perchè la maestra disse che i bambini sono
spesso imprudenti? Perchè debbono guardare dove mettono
i piedi? Perchè non debbono affacciarsi alla finestra? Per-
chè non debbono toccare i lumi ? Che cosa può accadere
a chi maneggia un lume a petrolio? Sono pericolosi gli aghi
e gli spilli? Perchè? Che pericolo v’è a maneggiare forbi-
ci e coltelli ?
Il vaso rotto
MARIO e Bice avevano avuto un regalino dalla
mamma.
Quel regalino consisteva in una palla di gom-
ma. Essi, appena l’ebbero portata a casa, inco-
minciarono a farla rimbalzare, correndo per le
stanze.
Mario, che era il più prepotente, non permet-
teva a Bice di baloccarsi con la palla. Dopo averla
fatta rimbalzare, egli si diede a lanciarla contro
una delle pareti della stanza da pranzo, senza
badare che sui mobili v’erano oggetti, che si po-
tevano rompere.
Bice intanto diceva :
– Mario, dammela : romperai qualcosa , e poi
sentirai la mamma !
Pagina 37
Mario faceva il sordo e continuava.
La palla, lanciata male, andò a battere contro
un vaso di maiolica, posato sulla credenza, e lo
mandò in mille bricioli.
– Te lo dicevo ! – esclamò Bice.
Mario non fiatava ed era impallidito per il
timore delle sgridate.
La mamma, spaventata dal fracasso, corse a
vedere quel che fosse accaduto.
– Peccato ! – disse – Quel bel vaso che m’era
stato regalato dalla zia Emilia. Siete due monelli,
due sbadati. Qua la palla; non l’avrete mai più!
Bice non fiatò per non far ricadere sul fra-
tellino tutta la colpa ; ma Mario volle che la
mamma sapesse tutta la verità, e disse :
– Non isgridare, nè punir Bice, mamma; ella
anzi mi ammoniva di non giocare a palla in
questa stanza; io non l’ho ascoltata : il vaso l’ho
rotto io, e la colpa del malestro è tutta mia.
La mamma fu disarmata dalla sincerità di
Mario, e gli perdonò. Ella encomiò Bice per non
aver accusato il fratellino , e Mario per aver
detta la verità.
DOMANDE–Perchè Mario non voleva dar la palla a Bice?
Perchè Bice tacque al rimprovero della mamma ? Perchè
la mamma perdonò a Mario ? Perchè encomiò Bice ?
L’affetto fraterno impone che si cerchi di co-
prire la colpa dei fratelli e delle sorelle.
Non vi è nulla di più odioso che l’accusarsi
Pagina 38
tra fratelli e sorelle. Bisogna anzi cercar di scu-
sare chi è in colpa, e con la persuasione indurlo
ad emendarsi.
La moneta trovata
COL berretto messo sulle ventiquattro e le
mani in tasca, Berto Carli correva a casa lascian-
dosi dietro la vecchia Rosa, la donna di servizio,
che sudava a seguirlo.
– Venga qua !–gli gridava Rosa di lontano.
Per due o tre volte Berto non rispose, ma non
volendo arrivare a casa solo, per paura di essere
sgridato dalla mamma, alla fine ubbidì, e tanto
per non istar fermo, buttò per aria il berretto,
che ricadde in terra.
Berto si chinò per raccattarlo e vide in terra
qualcosa che luccicava.
Era una moneta d’oro, grossa come una mo-
neta da dieci centesimi. Prenderla, buttarla per
aria, fare un salto e mandare un grido di gioia,
fu tutt’uno per Berto.
– Che fortuna ! – disse la Rosa–varrà, a dir
poco, cento lire.
– Cento lire ! – esclamò Berto – mi ci com-
pro subito un velocipede, e poi vedrai che corse!
Appena arrivato a casa, Berto entrò come il
vento nel salottino, dove lavorava la mamma,
e le disse :
/ BEGIN PAGE [39] /
...varrà, a dir poco, cento lire. pag. 38
Pagina 40
– Sai, mamma, ho trovato questa moneta
d’oro e mi ci compro un velocipede!
La mamma lo guardò seria seria.
–Non puoi spendere quel che non è tuo, ca-
rino mio; codesta moneta non è tua. Ora l’Uf-
ficio municipale è chiuso, ma domattina andre-
mo a depositarla. Così potrà essere ricuperata da
chi l’ha perduta.
A queste parole tutta la gioia di Berto svanì,
ed egli andò mogio mogio in camera sua.
–Come mai la mamma dice che la moneta
non è mia ?–ripeteva. E non si poteva persua-
dere che la sua mamma avesse ragione.
DOMANDE–Che cosa trovò Berto? Che cosa voleva com-
prarsi? Perchè la mamma gli disse che la moneta non
era sua? Dove si riporta la roba trovata?
All’Ufficio municipale
LA mattina dopo, Berto seguì a malincuore
la mamma al Municipio. Egli, pensa e ripensa,
non si poteva capacitare che la moneta trovata
non gli appartenesse.
Quando madre e figliolo entrarono nell’Ufficio
municipale, videro una povera donna piangente
davanti al finestrino la quale parlava con un im-
piegato.
–Ho perso ieri nel giorno una moneta d’oro
di cento lire in via Garibaldi–diceva singhioz-
Pagina 41
zando.–La mia padrona, che è una signora a-
mericana, mi aveva mandata dal cambiavalute
a cambiarla in carta. Non so come fosse, ma
quando andai per cambiarla, non me la trovai.
Se non la ritrovo, non torno più a casa, per-
chè la signora crederà che gliel’abbia rubata. Dio
mio, aiutatemi, se no, sono in mezzo di una stra-
da, e per di più accusata di furto!
Berto all’udir quei lamenti, si era avvicinato
al finestrino. Commosso dalle lacrime della po-
veretta, la tirò per lo scialle, e le disse:
– Non piangete; la moneta l’ho trovata io.
– Dice davvero ?
– Eccola! – rispose la madre di Berto.
La poveretta si gettò sulla mano che le por-
geva la moneta, e la baciò; poi disse :
–Sono contenta !–e preso il bambino fra le
braccia, lo coprì di baci, ripetendo :
–Che sia benedetto!
Lungo la strada Berto non fiatò per un pezzo,
ma poi disse alla mamma :
–Son contento di aver consolato quella po-
vera donna; ora capisco perchè commettevo una
cattiva azione non andando a depositare la mo-
neta al Municipio.–E non pensò più al velo-
cipede.
DOMANDE–Che cosa si commette non restituendo la
roba trovata? Perchè si deve depositare ogni oggetto che
si trova?
Pagina 42
Nel procurarsi una gioia bisogna, prima di
tutto, pensare : questa gioia costerà lagrime a nes-
suno? Se abbiamo dubbio che la nostra gioia
possa procurar dolori ad altri, vi si deve subito
rinunziare.
Le monete
LA mattina dopo che il Carli aveva trovato
la moneta, c’era un gran bisbiglio nella scuola.
Il bambino non aveva potuto fare a meno di
narrare ai compagni il caso occorsogli, e i com-
menti degli scolaretti erano infiniti.
–Silenzio !–disse la buona maestra–In classe
non si parla.
Tutti tacquero; ma dagli sguardi che i bam-
bini si scambiavano da un banco all’altro, la
maestra capì che ci doveva essere qualcosa per
aria, e domandò :
–Che cosa è successo?
–Lo domandi al Carli–risposero tutti a una
voce.
Berto Carli si alzò, e in due parole narrò il
caso.
–La tua mamma–disse la maestra–ti èduca
bene, e spero che dopo questa lezione tu abbia
capito che è dovere il restituire la roba trovata,
se si conosce il proprietario, il depositarla, se ci è
sconosciuto. E spero che lo avrete capito tutti,
questo dovere.
Pagina 43
–Sissignora –risposero gli scolaretti.
–Giacchè abbiamo parlato di monete, mi sa-
preste dire di che cosa son fatte?
–Di rame –disse un bambino.
–Di nichel–aggiunse un altro.
–D’oro e d’argento – saltò a dire un terzo.
–Avete ragione tutti–rispose la maestra.
Ma che cosa sono il rame, il nichel, l’argento
e l’oro?
–Sono metalli–rispose il Berni, che era fi-
gliuol d’un fabbro, e di quelle cose s’intendeva.
–Quanto valgono le monete di rame?–do-
mandò la maestra.
–Poco. Ci sono da un centesimo, da due,
da cinque e da dieci centesimi.
–Dunque, se le monete cosiddette spicciole
sono di rame, varranno meno delle altre ?
–Sicuro ! disse il Berni–e sono tanto più
pese. Una monetina di nichel vale venti cente-
simi e pesa poco più di una di rame da due
centesimi, e una lira d’argento pesa quanto cin-
que centesimi di rame; lo so perchè l’ho pesata
quando me la dette il babbo per la mia festa.
–È vero–rispose la maestra.– Avete visto
che vi sono monete d’argento da cinquanta cen-
tesimi, da una lira, da due e da cinque lire.
D’oro ve ne sono pure, da cinque lire, da dieci,
da venti e da cento lire.
DOMANDE–Di che cosa sono fatte le monete? Dove si
trovano i metalli? Quali sono le monete di minor valore?
Quali di maggiore?
Pagina 44
A che cosa servono le monete
– E sapete perchè si fanno d’argento e d’oro le
monete che hanno maggior valore ?
Nessuno seppe rispondere, e la maestra proseguì:
–Si fanno d’oro e d’argento le monete di
maggior valore, perchè se si dovesse portare in
tasca una moneta di rame che valesse venti lire,
oppure tante monete che rappresentassero quella
somma, ne proveremmo incomodo a cagione del
soverchio peso. Per trasportare cento lire di ra-
me, che peserebbero dieci chilogrammi, ci vorreb-
be l’aiuto di un facchino. Invece, cinque mone-
te d’oro di venti lire ciascuna, che formano cen-
to lire, pesano poco, e, perchè l’oro ha un valore
maggiore del rame, valgono lo stesso.
Le monete furono inventate per agevolare le
compre e le vendite.
Nei tempi antichi, quando quelle non esistevano,
un uomo, per esempio, che avesse voluto com-
prare un sacco di grano, non poteva averlo al-
tro che barattandolo, mettiamo il caso, con un
sacco di fagioli. Ma per esitare il suo grano do-
veva cercare una persona che ne avesse bisogno
e potesse dargli qualcosa che gli tornasse utile,
e in questa ricerca perdere troppo tempo. Con le
monete si sono rese più facili le compre e le
vendite, perchè con quelle si può sempre avere
qualunque oggetto ci occorra.
Pagina 45
Scommetto–aggiunse la maestra–che molti
fra voi, la mattina, si fermano a comprare cin-
que centesimi di castagne.
I bimbi si misero a ridere.
–Or bene, se nei tempi remoti le castagne
avessero fatto gola ai bambini, essi avrebbero do-
vuto dare in cambio delle castagne una mancia-
ta di grano, o qualche altra cosa che al vendi-
tore di castagne avesse fatto comodo; e se la co-
sa non gli fosse convenuta, i bambini avrebbero
dovuto rimanere a bocca asciutta.
–Che brutti tempi!–esclamarono i bambini.
– Brutti davvero – rispose la maestra– ma
l’uomo, aguzzando l’ingegno, lavorando indefes-
samente e studiando, è riuscito a migliorarli ed
a procurarsi tutti quegli agi e quei comodi, di
cui ora godiamo.
DOMANDE–Perchè le monete si fanno di rame, d’argento
e d’oro? A che cosa servono le monete?
La carità
LUISA TORRIOLI aveva un salvadenaro pieno di
soldi e ogni giorno ve ne metteva, perchè il
nonno e gli zii le davano sempre monete di ra-
me, e anche d’argento, quando aveva buoni punti
a scuola.
Nei giorni di vacanza, quando Luisa andava
a spasso insieme con la mamma e le sorelle mag-
Pagina 46
giori, faceva lunghe soste davanti alle vetrine in
cui erano esposti i balocchi, e sempre diceva:
–Domani rompo il salvadenaro, e mi compro
quella bambola–e indicava la più bella.
Ma a casa, la brama di aver la bambola era
già raffreddata e il salvadenaro restava intatto, e
si empiva ogni giorno di più.
In casa di Luisa andava, come lavandaia, una
certa Brigida, donna carica di figliuoli, che non
accozzava mai il desinare con la cena. Il marito
di lei faceva il muratore, ma guadagnava poco
e nei giorni di cattivo tempo non lavorava. Così,
quasi tutto il carico della famiglia era sulle spalle
di Brigida, che passava le giornate al lavatoio
o a stendere.
Un giorno Brigida riportò il bucato, mentre
Luisa era in casa, e la bimba le domandò se man-
dava a scuola le piccine.
–Ce le manderei tanto volentieri, ma come
fare? Sono tutte senza scarpe, e scalze non le ri-
cevono a scuola. Così, verranno su ignoranti co-
me me–disse la lavandaia con un sospiro.
– Che disgrazia–pensava Luisa–che quel-
le povere piccine, per la miseria della loro fami-
glia, non possano neppure imparare a leggere ed
a scrivere.
Mentre ruminava nella mente questi pensieri,
le venne fatto di gettar gli occhi sul salvadenaro,
e un sorriso le brillò sulle labbra. In un attimo
corse dalla Brigida.
Pagina 47
– Dimmi – le domandò – quanto ti ci vor-
rebbe a comprar le scarpe alle tue tre bambine
per mandarle a scuola ?
– Una quindicina di lire, signorina : ma chi
vuole che me le dia ?
Luisa andò dalla mamma e le domandò:
– Non è vero che sono proprio miei i quattrini
del salvadenaro ?
– Sicuro.
– E se li volessi spendere tu me lo permet-
teresti ?
– Purchè tu li spendessi utilmente.
– Vorrei acquistare le scarpe alle bimbe della Bri-
gida, perchè potessero andare a scuola. Così, stan-
do a casa per non avere scarpe, non imparano
nulla, poverine !
La mamma prese fra le braccia la Luisina e la
coprì di baci, ripetendole :
– Fa’ sempre un uso così nobile del denaro,
non ti mancheranno le benedizioni di Dio e dei
poveri.
Il salvadenaro fu spezzato, e la Brigida po-
tè mandare a scuola le sue bimbe.
DOMANDE – Perchè la Brigida si affliggeva di non poter
mandare a scuola le sue bimbe ? Perchè la mamma di Lui-
sa la baciò con tanta effusione ? Come si chiama l’atto di
Luisa ?
Le gioie che procura un’azione buona e gentile
sono assai grandi. Nessuno si priverebbe di quelle
gioie se le avesse provate.
Pagina 48
La preghiera interrotta
TUTTE le mattine, alle sette, la signora Giulia
entrava in camera di Beppino, che era il mi-
nore dei figliuoli, e spalancava le imposte.
Il bambino soleva balzar sul letto e, con gli
occhi ancora imbambolati dal sonno, ma col sor-
riso sulle labbra, stendeva le braccia alla mam-
ma, la quale lo baciava.
Poi la signora Giulia dicevagli :
– Ora ringrazia Iddio, e pregalo di assisterti
e di farti esser buono.
E Beppino prendeva a dire :
– « Signore, che sei nel Cielo, benedicimi e fam-
mi essere buono, ubbidiente, sincero e veritiero.
Conserva il babbo mio e la mia mamma, spargi
le tue benedizioni sui miei fratellini, su tutta la
mia famiglia, su questa città e sulla mia patria
che è l’Italia »
Una mattina Beppino disse le prime parole
della preghiera, ma quando fu a pronunziare la
parola « sincero » , si fermò ; le labbrucce inco-
minciarono a tremargli e vedendo che la mam-
ma lo guardava meravigliata, finì per dare in
un dirotto pianto.
La mamma lo prese fra le braccia e cercò di
consolarlo ; ma Beppino piangeva sempre.
– Dimmi, che cosa ti affligge ?
– Mamma... non sono stato sincero col babbo
iersera.
/ BEGIN PAGE [49] /
...finì per dare in un dirotto pianto. pag. 48
Pagina 50
E qui un nuovo diluvio di lagrime.
– Perchè non sei stato sincero ?
– Ti rammenti? dopo pranzo, mi domandò se
ero stato buono a scuola, e io gli risposi di sì;
invece non era vero; sentirai, stamani, che cosa
ti dirà la maestra !
– Ma che cosa facesti mai ?
– Detti noia al Segni che mi sta accanto, e
la maestra mi fece uscire di classe.
– Male – disse la mamma fattasi seria.
Peggio però l’aver taciuto quel fatto al babbo.
La prima cosa è una monelleria; la seconda
una colpa. Ora, termina la tua preghiera, e poi
verrai dal babbo a confessargli la tua bugia. –
Quella confessione fu un boccone amaro per
Beppino, ma dovette farla, perchè sapeva bene
che, se si fosse rifiutato, la mamma, gli avrebbe
negato il perdono.
Invece glielo accordò, ma a patto che non
avrebbe più detto nessuna bugia.
DOMANDE : Perchè Beppino interruppe la preghiera ? Per-
chè la mamma giudicò con tanta severità la bugia detta
al babbo ? Perchè obbligò Beppino a confessargliela? Che
cosa è la bugia ?
La perseveranza è una bella virtù.
Chi fa il proponimento, per esempio, di esser
sincero, deve perseverare in quel proponimento
sempre. Quanti bimbi non si propongono di non
dir più bugie, e in quella colpa non ricadono
spesso !
Pagina 51
Il proponimento non costa nulla. Invece è dif-
ficile perseverare in un proponimento, e il perse-
verare è merito.
Dio è presente dovunque
Dovunque il guardo io giro,
Immenso Dio, ti vedo;
Nell’opre tue t’ammiro,
Ti riconosco in me.
La terra, il mar, le sfere
Parlan del tuo potere;
Tu sei per tutto, e noi
Tutti viviamo in te.
Pietro Metastasio
Dal chicco al granaio
LA maestra un giorno aveva posato sulla cat-
tedra una ciotola piena di chicchi giallastri. Gli
scolaretti allungavano il collo ed aguzzavan gli
occhi per distinguere che cosa contenesse la cio-
tola.
– Non son confetti – disse la maestra, sorri-
dendo. – Venite un po’ qua e ditemi che cosa
sono questi chicchi.
– Saranno chicchi d’orzo – disse uno scola-
retto.
– Ma che ! – rispose un altro–Non vedi che
son chicchi di grano ! Sono stato una volta in
Pagina 52
Spiga
campagna, col nonno, e ne ho veduto tanto del
grano nel granaio.
– Hai ragione, caro, questi sono proprio chic-
chi di grano, e da questi chic-
chi nasceranno tante altre
pianticelle.
– Come fanno a nascere le
pianticelle del grano ? – do-
mandò un bambino.
– Ecco come nascono : il
contadino prende un sacchetto
di questi chicchi e li semina
nella terra arata di fresco.
Altri contadini gli vanno
dietro e a mano a mano, rico-
prono i chicchi con la terra.
– Quando si seminano i
chicchi del grano ?
– Prima che venga la cat-
tiva stagione, cioè d’autunno.
Le piogge bagnano i chicchi, e li ammorbidi-
scono. Quei chicchi ingrossano e da ognuno di
essi nasce una pianticella verde. La neve spesso
ricopre la pianticina, ma non le fa male.
Quando poi vien la buona stagione, la pianti-
cina cresce cresce e fa la spiga. Questa granisce
e matura e allora di verde che era diventa gialla.
Come sono belli nel giugno i campi, tutti co-
perti di spighe di grano, del color dell’oro !
Allora i mietitori hanno un gran da fare per
Pagina 53
mietere il grano. Essi vanno nei campi e con
la falce tagliano tutte le spighe, che poi riuni-
scono in covoni.
Quei covoni sono caricati su carri tirati da
buoi e portati sull’aia.
Qui sono i battitori che battono le spighe per
farne uscire i chicchi belli puliti, e per battere
si servono del correggiato.
Quando i chicchi sono stati ammucchiati ven-
gono posti nei sacchi e portati nel granaio.
Vedete quanto lavoro richiede la coltivazione
del grano ? Vedete quanta gente si affatica per
seminarlo, mieterlo, batterlo e riporlo nel gra-
naio ?
DOMANDE – Come si semina il grano ? Come nasce ?
Che cosa fanno i mietitori ? Perchè si batte il grano ?
Dove lo si ripone ?
Dal granaio al forno
– CREDETE che il grano si lasci sempre nel gra-
naio? – domandò un’altra volta la maestra.
– No – risposero gli scolarini.
– Che cosa si fa col grano ?
– La farina.
– Ma, per ridurre i chicchi del grano in fa-
rina, bisognerà pur fare qualcosa !
– Sissignora, il grano si porta al mulino.
– Avete mai visto un mulino ?
Pagina 54
Nessuno degli scolaretti lo aveva visto e al-
lora la maestra disse :
– Nel mulino vi sono certe pietre grosse, dette
macine, che girando stritolano i chicchi e li ridu-
cono in farina.
E con la farina che cosa si fa ?
– Il pane – rispose un bambino.
– Benissimo, ed il pane come si fa ?
– Per fare il pane, si stempera nell’acqua tepida
un pezzo di lievito, che è pasta inacidita. Si aggiun-
ge altra acqua e farina, e s’impasta e si lavora.
– Se sai tanto bene come si fa il pane – do-
mandò la maestra – mi saprai anche dire perchè
ci si mette il lievito ?
– Per far lievitare il pane.
Se non ci si mettesse, il pane sarebbe come
un masso. Con il lievito, invece, gonfia e diventa
soffice. Lo so, perchè il mio babbo è fornaio–ag-
giunse il bambino, tutto lieto d’essere interrogato
e di saper rispondere.
– Il pane – disse la maestra – si lavora nella
madia e si cuoce nel forno, che si scalda con le
fascine.
Quando il forno è caldo, lo si spazza con fa-
scine verdi, vi si mette il pane e poi lo si chiude.
– E quando il pane è cotto, lo si mangia– disse
un bambino che non vedeva l’ora di far merenda.
– Sapete – domandò la maestra – perchè noi
domandiamo a Dio che ci dia il pane quoti-
diano ?
Pagina 55
Gli scolarini non lo sapevano.
–Ebbene, noi rivolgiamo quella preghiera a Dio
perchè il pane è l’alimento principale dell’uomo;
e anche i poveri che cosa chiedono per carità?
– Un tozzo di pane.
– Vedete dunque che il pane ci è indispen-
sabile; senza tante altre cose si potrebbe vivere,
ma senza il pane no.
DOMANDE – Come si macina il grano? Come si fa il pane?
Come si cuoce ? Perchè domandiamo a Dio il pane quo-
tidiano ?
Iddio ha provvisto ai bisogni di tutte le crea-
ture.
Egli ha dato loro l’aria per respirare, il sole
per iscaldarsi, le piante per nutrirsi. Noi però
dobbiamo lavorare per trar frutto da tutti i doni
di Dio, ed essergli costantemente grati della sua
Provvidenza.
L’abbondanza
Quest’aperta campagna
Ed il fiume che bagna
Le sponde, e fa rumore,
Il villan che all’ardore
Del sole i campi miete;
Le contadine liete
Che dietro in lunga riga
Van cogliendo la spiga,
Pagina 56
Alle falci sfuggita,
Mi ridonan la vita.
I poledri lontani
Fanno la ruota, e il grano
Scuoton dall’ugne; al vento
Altri ’l gittano, e lento
E pulito ricade,
E s’ammucchian le biade;
Ecco il pane che a tutti
Iddio dispensa; e i frutti
L’uomo ingordo rinserra:
Li apre a tutti la terra.
G. Maccari
I pettirossi
LE prime foglioline cominciavano a spuntare
dagli alberi. Quelli che le avevano conservate
tutto l’inverno si coprivano, sulle vette dei rami,
di un verde più tenero.
La primavera si annunziava già.
In una folta siepe di bossolo due pettirossi co-
struirono il nido. Quante volte non dovettero
volare per portare i fuscellini di paglia necessa-
rj a preparare una solida casetta per la loro
famiglia ! Quanti altri viaggi non dovettero
fare per procurare una cuccetta soffice alle loro
uova !
Finalmente smisero di lavorare e la femmi-
na del pettirosso depose nel nido cinque uova,
Pagina 57
che non abbandonava mai per tenerle calde
col calore del corpo.
Il marito trillava sur un ramo vicino per te-
nerla allegra, e volava qua e là per procacciarle
il cibo.
In breve da quelle piccole uova sbucaron fuori
cinque pettirossini senza penne, che stavano
sempre col becco aperto, chiedendo il cibo.
La mamma, dopo aver dato loro l’imbeccata,
li riscaldava coprendoli con le ali. E il babbo,
da un ramo vicino, gorgheggiava per tenerli buoni
e insegnar loro a cantare.
Quando i piccini furono cresciuti ed ebbero
messo le penne, il babbo disse loro :
– Miei cari piccini , è tempo di provarvi a
volare. Iddio ci ha fatto dono delle ali per inal-
zarci nell’aria e scoprire tutte le meraviglie che
egli ha creato. Bisogna giovarsi dei doni di Lui.
– Proveremo.
E provarono difatto. Il babbo li fece volare dal
nido sur un ramo più basso. I piccini tremavano
e una femminuccia pensava :
– Come devo fare ?
Ma quando vide i fratellini posarsi sani e salvi
sul ramo, si provò anche lei.
Nei giorni successivi il babbo pettirosso con-
duceva i suoi piccini nei boschi, nei giardini ed
essi erano molto contenti di volare.
–Come abbiamo fatto bene a ubbidirgli !–
pensavano.
Pagina 58
DOMANDE – Perchè gli uccellini costruiscono il nido
con cura? Perchè la madre non abbandona le uova? Per-
chè il babbo insegna agli uccellini a volare ? Perchè i
pettirossini erano contenti di avere ubbidito ?
Quando i genitori o i maestri propongono ai
bambini d’imparare qualcosa di nuovo, i bambini
debbono sempre mostrarsi volenterosi. Ogni nuova
cognizione che acquistano procura loro un pia-
cere. E mostrandosi volenterosi contentano i ge-
nitori e i maestri, che si studiano sempre di edu-
carli ed istruirli.
La canzonetta delle stagioni
Il tuo verde allieta il cuore,
O soave Primavera.
Delle mammole l’odore
Da ogni siepe esala già.
Che farà la Marietta ?
Comporrà dei mazzolini,
Ascoltando gli uccellini,
Che gorgheggian dal piacer.
Rosse fragole in Estate
Son nel bosco e nel giardino
Ronzan l’api affacendate
Fitte intorno all’alvear.
Che farà la Marietta
In quei giorni senza fine ?
A infilar margheritine
Quieta in casa resterà.
Fichi, pesche, mele e pere
Son d’Autunno nel pomario;
Pagina 59
E dell’uve bianche e nere
La vendemmia allor si fa.
Che farà la Marietta ?
Coglierà gli ultimi fiori,
E cessati i gran calori,
Goderà di passeggiar.
Ma l’Inverno innanzi viene
E la neve è sopra i tetti:
Meglio assai che ai caminetti
Ci si scalda col saltar.
Mosca cieca e battimani
Tengon calda la Marietta,
Ed allegra il Ceppo aspetta
Con regali in quantità.
Gli alberi
LA buona maestra condusse una mattina i suoi
scolarini in giardino. Molti alberi erano sfron-
dati dai venti di dicembre, altri conservavano le
fronde.
Ella additò loro un gruppo di cipressi, e do-
mandò :
– Come si chiamano ?
Molti risposero :
– Quelli si chiamano alberi – Ma Berto Car-
li disse invece :
– Quelli sono alberi, e si chiamano cipressi.
– Bravo – disse la maestra.
E quelle pianticelle che rivestono il prato, co-
me si chiamano ?
Pagina 60
– Erbe.
– Notate nessuna differenza fra gli alberi e le
erbe ?
– Sissignora – rispose Berto Carli–Gli alberi
sono alti e grossi e le erbe sono piccine e deboli.
– Ma c’è un’altra differenza fra loco, mi pa-
re. Vedete che le erbe si piegano tutte a questa
brezza leggiera, mentre gli alberi stanno fermi?
– Sì, perchè gli alberi hanno il fusto di legno
e le erbe lo hanno....
– Erbaceo–disse la maestra–Albero, tenetelo
a mente, è il nome generico di tutte le piante
che hanno il fusto legnoso.
Che cosa hanno gli alberi sul fusto ?
– I rami.
– Ebbene, avrete veduto che in primavera i ra-
mi degli alberi si rivestono di fiori e di foglie e poi
maturano frutti.
Alcuni alberi maturano frutti grati al nostro
palato e che noi mangiamo. Altri portano frutti
che gli animali mangiano, altri invece ne portano
che nessuno mangia.
Molti alberi perdono in autunno le foglie e ne
metton fuori di nuove in primavera.
Altri serbano le foglie in tutte le stagioni.
Per esempio questi cipressi, come vedete, ser-
bano le foglie; anche quegli alberi di limone, che
crescono là, a ridosso al muro, hanno le foglie.
Questo noce che stende qui vicino i suoi larghi
rami, è privo di foglie.
Pagina 61
Gli alberi che serbano le foglie, come i cipressi,
i limoni e tanti altri, si dicono sempreverdi.
Il cipresso, come vedete, fa frutti. Raccoglie-
tene alcuni. Quei frutti si chiamano còccole, e le
còccole non sono buone da mangiare.
Certi alberi come le querce, portano frutti, detti
ghiande, che sono mangiati soltanto dai maiali.
DOMANDE – Come si distinguono le erbe dagli alberi ?
Quale è la parte principale dell’albero? Di che cosa è fat-
ta ? Che cosa portano gli alberi ? Tutti gli alberi ci for-
niscono frutta da mangiare ?
Il legname
– I ciliegi, i peschi, i fichi, i susini, gli albicocchi,
i meli, i peri, i mandorli, gli aranci, i nocciòli,
portano frutti che noi tutti mangiamo – disse
la maestra.
Mi sapreste dire se gli alberi ci forniscono
soltanto le frutta ?
– Ci dànno anche il legname – rispose Berto
Carli.
– E che cosa si fa col legname ? Sentiamo se
sapete dirmelo.
– Si fanno le barche.
– Soltanto ?
Berto volse in giro l’occhio e aggiunse :
– Le porte, i telai delle finestre, i banchi, le
tavole.
Pagina 62
– I carri, le carrozze... – disse un altro sco-
laretto.
– E anche le travi, le botti e i tini – aggiun-
se un terzo.
– Ma bravi ! Con il legname, dunque, che ci è
fornito dagli alberi, facciamo le travi, che sorreg-
gono i soffitti delle stanze, e gli affissi delle ca-
se come porte, stipiti e telai per le finestre e per-
siane, che ci proteggono dall’intemperie : mobili,
carri, carrozze; botti e tini per conservare il vi-
no, e anche barche e bastimenti.
Vedete quanto ci sono utili gli alberi; ma, a
pensarci bene, ci forniscono anche qualcos’altro.
– Le legna – disse Berto Carli.
–Già, le legna, con le quali ci scaldiamo e con
le quali si alimentano fornaci e forni; e il car-
bone dolce, che si adopra nei fornelli, in cucina.
Gli alberi allietano la vista, riposano l’occhio,
purificano l’aria e offrono ombra ai viandanti.
Vedete dunque che essi sono utilissimi all’uomo.
DOMANDE – Che cosa ci forniscono gli alberi, oltre i frut-
ti ? A quali usi serve il legname ? Nominate gli oggetti
che si possono fare col legname.
Al giardino pubblico
TUTTI i giorni le bimbe Tosi, Emma e Nina,
e le bimbe Salvadori andavano a fare il chiasso
/ BEGIN PAGE [63] /
– Via, mi conduca dalla sua mamma – disse il guardiano – pag. 64
Pagina 64
nel Giardino Pubblico, accompagnate dalla signo-
ra Salvadori.
Un giovedì le bimbe andarono come al solito
nel Giardino Pubblico.
La mamma Salvadori si mise a sedere su una
panca del Giardino e cavò di tasca un lavoro a
ferri; le bimbe si allontanarono insieme.
Esse incominciarono a rincorrersi, e le loro
voci giulive giungevano fino all’orecchio della si-
gnora.
Emma e Nina Tosi s’eran messe a correre le
prime, e le altre cercavano d’acchiapparle.
Emma, per evitare d’esser presa, invece di cor-
rere nei viali, traversò un praticello.
– Così non vale – disse Bice fermandosi.–
Io non vengo ad acchiapparti sul prato, perchè
non è permesso andarvi.
– Che importa che non sia permesso ? vieni.
Bice non le diede retta.
Emma, indispettita da quel rifiuto, strappò al-
cune rose autunnali, che ancora fiorivano.
Un guardiano la vide, corse da lei e le disse:
– È in contravvenzione per essere entrata
nel prato, e per aver colto dei fiori. Deve pagare
una lira.
Emma si spaventò e volse uno sguardo deso-
lato a Bice.
– Via, mi conduca dalla sua mamma – dis-
se il guardiano.
Emma cominciò a piangere, e Bice si accostò
Pagina 65
a lei. Saputo di quel che si trattava, cavò dal
suo piccolo portamonete una lira, che la mamma
avevale dato per far cambiare la testa di porcel-
lana alla bambola, e la mise in mano del guar-
diano, dicendo all’amica :
– Non dirò nulla alla mamma di quel che è
accaduto , ma tu non andare nei punti del
giardino dov’è proibito penetrare, e non coglier
piú fiori.
– Non dubitare. Ma come farò a restituirti la
lira ?
– A questo non ci pensare.
Le bimbe tornarono a casa poco dopo. L’Em-
ma, che era pentita di quel che aveva fatto,
ed era grata all’amica perchè non aveva rive-
lato l’accaduto alla signora Salvadori, confessò
tutto alla mamma. Questa encomiò la Bice per la
sua condotta. All’Emma toccò una sgridata per
non aver ubbidito ai consigli dell’amica , ma le
potè restituire la lira e ringraziarla di nuovo
con effusione.
DOMANDE–Perché è proibito calpestare l’erba nei Giar-
dini pubblici ? Perchè il guardiano del Giardino volle da
Emma una lira ? Perchè fu commendevole la condotta di
Bice verso l’amica ?
I bambini maleducati non sanno far altro che
distruggere. È un piacere stupido e breve. Invece
di conservare un balocco, lo fanno in pezzi, e co-
sì si privano del piacere di trastullarsi. Chi sa
Pagina 66
conservare gli oggetti è sempre ricco ; chi li di-
strugge ne è sempre privo, e per conseguenza po-
vero.
La pianta d’amorino
UNA mattina Carlino portò in dono alla mae-
stra un bel garofano.
– Grazie tante; come odora ! – disse la mae-
– Sul terrazzino della cucina. Ce n’ho un bel
vaso tutto bocci e lo annaffio sempre da me.
– Bravo, ed hai altre piante ?
– Sissignora; sul terrazzino c’è anche un va-
so d’amorini e quelli li ho seminati io, e fra poco
faranno i fiori.
– Avrai visto come nascono gli amorini ?
– Altro ! Ero sempre a guardarli.
– Racconta dunque come hai fatto a semi-
narli e come son nati.
– La mamma comprò i semi da un giardi-
niere. Erano piccini piccini, come capocchie di
spillo. Io smossi bene la terra di un vaso, spar-
si il seme, sopra ci misi un po’ di terra e poi
l’annaffiai.
– E ti nacquero subito le piante d’amorini ?
– Nossignora. Io credevo di trovarle nate la
mattina dopo, ma la mamma mi disse che avrei
dovuto aspettare almeno una settimana, e che bi-
Pagina 67
sognava tenere umida la terra, perchè i semi si
aprissero. Non vedevo l’ora che gli amorini na-
scessero, e sempre guardavo i semi.
– E come nacquero gli amorini ?
– Una settimana dopo vidi come tanti filini bian-
chi uscir dalla terra , e in cima c’era il guscio
del seme. Dopo un paio di giorni il guscio cad-
de , e in cima a ogni filino bianco c’erano due
foglioline. Poi il filino bianco si allungò, diven-
tò verde, le due foglioline crebbero, ne nacquero
dell’altre e ora le piante d’amorino sono alte, e
in cima, accanto alle due foglie, hanno come tanti
grappoli. La mamma mi ha detto che fra poco
fioriranno e allora porterò gli amorini. Quelli sì
che odorano !
– È meglio che tu lasci i fiori sulla pianta
finchè questa non secca ; quest’altr’anno potrai
avere, invece d’uno, tanti vasi d’amorino.
– No, no, glieli porto, perchè le piante d’a-
morino fanno tanti fiori. Mi fa molto piacere di
portarglieli !
La maestra dette un bacio a Carlino e lo man-
dò a sedere.
DOMANDE–Carlino come aveva seminato gli amorini ?
Come nacquero ? Che cosa disse Carlino degli amorini ?
I vegetali
– IL vostro compagno Carlino vi ha spiegato–
disse il giorno seguente la maestra – che gli
amorini nascono dal seme. Avete visto nascere
altre piante nella stessa maniera ?
– Sissignora; io ho visto nascere i convolvoli,
che poi si sono arrampicati su due canne da una
parte della finestra, e fanno i fiori tanto belli –
disse uno scolarino.

Pianta con radice
– Io ho visto nascere dal seme
il basilico–disse un altro.
i cavoli, i pomidoro e l’insalata
nell’orto della mia comare–ag-
giunse un terzo.
– Lo credo ; perchè tutte le
piante nascono dal seme. Il seme
da una parte mette la radice nella
terra, e dall’altra manda fuori
il fusto.
Che cosa avete osservato sul fusto di una
pianta ?
– I rami, le foglie... – rispose uno scolaro.
– E i fiori – soggiunse Carlino.
– Sì , il fusto delle piante porta i rami , le
foglie, i fiori e i frutti.
Sapete come si chiama tutto quello che nasce
dalla terra, tanto che siano alberi alti alti, quanto
pianticine piccine piccine ?
Nessuno seppe rispondere.
– Ebbene, ve lo dirò io : tutto quello che na-
sce dalla terra si chiama vegetale.
I vegetali ci sono molto utili, difatto noi man-
giamo i frutti di molti di essi.
Pagina 69
Col grano si fa il pane, col riso si fa la mi-
nestra, coll’uva si fa il vino, con le ulive si fa
l’olio. Quelli che ho nominato sono frutti di ve-
getali che tutti conoscete, tutti utilissimi.
DOMANDE–Come si chiama tutto ciò che nasce dalla
terra ? Con che cosa si fa l’olio ? Che cosa è il riso ?
Le piante tessili
– NON ci credo – disse Berto Carli a un suo
compagno.
– A che cosa non credi ? – gli domandò la
maestra, che aveva udito quella esclamazione.
– Non credo che il
fazzoletto da naso sia
fatto con una pianta ,
come dice il Bini.
– Il Bini ha ragio-
ne–rispose la maestra,
il tuo fazzoletto è fatto
appunto con le fibre di
una pianta che si chia-
ma lino.
- Davvero ?
- Sì, caro, e non è
la sola pianta che abbia
fibre, le quali si filano e
Cotone
tessono. C’è pure la canapa. Con le fibre del
lino si fa la tela per le camicie , le lenzuola ,
Pagina 70
le tovaglie, i fazzoletti. Con le fibre della canapa
si fanno tele più ordinarie per le vele dei basti-
menti, per i canovacci di cucina, e si fanno an-
che gomene, corde e funi.
Canapa e lino si chiamano piante tessili, per-
chè servono a far tessuti, ma c’è un’altra pianta
tessile, che è il cotone.
Però del cotone non si filano le fibre, ma la
bambagia, che è rinchiusa dentro il frutto.
Col cotone si fanno tanti tessuti, belli e resi-
stenti.
Vedete che le piante non ci dànno solamente
cibi, bevande, legname, medicine, ma anche ci
forniscono tessuti per vestirci.
DOMANDE–Quali sono le piante tessili ? Perchè si chia-
mano così ? Che cosa si fa col lino ? E con la canapa ? E
col cotone ?
L’albero di Natale
GINO era un bimbo tanto infelice; ma tanto
buono !
Quando era in fasce aveva avuto una terribile
malattia, che si chiama scarlattina.
La scarlattina gli aveva attaccato le gambe
per modo che Gino non aveva mai potuto ser-
virsene.
Egli passava le giornate su d’una poltrona, o in
una carrozzina. La sua mamma, che gli voleva
Pagina 71
un gran bene, tentava mille cure per fargli riac-
quistare forza nelle gambe; ma tutto era inutile.
Però quella infermità non rendeva malinconico
Gino. Egli aveva l’affetto della sua mamma ,
e quello di tanti bambini della età sua, che cer-
cavano di distrarlo.
La mamma disse a Gino la vigilia di Natale:
– Stasera, come al solito, accenderemo le can-
deline sull’albero, e tu lo vedrai carico di baloc-
chi e scintillante di lumi.
Albero di Natale
– Grazie, mamma mia
cara.
– Ecco qui la lista dei
tuoi piccoli amici, che ho
invitati. Ti pare che abbia
dimenticato nessuno ?
Gino lesse la lista e ri-
spose:
– No, mamma, sulla li-
sta ci sono tutti, ma...
– Vuoi che inviti qual-
cun altro ?
– Vorrei che tu invitassi
Piero,quel povero gobbino,
figliuolo della stiratora, che è più infelice di me,
perchè è anche povero.
La mamma si affrettò a compiacere Gino , e
affinchè il gobbino non avesse da scomparire fra
gli altri invitati, lo rivestì da capo a piede. –
Gino, quella sera di festa, era tutto premure
Pagina 72
per il più infelice dei suoi ospiti. A lui empiva
le tasche di chicche, e quando la mamma dette
ai piccoli invitati il segnale di saccheggiare l’al-
bero, i più bei doni toccarono al gobbino. Gino
era beato di vederlo godere, e quando tutti gl’in-
vitati se ne furono andati, si buttò al collo della
mamma dicendole :
- Come ti ringrazio di aver invitato Piero !
Di questa festa di Natale non mi dimenticherò
più, perchè ho fatto Piero felice per molto tempo.
– Continua a pensare ai disgraziati , a solle-
varli dalle loro miserie, e la vita sarà bella an-
che per te, angiolo mio.
Gino quella notte ebbe sogni lieti. Vedeva con-
tinuamente bimbi sorridenti intorno a sè. E fra
quei bimbi scorgeva Piero, più lieto di tutti.
DOMANDE : Perchè Gino era tutto premure per Piero ?
Perchè a lui dava i doni più belli dell’albero ? Perchè, ter-
minata la festa, sentivasi così lieto ?
Tutte le persone che hanno qualche difetto fi-
sico, cioè i gobbi, gli zoppi, i sordi, i ciechi, sono
infelici. La carità insegna che si debba essere
più premurosi con loro che con le persone prive
di difetti fisici. È una crudeltà canzonare gli
infelici, e chi lo fa, dà prova di non aver cuore.
I bambini buoni e affettuosi cercano di non far
sentire a quegl’infelici la loro sventura.
Gli auguri di Natale
Questa è la notte. Nebbioso velo
Copre la terra, le stelle asconde...
Ma pel tacente rigido cielo
Ecco, un allegro suon si diffonde.
Son le campane di Ceppo, liete
Scendon le note sul nostro cuore ;
« Pace ed amore–quel suon ripete–
A tutti gli uomini pace ed amore ! »
Nei santi gaudj della famiglia
Udite, o bimbi, quei dolci suoni,
Come una voce che vi consiglia
Ad esser sempre gentili e buoni.
Cari bambini, stretti in quest’ora
Nell’amoroso materno amplesso,
Di far felice vi sia concesso
Chi a voi la vita di rose infiora.
Enrico Nencioni
Le paure di Sandrino
NELLE lunghe vacanze di Natale e di Capo-
d’anno, la mamma di Sandrino era dovuta uscire
spesso per far visite.
Sandrino si annoiava a sentire i discorsi che
soglion fare fra di loro le signore. E poi, a dir
la verità , non riusciva a star fermo cinque mi-
nuti sulla sedia.
Pagina 74
La mamma, dunque, l’aveva lasciato a casa,
affidato alla sua balia, una certa Menica, che
era venuta in città per passare le feste.
Menica era una donna buona, ma ignorante
quanto mai ; ella aveva paura anche della sua
ombra.
Nel ritrovare il bambino al quale aveva dato
il latte , si sgomentò vedendolo andare a letto
solo, e dormire al buio. Sandrino cominciò a ri-
flettere sui discorsi della balia , e a non esser
più coraggioso come prima.
La sera andava a letto , ma ogni momento,
col pretesto di voler bere, o di aver freddo, chia-
mava più volte la mamma, e la tratteneva pres-
so di sè.
Nella notte , se gli veniva fatto di destarsi,
stava in ascolto , tremava tutto udendo scric-
chiolare un mobile, e avrebbe chiamato, se il ti-
more d’ essere sgridato dal babbo non lo avesse
trattenuto.
Una notte, che al solito si era svegliato tutto
tremante, si sentì tirar le coperte, e fu preso da
una paura pazza. Si sentiva battere il cuore forte
forte, sudava freddo e si figurava che in camera
ci fosse qualche ladro, che volesse assassinarlo.
Mentre stava così agitato, sentì dare uno strat-
tone più forte alla coperta.
– Babbo ! Babbo ! – urlò Sandrino – aiuto !
Il babbo , che dormiva nella stanza accanto,
balzò dal letto , accese il lume e accorse presso
di lui.
Pagina 75
Sandrino aveva la testa sotto le coperte.
– Ti senti male ?
– C’è un ladro sotto il letto... L’ho sentito–
disse il bambino con voce soffocata.
Il babbo alzò la coperta, guardò sotto il letto
e vide... il gatto.
– L’ho preso ! – esclamò ridendo il babbo –
metti fuori la testa e guardalo ; non c’è pericolo
che mi scappi. Guardalo, pauroso, che non sei al-
tro ; guardalo e vergògnati !
Sandrino, rassicurato dalle parole del babbo
s’indusse a guardare.
Il ladro, che gli aveva fatto tanta paura, era
il gatto di casa, il suo amico Soriano, che si ar-
rotava gli ugnoli alla coperta.
Sandrino si vergognò di aver disturbato il bab-
bo, e avendo capito che un bambino non deve
aver paura, riprese i sonni tranquilli.
DOMANDE – Perchè la Menica metteva delle sciocche
paure nella mente di Sandrino ? Che cosa avrebbe dovuto
fare Sandrino udendo parlare la Menica ? Perchè il babbo
rideva e si burlava di Sandrino ? Perchè Sandrino si ver-
gognò ?
« La paura è fatta di nulla » dice il popolo
piemontese, con ragione. Ma la paura ha le stesse
conseguenze di una malattia. Essa altera il san-
gue, guasta la digestione e interrompe il sonno.
1l coraggio è una virtù, la paura è un difetto.
La paura rende timidi e toglie la possibilità di
Pagina 76
difenderci dai pericoli veri. L’uomo coraggioso è
stimato da tutti ; il pauroso è guardato con di-
sprezzo.
L’orto della zia Balbina
LA zia Balbina era sorella del nonno di Rita
e di Gabriele.
Ella non aveva mai voluto abbandonare la
villa dove era nata, cresciuta e invecchiata.
Quando il resto della famiglia era andato a
stabilirsi in città, la zia Balbina, alle dolci insi-
stenze fattele per indurla a partire, aveva sempre
risposto :
– Lasciatemi nel mio regno. Avrete almeno
frutta mature, ortaggi freschi e belli.
Il regno della zia Balbina, era l’orto, e il suo
primo ministro, Michele, un vecchietto come lei,
che era stato un tempo garzone e poi ortolano.
Ora, che non poteva più zappare, nè faticare,
sorvegliava il nuovo ortolano.
L’orto della zia Balbina era esposto bene , e
conteneva tutto quanto può occorrere per la cu-
cina di una famiglia.
Anche d’inverno l’orto era sempre verde , e i
quadrati erano divisi da viottole coperte di ghiaia.
In un quadrato vi erano le insalate, cioè l’in-
divia, la cicoria e la lattuga.
In un altro le carote, le barbabietole, i finocchi
e i sedani.
Pagina 77
Un piccolo reparto era riservato alle erbe aro-
matiche : prezzemolo, pepolino, menta.
In un grande quadrato crescevano alti e rigo-
gliosi i cavoli, come broccoli romani con le palle
verdi o rossastre e cavoli cappucci, con le foglie
frangiate di verde , che erano l’ orgoglio della
zia Balbina.
In un altro, bianchi come palle di neve, era-
no i cavoli fiori, quelli neri con le foglie lunghe
e crespute, i cavoli rape, e le rape stesse.
In un angolo vi era la carciofaia , e le belle
e rigogliose piante di carciofi allargavano le loro
foglie seghettate, facendole ricadere fino a terra.
In un cantuccio vi erano arboscelli di salvia
e di rosmarino.
L’orto era bello e ben tenuto, e la zia Balbina
aveva ragione di guardarlo con compiacenza.
DOMANDE–Che cosa si coltiva in un orto ? Che cosa vi
si vede crescere nell’ inverno ? Nominate le insalate. No-
minate le diverse specie di cavoli. Quali sono le erbe a-
romatiche ?
Un arrivo inatteso
LA vigilia di Capo d’anno la zia Balbina era
nell’orto tutta arzilla, e, andando da un quadrato
all’altro, dava ordini a Michele.
Ella si faceva una testa di scegliere i più
belli tra i suoi ortaggi, per mandarli in dono ai
parenti, affinchè essi avessero una prova che pen-
Pagina 78
sava a loro. Michele doveva andare la mattina
dopo, per tempo, col baroccio in città, a portare
i doni al nipote Pietro, padre di Rita e di Ga-
briele.
La zia cercava le lattughe più bianche, i più
grossi cavoli fiori , i broccoli più maestosi, e in-
dicavali a Michele affinchè li tagliasse , quando
di là dal muro, sotto al quale passava la strada
maestra, udì un allegro vocìo.
Pochi istanti dopo quattro piccole braccia si
allungavano per cingere il collo della vecchia
signora.
Rita e Gabriele erano andati insieme con i loro
genitori a fare il Capo d’ anno con la zia Bal-
bina.
La vecchia signora, che non s’aspettava quella
improvvisata, balbettava fra le lagrime :
– Che bella sorpresa !
– Zia, doveva aspettarsi la nostra visita–disse
il nipote Pietro. Ella ci ha scritto che non po-
teva venire in città ; le pare che noi potessimo
lasciarla sola sola per Capo d’anno ?
In questo giorno i parenti sogliono riunirsi e
festeggiare insieme , col bicchiere in mano , la
nascita del nuovo anno. Anche se non ci avesse
spinti qui il desiderio di passare insieme questa
giornata, la gita ci sarebbe stata imposta dal do-
vere. Non è stata lei una seconda madre per me?
La zia Balbina , commossa da quelle parole,
abbracció prima il nipote, poi la nipote e quindi
Pagina 79
i bambini. Ella ripeteva con le lagrime nella
voce :
– Pietro, mi hai data una grande consolazione.
DOMANDE–Perchè la zia Balbina volea mandar doni
ai nipoti per Capo d’anno? Perchè i nipoti andarono a vi-
sitarla ? Quale dovere spingeva il nipote presso la zia?
Perchè ella diceva di esser tanto contenta ?
I giovani dabbene debbono dimostrare sempre,
in ogni occasione, molta deferenza e molti riguardi
per i vecchi. Questi, che hanno lavorato e sofferto
e sentono approssimarsi la morte, hanno bisogno
di cure , di attenzioni e di affetto. È dovere dei
giovani di aiutare i vecchi a portare il peso de-
gli anni.
Come Rita e Gabriele passarono il
Capo d’anno
– ZIA cara !
– Zia buona !
Con queste due esclamazioni e con un diluvio
di baci, Rita e Gabriele accolsero la zia Balbina,
mentre usciva di camera, la mattina del primo
dell’anno.
–Tanti augurj – disse Rita , e le diede uno
scialletto, dicendo :
– L’ho fatto tutto io ; ti farà comodo quando
vai nell’orto.
– Io ti ho fatto questo cestino, al traforo, per
metterci le chiavi – disse Gabriele.
Pagina 80
Nella stanza da desinare era preparata con
fiori la tavola per la colazione , e Michele , che
l’aveva ornata , stava in disparte a spiare se la
sua padrona si mostrasse contenta di quell’atten-
zione.
– Grazie, Michele – disse la vecchia signora.
E, chiamate tutte le persone di servizio, dette
a ciascuna un regalo in denaro.
Tutta quella brava gente ringraziò la signora
con effusione, e le augurò molti anni prosperi.
– Ti vogliono molto bene tutti i tuoi servi-
tori ?–domandò Gabriele.
– Credo, perchè li tratto bene, e mi studio di
esser giusta con loro.
I bimbi fecero allegramente colazione e quin-
di, insieme con la zia e coi genitori, andarono in
chiesa a ringraziare Iddio d’ averli assistiti e
protetti nell’anno ormai terminato, e ad implo-
rare protezione in quello che era appena comin-
ciato.
DOMANDE–Perchè le persone di servizio della zia Bal-
bina le volevano bene ? Come si deve trattare chi ci ser-
ve ? Perchè si ringrazia Iddio al finire dell’anno ? Perchè
si prega al principio dell’anno nuovo ?
I bambini, che hanno molto bisogno dell’aiuto
degli adulti in tutte le occorrenze della vita, deb-
bono esser gentili e cortesi. Quando bramano qual-
cosa, essi devono dire : « mi fai il piacere » ; quan-
do l’hanno ottenuta , ringraziare. Il segreto per
Pagina 81
esser trattati bene consiste nell’usar buone manie-
re. Un « grazie » non costa nulla, e paga di tante
fatiche.
Nel regno della zia Balbina
– ORA che abbiamo adempiuto i nostri doveri,
andiamo a divertirci–disse la zia ai piccini con-
ducendoli nell’orto.
–Come mi piace il tuo orto ! È sempre bello
così tutto l’anno? –domandò Rita.
–Che cosa intendi per bello ?
– Voglio dire, se ci sono sempre questi bei ca-
voli e questa insalata.
–No, perchè quelle che vedi ora sono piante
invernali, che non temono il freddo moderato dei
nostri paesi. Ogni stagione ha le sue piante e
nella primavera l’orto cambia aspetto. Dove
ora crescono i cavoli, si mettono le leguminose,
cioè i piselli, i fagioli, le lenticchie, i ceci, le fa-
ve e i lupini.
Ove ora vedete quella distesa di lattughe e di
altre insalate, in primavera si mettono i solani,
cioè pomidoro, petronciani, e patate.
Più in là, se foste qui in giugno, vedreste una
distesa di agli e di cipolle, e lungo il muro una
quantità di cucurbitacee, cioè di cetrioli, zucche,
peperoni, e poponi.
Le insalate, le radici, le barbabietole e le ca-
rote crescono d’estate e d’inverno.
Pagina 82
Queste diverse piante, nella stagione adatta,
si seminano in un piccolo quadrato e si annaf-
fiano. Quando sono grandicelle, si trapiantano.
Il seme, nella terra umida, si schiude.
Da esso spunta la radice, che si allunga nella
terra, e il fusto, che vien fuori e s’inalza.
– Lo sappiamo – disse Bice. – A casa met-
temmo alcuni fagioli in un vaso, e vedemmo
come ogni fagiolo, dopo pochi giorni, si spaccò.
Di sotto era spuntata la radice e di sopra le fo-
glioline. Ma le pianticelle non crebbero, anzi mo-
rirono subito.
–Le avrete tenute in casa !
–Già, Gabriele teneva il vaso sul cassettone.
–Le piante, bambini, vivono male nelle case.
Esse si nutriscono non solo dei succhi della ter-
ra, ma anche di luce, d’aria e d’acqua.
Rita, che era assai più bramosa di sapere che
il fratellino, domandò:
– Come fai , zia , ad annaffiare tutte queste
piante dell’orto ?
–Vedi quel pozzo, che è là in fondo? Se ti
ci accosti, ti accorgerai che c’è una ruota, attorno
alla quale sono appese cassette di legno, tenute
insieme da funi.
Il somaro fa girare la ruota, le cassette scen-
dono nel pozzo, si riempiono d’acqua e la scari-
cano in una vasca, da cui scorre in quei fossatelli.
Quando si vuole far andare l’acqua in un qua-
drato dell’orto, con un colpo di zappa si taglia
Pagina 83
quella piccola diga, che lo circonda, e l’acqua vi
entra.
Quell’ordigno si chiama bindolo.
Un orto richiede molte cure e molto lavoro ;
ma la terra ricompensa sempre le fatiche del-
l’uomo.
I bambini rimasero lungamente nell’orto a guar-
dare le diverse piante e ne impararono i nomi.
DOMANDE – Quali sono i legumi estivi? Nominateli. Da
che nasce la pianta? Perchè le piante non vivono in ca-
sa? Come si chiama l’ordigno che serve ad attinger l’acqua
dal pozzo?
I bambini, come le piante, hanno bisogno d’a-
ria, d’acqua e di luce. Essi devono star molto al-
l’aria aperta, lavarsi con molta acqua e non te-
mere le carezze del sole. È vero che l’aria, l’ ac-
qua e la luce non basterebbero a sfamarli, ma a
questo pensano i genitori ; Iddio li ha posti loro
a fianco perchè provvedano ai loro bisogni, finchè
sono piccini. Quando poi i genitori si fanno vecchi
e i figlioli sono grandi, sono questi che devono
pensare ai genitori, e ricompensarli di quello
che essi hanno fatto per loro.
Nel pollaio della zia Balbina
– ZIA, ce n’hai galline?–domandò Rita.
– E di molte. Venitele a vedere.
Pagina 84
La zia Balbina condusse i bimbi in una casina
piccina piccina, accanto alla stalla.
–Ecco il pollaio dove stanno le galline–disse
la zia accennando alla casina.
In quel momento una bella chioccia, seguita
da un branco di pulcini, usciva dal pollaio.
–Guarda come i pulcini vanno dietro a quel-
la gallina, che cammina piano piano ! Pare una
mamma che conduca i figlioli a passeggiare! –
disse Rita.
–La chioccia è una buona mamma per i suoi
pulcini. Le galline, quando hanno i pulcini, si chia-
mano chiocce. E guardate come li sorveglia, co-
me li tiene a dovere, eppure ne ha una ventina!
Se vi provaste a toccargliene uno, lei, che pa-
re tutta pace, vi salterebbe addosso e comince-
rebbe a beccarvi.
– Le galline non fanno l’uovo ? – domandò
Gabriele.
–Sicuro che lo fanno, e come è buono l’uo-
vo e come fa bene alla salute !
Affacciatevi al pollaio–aggiunse la zia.
I bambini si accostarono alla porta e misero la
testa dentro.
–Quante galline! Che cosa fa quella accovac-
ciata ?
–Cova le uova, dalle quali poi verranno fuori
i pulcini. Le galline sono tanto girellone, ma
quando covano, se ne stanno sempre ferme, per-
chè le uova non patiscano freddo. Vedete quan-
te cure hanno per i figli !
Pagina 85
–Perchè quell’altra gallina fa sempre coccodè,
coccodè!?
–Per avvertire che ha fatto l’uovo. Entra,
cercalo accanto alla gallina, e lo troverai.
– Eccolo ! – esclamò Rita – Come è caldo !
– Portalo alla cuoca, perchè lo metta insieme
con le altre uova che stamane ha trovato nel
pollaio. A cena si farà, con le uova, una bella frit-
tata. Bada però di non serrarlo troppo perché
potresti romperne il guscio, e allora col chiaro e
col torlo t’impiastricceresti tutto il grembiulino.
Rita corse in cucina e poi tornò con una man-
ciata di granturco, che la cuoca le aveva dato,
e lo sparse in terra.
– Vedi, come corrono tutte a prendere il bec-
chime! –disse la zia. –Ora puoi vedere che le gal-
line non sono tutte compagne; alcune hanno le
penne bianche, altre colorate...
– Sì, ma hanno tutte la cresta rossa, il bec-
co e quei ciondoletti rossi sotto il becco...
Rita e Gabriele rimasero un pezzo a veder le
galline che beccavano, e poi andarono nella stalla.
DOMANDE–Come si chiama la gallina che ha i pulcini?
Che cosa fa la gallina? Qual’è il luogo dove si tengono
le galline?
Nella stalla della zia Balbina
UN muggito lungo accolse la zia appena
ella entrò nella stalla.
Pagina 86
– Sentite, è la Bianca che mi saluta–disse la
zia.
–Chi è la Bianca? domandò Rita.
– La vacca che ha il vitellino.
Nella stalla c’era un po’ di buio e i bimbi non
avevano veduto una vacca, bianca come la neve,
legata alla greppia, che voltava la testa muggen-
do per salutare la padrona. Essi non s’erano nep-
pur accorti che un vitellino di pochi giorni pren-
deva il latte dalla mamma.
Se ne accorsero però e mandarono un grido e
fecero un balzo quando il vitellino saltò su e con
due lanci uscì dalla stalla, per tornar subito di
corsa accanto alla mamma.
–Ma è matto quel vitellino ? – disse Rita.
–No, son così tutti i bovi quando son picci-
ni: fanno il chiasso volentieri come i bambini,
ma con l’età mettono giudizio.
La zia accarezzò la Bianca e disse:
–Questa brava vacca ci dà tanto latte e col
latte facciamo il burro e il formaggio.
Rita aveva in tasca un pezzetto di pane con
una fettina di carne e lo porse alla Bianca, che
lo annusò, ma non lo prese, e alzando il collo
strappò un po’ di fieno dalla mangiatoia.
– Perchè la Bianca non vuol la carne, zia?
– Perchè le vacche e i buoi si nutriscono di erba
fresca o secca, e per questo si chiamano erbivori.
In quel mentre si fermò davanti alla stalla il
bifolco, che tornava con un paio di bovi, dal
campo.
– Dove sono stati i bovi, zia ?
A lavorare la terra con l’aratro, che è quello
strumento col quale si fanno i solchi nei campi
per seminare le biade.
Questi bovi hanno faticato tanto per lavorare
la terra, che è dura, e ora hanno diritto di man-
giare e di riposarsi. Non tutti i giorni lavorano
la terra, ma sempre si rendono utili trascinando
il carro carico.
L’attenzione dei bambini era attratta di nuo-
vo dal vitellino, che faceva lanci e corse, e ogni
tanto s’accostava alla mamma e poi, via, a un
tratto.
– Che ne farai del vitellino, zia ?
- Prima che abbia un anno lo manderò al-
l’ammazzatoio.
– Perchè, poverino ?
– Perchè noi mangiamo la carne di bove; e la
carne dei bovi giovani, che si chiamano vitelli, è
più tenera e migliore che quella degli animali
adulti.
– Poverino ! – dissero i bambini.
– È necessario, perchè noi, per nutrirci, ab-
biamo bisogno anche della carne: con la pelle
del bove si fanno le scarpe e altri lavori; con
le corna si fanno pettini e altri oggetti utilis-
simi.
Vedete, dunque, quante buone cose ricaviamo
dal bove e dalla vacca.
– Povero vitellino ! – badavano a ripetere i
bambini.
Pagina 88
Essi rimasero un altro giorno in campagna dal-
la zia e tornando in città non facevano altro che
dire quanto s’erano divertiti in campagna dalla
zia Balbina.
DOMANDE–Come si chiamano i bovi quando son picci-
ni ? Perchè si dice che i bovi sono operosi ? Che cosa ci
dànno i bovi ? Che ci dà la vacca ?
Per Capo d’anno
(alla mamma)
Un altr’anno è passato.–Un solo affetto
Tutti insieme ci accoglie a te d’intorno
E sotto il nostro tetto
Non è mutato nulla, in questo giorno.
La stessa pace e il tenero desio
Di mirarti così fiorente ognora;
Oh! ci consenta Iddio
Quest’allegrezza per lunghi anni ancora !
Vedi: come d’aprile, oggi le rose
Per te, mamma, cortesi, hanno fiorito,
E son belle e odorose,
Quasi il tempo per lor non sia fuggito.
E anche per te non fuggirà !–Fidata
All’ombra mite del filiale amore,
Trascorrerai beata
De’ cari giorni tuoi placide l’ore.
Spira invano il dicembre: invan ci appresta
L’inverno i mesti dí, la nebbia, il gelo;
Pagina 89
Noi ti facciamo festa,
Il sol risplende ed è sereno il cielo.
Chè, quando in mezzo a noi sincera
È la letizia del tuo dolce riso,
Mamma, la primavera
Ride per noi, se ti guardiamo in viso.
Marianna Giarrè Billi
La divisione dell’anno
– DUNQUE ci siamo lasciati nel 190.. e ci ri-
vediamo nel 190..
Con queste parole la maestra della seconda
incominciò la lezione.
Il primo giorno di ogni anno è festa so-
lenne per quasi tutti i popoli civili; e quel gior-
no si chiama Capo d’anno.
– Io non so come si faccia a contare gli an-
ni–osservò uno scolaretto.
– Sai di quanti giorni si compone l’anno ?
– L’anno si compone di 365 giorni.
– Ebbene, poiché i giorni si compongono di
24 ore e in ogni giorno sorge e tramonta il sole,
basta tener conto di quante volte è sorto e tra-
montato il sole, per sapere quando termina
l’anno.
I 365 giorni di cui si compone l’anno, come
si dividono ?
– In mesi.
Pagina 90
– E quali sono questi mesi ?
– Sono gennaio, febbraio, marzo, aprile, mag-
gio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, no-
vembre e dicembre.
– Benissimo ; hai detto tutti i 12 mesi del-
l’anno per ordine, senza sbagliarne neppur uno.
Ora, mi sapresti dire come si dividono i mesi ?
– I mesi si dividono in settimane.
– E quanto sono le settimane ?
– Non lo so.
– Sono 52, ma saprai di quanti giorni si com-
pone una settimana.
Lo scolaretto riflettè un poco , e si vedeva
bene che ripeteva i nomi dei giorni, per sapere
quanti erano.
– Dimmi i nomi dei giorni della settimana.
– I nomi dei giorni della settimana sono : lu-
nedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato,
domenica.
– Dunque quanti sono ?
– Sette.
– E le stagioni ?
– Le stagioni sono quattro: primavera, estate,
autunno e inverno.
– I mesi non hanno tutti un numero eguale
di giorni. Alcuni sono di 30 giorni, altri di 31,
e febbraio, che è il più corto, è di 28.
Ogni quattro anni il febbraio è di 29 giorni.
L’anno che ha febbraio di 29 giorni, si chia-
ma bisestile, e quel giorno aggiunto, bisesto.
Pagina 91
L’anno bisestile ha 366 giorni, invece di 365,
come l’anno comune.
La maestra aggiunse:
– Per non ricorrere sempre al calendario quan-
do volete sapere di quanti giorni è un mese, im-
parate questi pochi versi, e così, vi rammenterete
sempre della lunghezza dei mesi.
Trenta dì conta novembre
Con april, giugno e settembre;
Di ventotto ce n’è uno,
Tutti gli altri n’han trentuno.
Si sentì per un pezzetto scricchiolare le penne
sulla carta e tutti gli scolarini trascrissero quel
modo di dire popolare.
DOMANDE – In quanti giorni si divide l’anno ? Quanti
mesi formano l’anno ? Quante sono le settimane ? Quanti
giorni hanno i mesi ? Come si chiama l’anno che ha un
giorno di più che quello comune ?
Tempo e stagioni
IL giorno dopo la maestra prese a dire :
– In quale anno siamo ora ?
– Nel 190...–rispose un bambino.
– Credete che il mondo sia stato creato sol-
tanto da 190... anni ? – Domandò la maestra.
Chi diceva di sì, chi di no.
– No, bambini ; il mondo ha un’età molto
Pagina 92
superiore a 190.. anni. Questo numero d’anni
non è altro che l’ultimo periodo della sua esi-
stenza.
Questo periodo si chiama èra cristiana.
Ora, in quale stagione dell’anno siamo ?
Gli scolarini si misero a ridere guardando i
cristalli appannati dal freddo.
– Siamo nella stagione d’inverno , signora
maestra.
Lo scolarino che aveva risposto così, era Berto
Carli.
– Dimmi, se sai, quando comincia ciascuna
stagione.
– La primavera comincia il 21 marzo ; l’e-
state il 21 giugno; l’autunno il 21 settembre, e
l’inverno il 21 dicembre.
– Bravo. Vedo che impari anche fuori della
scuola, perchè noi non avevamo ancora parlato
della divisione del tempo.
– La mamma m’insegna tante cose.
– Ti ha anche insegnato la mamma che il
tempo non va sprecato ? Che bisogna impiegarlo
utilmente ?
– Sissignora. Ella mi ripete sempre che il
tempo passa e non ritorna, e che chi ha tempo non
aspetti tempo e che il tempo è moneta.
– Vedo che la tua mamma ti dà saggi av-
vertimenti.
Berto si fece rosso dalla consolazione sentendo
lodare la sua mamma.
Pagina 93
DOMANDE–Che cosa è l’èra cristiana ? Quando incomin-
ciano le stagioni ? Perchè non si deve sprecare il tempo ?
Chi ha tempo non aspetti tempo
LA mamma badava a ripetere a Tonino :
- Studia, bambino mio, invece di baloccarti.
- C’è tempo, mamma.
- Ma i giorni passano e se non istudii, ti toc-
cherà poi ripeter la seconda.
- Ce ne sono tanti dei giorni da qui a luglio!
Questi discorsi fra la mamma e Tonino inco-
minciarono subito dopo la riapertura delle scuole,
e durarono per tutto l’anno.
Tonino non trovava mai il verso di mettere
il capo a partito.
Peraltro, quando si avvicinò il tempo degli
esami, Tonino era tormentato da una certa irre-
quietezza.
La sua coscienza gli rinfacciava che egli non
aveva imparato nulla, e vedeva con dolore che i
giorni passavano presto.
Quando fu proprio agli sgoccioli si mise a stu-
diare; ma sì ! Era troppo tardi.
Tonino tornò dagli esami tutto scorbacchiato,
vedendo la sua mamma umiliata per la cattiva
figura fatta da lui.
Invece, com’erano felici le mamme dei suoi
compagni studiosi, i quali avevano risposto con
franchezza e bene !
Pagina 94
Tonino disse fra sè :
- Uno scorno come quello d’oggi non voglio
più soffrirlo.
E si mise alle costole di una sua sorella, che
già aveva terminato le elementari, e le disse :
- Marietta, vuoi aiutarmi a prendere una ri-
vincita a ottobre ?
Marietta acconsentì alla domanda, e fece stu-
diare assiduamente Tonino durante le vacanze
È vero che Tonino non aveva bisogno di sti-
molo.
Si rammentava troppo bene di quel brutto
giorno della sua disfatta.
A ottobre si presentò all’esame di riparazione
senza tremare.
Era sicuro di sè.
E rispose così bene che fu promosso.
Quel giorno lo compensò dall’altro che era sta-
to tanto triste, perchè egli vide la sua mamma
sorridere di consolazione.
Egli non dimenticò più la verità che racchiude
il proverbio popolare : Chi ha tempo, non aspetti
tempo, e studiando sempre ottenne nella scuola
il primo posto, e formò la consolazione della
mamma.
DOMANDE – Che cosa avvenne a Tonino per aver spre-
cato il tempo ? Perchè tremava nel presentarsi all’esame ?
Perchè soffriva dopo ? Quali propositi fece Tonino ? Li
mantenne ? Qual premio ne ottenne ?
Pagina 95
Volere è potere. Chi vuole una cosa e la vuole
fortemente, è difficile che non riesca ad ottenerla.
Per questo nessuno compatisce i bambini che di-
cono di volersi emendare di un difetto e poi ad-
ducono il pretesto di non aver potuto. Quando
si vuole davvero, si può.
Il 9 Gennaio
- DOMANI, bambini, la scuola è chiusa in se-
gno di lutto.
- Chi è morto ? – domandò una bambina alla
maestra.
- Nessuno; ma il 9 gennaio ricorre l’anniver-
sario della morte di Vittorio Emanuele II.
- Chi era ?
- Vittorio Emanuele II fu il primo Re che
avesse l’Italia.
La maestra aggiunse :
- La scuola è chiusa dunque, ma io desidero
che sappiate perchè l’Italia serba tanta venera-
zione e tanta riconoscenza a quel sovrano.
Vittorio Emanuele II morì a Roma il 9 gen-
naio 1878.
La salma di lui riposa nel Pantheon, il quale è
il monumento più insigne, che ci resti, della gran-
dezza romana.
E il popolo d’ Italia volle che appunto fos-
se collocata là per rammentare i grandi fatti
Pagina 96
compiuti dal suo Re, e per attestare la ricono-
scenza degli Italiani.
Vittorio Emanuele II era Re di Sardegna.
L’Italia, quando egli prese la corona sul cam-
po di battaglia di Novara, era divisa in tanti
Stati.
Alcuni di questi Stati erano governati dagli
stranieri.
Gl’Italiani, come tanti fratelli, costretti a vi-
ver separati, avevano una brama intensa di riu-
nirsi in una sola famiglia.
Ogni tentativo da essi fatto per giungere a
quest’intento, fruttò a molti l’esilio, il carcere e
la morte.
Vittorio Emanuele, che aveva cuore magnani-
mo, fu commosso dalle sofferenze degli Italiani
e raccolse i loro gridi di dolore.
Egli mosse guerra all’Austria nel 1859, e con
l’aiuto dei Francesi la vinse, dando prova di gran-
dissimo valore.
In pochi anni riuniva in un solo Regno tutta
l’Italia; e di Roma , che era il sogno degli Ita-
liani , il 20 settembre 1870 , faceva la capitale
del suo Regno.
Egli morì circondato di gloria e di rimpianto,
lasciando la corona a Umberto I, suo degno suc-
cessore.
Umberto I regnò 22 anni e morì il 29 lu-
glio 1900, a Monza.
Ora il Re d’Italia è Vittorio Emanuele III.
Eccovi spiegato perchè si fa vacanza il 9 gennaio.
Pagina 97
DOMANDE – Perchè Vittorio Emanuele II. meritò la
riconoscenza degli Italiani ? Quale fu la gloria maggiore
di quel Re ?
Tutti dobbiamo amare l’Italia, che è la nostra
patria. Tutti dobbiamo servirla e, nel momento
del bisogno, dare per lei anche la vita.
Il cuore di Vittorio Emanuele II.
BERTO CARLI, andando a casa, rifece a salti
e a sbalzi la storia di Vittorio Emanuele II, men-
tre il babbo suo stava seduto, dopo pranzo , fu-
mando il sigaro, e la mamma ricamava.
Il bambino, quando ebbe terminato il suo rac-
conto, esclamò :
- Che cuore doveva avere quel Re !
- Grande davvero – rispose il babbo. – Egli
aveva per i bambini un amore speciale , e com-
pativa tanto i poveri e gl’infelici.
Un giorno, andando a caccia–perchè Vittorio
Emanuele II. era guerriero e cacciatore–incontrò
un bambinetto, che s’inerpicava scalzo su per una
ripida e sassosa viottola di montagna.
Il bambinetto portava le scarpe sulle spalle.
Il Re gli domandò:
- Perchè non ti metti le scarpe ?
– Fossi matto ! – rispose il bambino, che non
lo conosceva – le scarpe si consumano coi sassi.
– E i sassi non ti consumano e non ti lacerano
i piedi ?
– Ma la pelle dei piedi non costa nulla, e le
scarpe costan quattrini.
Vittorio Emanuele rise di quella arguta rispo-
sta e domandò al bambinetto come si chiamava.
– Alberto.
– Tu porti il nome di mio padre. Eccoti venti
lire, comprati le scarpe e risparmia i piedi.
Il bambinetto andò via tutto contento, e solo
più tardi seppe che il generoso donatore era pro-
prio il Re.
Vittorio Emanuele II, oltre il defunto re Um-
berto, aveva altri figli.
Uno di questi, per nome Oddone, era malatic-
cio e gobbo.
Il Re l’amava teneramente, e provò un dolore
profondo per la morte di lui.
Ogni giorno il Re, uscendo dal suo palazzo di
Torino, ove era allora la capitale del Regno, in-
contrava un gobbetto, che chiedeva la carità ai
passanti.
Il Re, nel vederlo, faceva sempre fermare la
carrozza e gli dava una larga elemosina , di-
cendo :
– Quel poveretto mi rammenta il mio Oddone.
– Vittorio Emanuele II, come ti ho detto–con-
tinuò il babbo di Berto Carli–era appassionato
/ BEGIN PAGE [99] /

- Ma la pelle dei piedi non costa nulla… pag. 98
Pagina 100
cacciatore. Mal vestito, spesso passava più giorni
sulle Alpi, a caccia ai camosci.
Una volta entrò in un misero tugurio, e, trovan-
dovi un vecchio, gli chiese qualcosa da mangiare.
Il vecchio gli dette quel poco che aveva, e
non conoscendolo, prese a parlare familiarmente
col suo ospite. Fra le altre cose gli narrò che
aveva un figlio soldato , in uno dei reggimenti
dell’esercito, e che, mancandogli quel figlio, gli
mancava ogni appoggio.
Il Re non disse nulla, ma s’impresse bene in
mente il nome e il reggimento del soldato, e do-
po aver confortato il vecchio a sperare in giorni
migliori, lo pagò e usci.
Tre giorni dopo il soldato tornava alla casa
paterna. Il Re l’ aveva mandato a confortare il
vecchio padre. Il quale, saputo che l’ ospite suo
era Vittorio Emanuele II, non cessò di benedirlo.
Il vecchio sopravvisse al Re , e il giorno dei
funerali solenni, sfidando mille sacrifizj volle re-
carsi a Roma, per dargli l’ultimo attestato della
sua gratitudine.
DOMANDE–Era buono Vittorio Emanuele II ? Perchè il
signor Carli diceva che il Re aveva un gran cuore ? Nar-
rate, se lo sapete, qualche tratto della bontà d’ animo di
Vittorio Emanuele II.
La Patria
LA maestra della seconda elementare aveva
tratteggiato alla sua classe , come vi ho detto,
Pagina 101
i fatti più gloriosi del Regno di Vittorio Ema-
nuele II.
Gli scolarini sapevano che Vittorio Emanuele II,
era salutato Padre della Patria , perchè aveva
riuniti gli Stati divisi dell’Italia.
Ma la parola patria era per loro tuttavia o-
scura.
La maestra volle che ne capissero bene il si-
gnificato e disse:
- Voi, bimbi, avete tutti una famiglia, e vi-
vete insieme con la vostra famiglia , avendo bi-
sogno dell’ aiuto dei genitori per crescere sani,
istruiti e virtuosi.
Ma la vostra famiglia, vi pare che potrebbe vi-
vere sola e abbandonata e bastare a tutti i bisogni?
Se vostro padre, per esempio, lavorasse la terra,
potrebbe nello stesso tempo farvi le scarpe, tes-
servi i vestiti e insegnarvi a leggere ?
- No, davvero ! – rispose un bambino.
- Dunque, essa ha pure bisogno dell’aiuto di
altre famiglie.
Un capo di famiglia , per quanto industrioso,
non potrebbe procurare cibo, vesti, utensili di ca-
sa, istruzione e tante altre cose ai suoi figli.
Per questo le famiglie vivono una accanto al-
l’altra, aiutandosi a vicenda.
L’unione di molte famiglie costituisce un Co-
mune.
Ma neppure gli abitanti di un Comune pos-
sono bastare a se stessi. Essi hanno bisogno del-
Pagina 102
l’aiuto di quelli di altri Comuni per procurarsi
le cose che mancano loro , e per vendere quelle
di cui hanno sovrabbondanza. Inoltre, hanno bi-
sogno di vivere in rapporti amichevoli con gli
abitanti di altri Comuni , per la propria sicu-
rezza , per difendersi dai nemici, e per provve-
dere alle opere pubbliche.
Per questo gli abitanti di una medesima terra,
che parlano la stessa lingua e sanno che anche
nei tempi antichi si consideravano come fratelli,
si uniscono insieme e formano lo Stato.
Lo Stato è l’unione di tanti cittadini gover-
nati dalle stesse leggi.
DOMANDE–Perchè una famiglia non potrebbe viver da
sè? Come si chiama la riunione di più famiglie? Come
si chiama quella di più paesi e città? Che cosa è lo Stato?
L’Italia
– LO Stato nostro è l’Italia–disse la maestra–
la patria nostra, cara e benedetta, unita ora per
virtù di Vittorio Emanuele Π, è l’Italia.
L’Italia comprende 8264 Comuni, tra grandi
e piccoli.
Non sempre un paese costituisce un Comune.
Talvolta occorrono più paeselli, poco popolosi, per
formarlo.
L’Italia è molto grande, perchè i paesi che la
compongono sono distanti tra loro.
Pagina 103
Essa ha la forma di uno stivale gigantesco,
galleggiante sul mare, ed è separata dagli altri
Stati per mezzo di un’altissima catena di mon-
tagne chiamate Alpi.
Ringraziate Iddio di avervi fatto nascere in
questa bella Italia , che è la patria comune a
tutti gl’Italiani.
Amatela per le bellezze di cui l’ha adornata la
natura , per il suo glorioso passato , per gli uo-
mini grandi che la illustrarono.
Amatela e cercate di renderla rispettata. L’I-
talia, come tutte le nazioni, ha bisogno di donne
virtuose, di uomini integri, operosi e intelligenti.
La patria, non solo si serve con le armi nei
momenti di guerra, essa si serve meglio con l’o-
nestà, il lavoro, l’affetto alle opere nobili e glo-
riose.
La gloria e la grandezza della patria è gloria
e grandezza di tutti i suoi figli.
DOMANDE – Qual’è la patria nostra ? Che forma ha?
Perchè dobbiamo amarla ? Come si serve la patria ?
La bandiera d’Italia
UN’ALLEGRA fanfara militare fece balzare Berto
Carli sulla seggiola.
Chiuse il libro di lettura, respinse il qua-
derno e corse nello studio del babbo.
- Babbo, vieni alla finestra.
Pagina 104
Berto era un bambino ubbidiente e sapeva che
non doveva affacciarsi solo, perchè le finestre sono
pericolose per i bimbi. Basta che si spenzolino
un poco, e cadono di sotto. E allora ?
Il babbo lo contentò subito.
Nella strada passava un reggimento di fan-
teria.
Quei fieri soldati marciavano in perfetto or-
dine. Un giovane ufficiale portava una bandiera
tutta logora, che pendeva a brandelli.
Il bianco della bandiera, sul quale spiccava lo
stemma di Savoia, era diventato bigio ; il rosso
era sbiadito e ne restava un lembo , e solo il
verde aveva preso un colore di foglia secca bru-
ciata dal sole.
- Come sono fieri quei soldati!–diceva Berto–
quando sarò grande voglio farlo anch’io il sol-
dato.
Il babbo sorrideva.
– Vedi come marciano ? Anch’io so marciare
a quel modo; dunque potrò esser soldato...
Berto fu distratto da questi pensieri alla vista
della bandiera logora e sbiadita, e aggiunse :
– Però, se fossi ufficiale , non vorrei portare
una brutta bandiera come quella.
– Scioccherello–rispose il babbo–quella vec-
chia bandiera è l’onore del reggimento.
Tanto è vero che si dice: Bandiera vecchia fa
onore al capitano.
– Ma perchè ?
Pagina 105
- Perchè quella bandiera ha la sua storia glo-
riosa. Essa ha accompagnato, sui campi di bat-
taglia i soldati di quel reggimento; molti fra
essi hanno dato la vita per difenderla. Le palle
nemiche l’hanno traforata, essa è stata decorata,
come un soldato valoroso , e la medaglia della
bandiera è un onore per tutto il reggimento.
I soldati avevano terminato di sfilare; il suono
delle trombe si perdeva in distanza , e il babbo
fece scendere Berto dalla finestra.
Il bambino tacque per un certo tempo , poi
domandò:
- Dunque la bandiera italiana è....
- Tricolore , cioè a tre colori : bianca , rossa
e verde.
Nel bianco vi è la croce bianca su fondo ros-
so, sormontata dalla corona reale, stemma della
famiglia di Savoia.
Alla famiglia di Savoia appartenevano Vittorio
Emanuele II e Umberto I, e appartiene il nostro
Re Vittorio Emanuele III.
Quello stemma significa che l’Italia è unita sot-
to la monarchia di Savoia.
Essa è per tutti gli Italiani un simbolo sacro.
DOMANDE – Perchè il babbo disse a Berto che la bandie-
ra logora era l’onore del reggimento ? Che cosa si deve fa-
re per la difesa della bandiera ? Quanti colori ha la ban-
diera Italiana ?
Pagina 106
Italia
Lo sai tu bambino,
Che lieto e fecondo,
L’Italia è il giardino
Più bello del mondo ?
Di blanda, gentile
Favella risona.
Di monti due file
Le fanno corona.
È ricca d’onori,
Di mura, d’allori;
La adornano i fiori;
La bagnan tre mari:
Eterno la veste
April del suo manto;
Oh, Italia, celeste,
Poetico incanto !
E. Fiorentino
I colori
– CHE disdetta !
Questa esclamazione era sfuggita alla maestra
dopo ch’ ella avea guardato fuori della finestra.
E soggiunse :
– Oggi volevo appunto farvi una lezioncina
sui colori, e la neve vien giù a fiocchi, e copre
di un mantello bianco ogni cosa. Anche il cielo
è color di piombo.
Dopo un poco prese a dire:
– Ma v’è fra voi qualcuno che mi sappia di-
re di che colore è il cielo quando è sereno ?
– Azzurro – risposero una diecina di piccini.
– Va bene : il cielo dunque sapete che è az-
zurro ; sapete pure di che colore è l’ erba dei
prati ?
Pagina 107
– E le ciliege?
– Rosse – dissero tutti in coro.
– E il torlo dell’uovo ?
– Giallo.
– E le arance ?
– Giallo, ma più rosse del torlo dell’uovo.
– Le arance sono color arancione. Ma l’azzur-
ro, il verde, il rosso, il giallo, e l’arancione non
sono i soli colori che hanno le cose. Per esempio
il Carli ha un vestitino da marinaro color tur-
chino, le violette che vi divertite a cogliere in
primavera nei prati, sono di color viola.
Le rose....
Qui la maestra fu interrotta da una luce viva,
che entrava dalle finestre, e tutti i bimbi volsero
gli occhi verso il cielo, sul quale disegna vasi, a
torma di arco, un magnifico arcobaleno.
– Ecco i colori di cui vi ho parlato – disse
la maestra.
Vedete prima il rosso, poi l’arancio, poi il gial-
lo, il verde, l’azzurro, il turchino, il violetto.
– Bello quell’arco di tanti colori ! E come si
chiama ?
– Si chiama arcobaleno, ed è un fenomeno
naturale. In tempo di pioggia o di neve appa-
risce nelle nubi di contro al sole.
– Come è bello ! – badavano a ripetere gli
scolaretti.
Essi avevano appena proferita quella esclama-
zione, che il bell’arcobaleno era scomparso, e la
neve ricominciava a cadere.
Pagina 108
DOMANDE – Quali sono i sette colori dell’arcobaleno ?
Quando appare in cielo l’arcobaleno ? Che forma ha ?
Un giorno di neve
- MAMMA, che bella cosa ; guarda come nevica!
- così diceva una mattina Bice alzandosi e cor-
rendo alla finestra per vedere i fiocchi bianchi
bianchi che il vento faceva turbinare.
La mamma andò a raggiungerla, e, dietro ai
vetri della finestra, stava anch’ella a guardare la
via deserta, sulla quale la neve s’accumulava.
- Mamma, sapresti dirmi che cos’è la neve ?
- È acqua.
- Davvero ?
- Metti una tazza sulla finestra e lascia che
si riempia di neve.
Bice ubbidì subito.
Intanto che ciò avveniva, due passerotti erano
andati a posarsi sul davanzale della finestra.
Erano tutti bagnati, e non facevano udire il
loro allegro pigolìo.
Bice li guardava impietosita, e corse a pren-
dere alcune briciole di pane per gettarle sul da-
vanzale.
Gli uccellini volarono via, ma impauriti dalla
neve, tornarono subito a metterei al riparo, e si
diedero a beccare.
- Quando mi sono rallegrata vedendo nevi-
care – disse Bice – ho pensato soltanto al pia-
/ BEGIN PAGE [109] /

Bice li guardava impietosita. pag. 108
Pagina 110
cere di andare più tardi giù nel giardino a far le
palle di neve e i fantocci; ma ora, vedendo que-
sti poveri uccellini, non mi rallegro più.
– Pensi agli uccellini soltanto? Credi che es-
si soli soffrano per la neve? E gli operai che non
possono lavorare e non guadagnano ? E i pove-
retti che non hanno come ripararsi ?
Sotto il portone della casa dirimpetto, s’era
fermato appunto un lustrascarpe: un bambinuccio
scalzo, con i calzoni a brandelli.
– Guarda quello–disse la mamma.
Bice lo fissò impietosita, e domandò:
– Non hai un paio di scarpe vecchie da dar-
gli ?
– No, cara, ma posso mandar la Rosa a dir-
gli che si rifugi in cucina.
– Ci vado io – esclamò Bice, e poco dopo tor-
nava tutta lieta, annunziando che il bambino era
giù che si riscaldava e mangiava.
Intanto la tazza, posta sul davanzale, si era
empita di neve e la mamma avevala tolta per
posarla sul tavolino.
Nell’aria calda della stanza la neve non tar-
dò a liquefarsi.
– Vedi che cos’è la neve ?
– Acqua –rispose Bice. – Ma come mai cade
così condensata come se fesse fatta di tanti pez-
zettini di cristallo ?
– Perchè l’acqua, nelle regioni alte dell’aria,
ghiaccia; ghiacciando, cioè solidificandosi, forma
Pagina 111
appunto tanti piccoli cristalli, che aggruppandosi
prendono la forma di fiocchi di bambagia. Quel-
l’aggruppamento di cristalli si chiama neve. An-
che la grandine è acqua solidificata.
– Brutta cosa la neve–disse Bice guardando
i due uccellini rincantucciati e pensando ai piedi
paonazzi del lustrascarpe.
DOMANDE–Perchè la mamma di Bice disse che non do-
veva pensare soltanto agli uccellini ? Che cosa è la neve?
Come si forma? Come si forma la grandine? Come si scio-
glie la neve ?
Il corpo umano
LA maestra si rivolse ai suoi scolarmi di-
cendo :
– Oggi parleremo un poco di noi. Voi, io, tutti
abbiamo un corpo. Il nostro corpo si forma di
varie parti ; volete nominarle ?
- Nel nostro corpo c’è il capo – rispose uno
scolarino.
- Come si chiama la parte davanti, o ante-
riore del capo ?
– Viso.
– Volto.
– Faccia.
– Avete ragione tutti e tre. La parte ante-
riore del capo si chiama viso, volto o faccia; e
nel viso che cosa abbiamo ?
- Occhi, naso, e bocca , e dai due lati gli
orecchi.
– Che cosa contiene la bocca ?
– I denti e la lingua.
– Il capo però è coperto da qualcosa ?
– Dai capelli.
– E da che cosa è sostenuto ?
– Dal collo, e sotto il collo comincia il tronco.
– Mi rallegro–disse la maestra–sapete bene
il nome delle diverse parti del corpo. – Ditemi:
che cosa è attaccato al tronco ?
– Le braccia e le gambe.
– E come terminano le braccia ?
– Le braccia terminano con le mani: le gambe
con i piedi.
Il piede e la mano hanno cinque dita.
Le dita si chiamano : pollice , indice , medio,
anulare e mignolo.
Le mani ci servono per lavorare e per man-
giare.
Lo scolarino aveva detto tutte queste parole
presto presto ed ebbe molti elogi dalla maestra,
la quale continuò :
– Senza le mani non potremmo nè lavorare
la terra, nè costruire le case, nè cucire i vestiti.
I piedi ci sorreggono e ci permettono di tra-
sportarci da un punto ad un altro.
Gli uomini, che hanno le mani storpie o ai quali
manca un braccio, sono degni di compassione, per-
chè non possono lavorare; molto infelici sono pu-
re quelli che non possono far uso delle gambe.
DOMANDE–Abbiamo tutti un corpo? Quali sono le par-
Pagina 113
ti principali del corpo umano ? A che cosa servono le ma-
ni ? E dei piedi quale uso facciamo ?
Ogni bambino , prima di andare a scuola, deve
lavarsi bene il viso e le mani e pettinarsi i ca-
pelli. Un visino pulito fa piacere a vedersi , ma
come è ributtante un viso sudicio!
L’arrivo del Re
LE bandiere sventolavano alle finestre, i reg-
gimenti passa-
|
vano per le vie
al suono delle
musiche, la gen-
te a frotte cor-
reva su, verso
la piazza d’ar-
mi. La città
era in festa per-
chè in quel gior-
no, il Re Vit-
torio Emanue-
le III – arri-
vato pochi dì
innanzi – pas-
sava in rivista
i soldati della
guarnigione.
I bambini Persico , che stavano in via Venti
Pagina 114
Settembre, a pochi passi dal palazzo Reale, ave-
vano invitato tutti i loro amici per veder pas-
|
sare il Re d’I-
talia.
Prima passò
per via Venti
Settembre la
nostra bella e
buona Regina
Elena. Poi pas-
sò il Re , pre-
ceduto da’ bei
corazzieri in al-
ta tenuta e se-
guito da centi-
naia di ufficiali.
A intervalli si
udivano i colpi
di cannone e
quando il Re
giunse sotto le finestre di casa Persico, scroscia-
rono battimani ed evviva.
La rivista sarebbe durata un pezzo e i bambini
Persico, insieme con i loro amici, avrebbero dovuto
attendere molto per veder ripassare il Re, e la
Regina; perchè, prima che fossero di ritorno sareb-
bero passate tre ore almeno, e come sarebbe stato
possibile tener buoni tanto tempo quei diavoletti?
La signora Persico prima dette loro diversi li-
bri illustrati perchè si divertissero a guardar le
/ BEGIN PAGE [115] /
…si trattiene lungamente negli ospedali per confortare... pag. 116
Pagina 116
figure, poi cercò di baloccarli con diversi giuochi,
e finalmente le venne un’ispirazione e disse:
- Vi farà certo piacere che io vi parli del
compianto Re Umberto I, padre del nostro Re Vit-
torio Emanuele III; del Re buono, leale che sarà
pianto da tutto il popolo per lunghi anni ancora.
Voi saprete che una mano sacrilega tolse barbara-
mente la vita a Umberto I, il 29 luglio 1900, a
Monza. Ed io voglio narrarvi quanto Egli fece
una volta per alleviare le sventure del suo popolo;
statemi dunque a sentire.
La bontà del Re Umberto
– NEL 1884, Napoli, una fra le più belle città
d’Italia, era desolata da una terribile epidemia :
dal colera. A migliaia morivano poveri e ricchi:
e le persone sane, sgomente da quel flagello, non
facevano nulla per combatterlo. Nelle luride case
giacevano senza soccorso i malati; i morti rima-
nevano insepolti.
Re Umberto , impietosito da tanta miseria,
va a Napoli incomincia a visitare gl’infermi nei
loro tugurj, si trattiene lungamente negli ospeda-
li per confortare gli agonizzanti; va ovunque, sfi-
dando il pericolodel contagio, ordinando soccorsi.
La gente, nel vedere il Re affrontare impavido
la morte, si scuote dall’inerzia, caccia la paura
e lo aiuta nell’opera benefica.
Da un giorno all’altro Napoli cambia d’aspet-
Pagina 117
to. Non più malati senza soccorso, non più ca-
daveri insepolti. Medici, infermieri, signore, tutti
imitano l’esempio del Re, tutti dimenticano se
stessi, per pensare soltanto a chi soffre. Il nume-
ro dei malati e dei morti diminuisce subito sen-
sibilmente , e poco dopo Napoli è liberata dal
morbo. –
A questo punto della narrazione la signora
Persico fu interrotta dagli squilli lontani delle
trombe e i suoi piccoli ascoltatori corsero tutti
alle finestre per rivedere il Re e la Regina.
DOMANDE–Che cosa fece il Re Umberto durante il co-
lera di Napoli ? A che cosa giovò il suo esempio ? Come
si chiama la virtù di cui diede prova il Re Umberto ?
A S. Μ. la Regina d’Italia
Maestà, se permette,
Le dico una cosina ;
Quando noi bambinette
Giochiamo alla Regina
Fra le più brave e belle,
Non soltanto di viso,
Si sceglie una di quelle
Che han più dolce il sorriso.
E si guarda negli occhi
Quale è stata più buona.
Per vedere a chi tocchi
Di portar la corona.
Ed ecco or or m’ha detto
La maestra amorosa:
- Senti, caro folletto,
Prendi in man questa rosa,
Pagina 118
Porgila alla Regina:
Coraggio e garbo, sai ?
Bada, la mia bambina,
Se tu sbagliassi, guai !
E via ! questo timore,
Si potea risparmiare !
Tutte belle, signore...
Ma non si può sbagliare.
Ulisse Poggi
La luce
- CHIUDETE gli occhi–ordinò la maestra.
Tutti ubbidirono subito ridendo.
– Che cosa vedete ora ?
– Nulla.
– Apriteli e ditemi che cosa vedete.
– Vediamo il sole, il cielo, vediamo le pareti
della stanza e lei–rispose Berto Carli.
– Dunque a che cosa servono gli occhi ?
– A vedere.
– Va bene. Se però noi chiudessimo ora la
finestra, non vedreste, come non vedete di notte,
anche spalancando gli occhi.
Dunque perche vediamo ?
– Perchè è giorno.
– Ed è giorno, perchè c’è luce; ma quando
questa luce manca, abbiamo la notte e il buio.
Dunque noi vediamo perchè c’è la luce.
Quando la luce è scarsa, vediamo tutti i co-
lori più pallidi, e gli oggetti meno distinti.
Pagina 119
Se io vi domandassi da che cosa proviene que-
sta luce che illumina la Terra sulla quale vivia-
mo, che cosa rispondereste ?
– Dal sole.
– Appunto, ed essa ci viene direttamente.
Dunque quella luce è diretta.
Il sole, però, non illumina soltanto la Terra ma
anche la luna. La luce della luna è una luce ri-
flessa ; di fatto la sua luce è molto più pallida di
quella del sole.
Molte stelle sono pure luminose come il sole ,
e anche più.
Ma quelle stelle sono molto più lontane da noi
che il sole. Per questo la loro luce ci pare molto
pallida.
Se state vicini a una candela e poi ve ne al-
lontanate, vedrete che la luce, la quale prima era
viva, vi apparirà sempre più debole.
Noi siamo molto, ma molto lontani dalle stelle,
e per questo la loro luce ci giunge debole debole.
Invece come è viva quella del sole ! Il sole c’il-
lumina, ci riscalda, fa crescer le piante, sbocciare
i fiori e maturare i frutti. Come è bello un raggio
di sole !
DOMANDE – Basterebbero gli occhi per vedere ? Di dove ci
viene la luce maggiore ? Ha la luna luce propria? Perchè ha
poca luce ? Perchè le stelle ci mandano un luce scarsa?
La luce artificiale
– IL sole non risplende sempre–disse una volta
Pagina 120
la maestra–la mattina sorge e la sera tramonta,
e quando il sole è tramontato, è notte e tutto
rimane al buio. C’è la luna, è vero; ma non sempre
ci manda la sua luce, eppoi è una luce pallida
pallida, che non ci permetterebbe di leggere, nè
di lavorare, anche se penetrasse nelle nostre stanze.
Che cosa adopriamo per illuminare le stanze
quando è notte ?
– I lumi – rispose il Rossi.
– Quali ? Ce ne sono di più qualità.
– I lumi a petrolio, le candele, i lumi ad olio...
anzi, signora maestra, mi dice dove si trova il
petrolio ?
– Sì, caro; il petrolio si trova in pozzi sotto
terra, mentre le candele si fanno con la cera che ci
forniscono certi insetti tanto industriosi, detti api.
– Quelle api che fanno anche il miele ?...
– Appunto; però le candele comuni, che ado-
priamo tutti, sono fatte non con la cera, ma col
grasso di alcuni animali, e si chiamano candele
steariche. L’olio, col quale si empiono alcuni lumi
per tenerli accesi, da qual frutto si estrae ?
– Dalle ulive.
– Sì, l’olio si estrae dalle ulive, ma anche dai
semi di altre piante, come dal sesamo, dal lino,
dal cotone. Tanto l’olio delle ulive, quanto quello
delle altre piante, si chiama olio vegetale; mentre
il petrolio si dice olio minerale.
Ma vi sono altri mezzi d’illuminazione. Le
strade e molte botteghe sono illuminate a gas e
alcune città hanno la luce elettrica.
Pagina 121
La luce, che ci dispensa il sole, si chiama luce
naturale; l’altra, che ci procuriamo col petrolio,
con l’olio, con le candele o col gaz, si dice luce
artificiale.
Ma quanto è più gaia e bella di tutte queste
luci, la luce naturale del sole !
DOMANDE – Che cosa è il petrolio ? Dove si trova? Da
che cosa si estrae l’olio ? Quali piante hanno i semi che
contengono olio ? Come si chiama la luce del sole? E le
altre ?
Il sorriso è il sole che illumina il nostro volto.
Esso è l’ imagine di una coscienza tranquilla.
Cercate di essere sempre sinceri e buoni e il sor-
riso non isparirà mai dal vostro visino.
Il cieco
- MICHELINO, bada di non stare accanto al
fuoco quando riempi il lume a petrolio ! Una fa-
villa potrebbe tarlo incendiare. Non sai quanto
sia pericoloso il petrolio? Non sai le disgrazie che
possono accadere ?
Questi avvertimenti erano dati da un falegna-
me al suo figliuolo, il quale aveva il vizio di ac-
comodare sempre il lume in fondo alla bottega,
accanto a un fornellino dove metteva i trucioli
a bruciare, per iscaldare la colla.
Una sera, pur troppo, avvenne quello che aveva
preveduto il falegname.
Una favilla partì dai trucioli e cadde sul pe-
trolio, che Michelino versava nel lume.
Pagina 122
Il petrolio fece una grande vampata, e Miche-
lino gettò un grido straziante.
A un tratto tutta la bottega fu in fiamme,
e il povero padre ebbe appena tempo di portar
via il suo figliuolo, ma in quale stato !
Il viso, le braccia, il petto del ragazzo erano
tutt’una piaga.
Lo adagiò in una carrozza, lo portò all’ospe-
dale e dopo due mesi di patimenti, Michelino ne
usciva guarito... ma cieco.
La cecità è una disgrazia per tutti, ma è an-
che maggiore per chi deve guadagnarsi la vita.
Michelino si struggeva dal dolore di non po-
ter aiutare il padre, sapendo che questi si trova-
va in grande miseria, perchè l’incendio avevagli
distrutto tutto il legname che aveva in bottega,
e gli arnesi del mestiere.
Oh ! come gli pareva amaro il pane che man-
giava a ufo !
Egli tanto fece, tanto si raccomandò ai me-
dici che lo avevano curato, e ad altre pietose
persone, che riuscì ad esser collocato in un O-
spizio di ciechi.
Egli voleva ad ogni costo rendersi utile e vi
riuscì.
In poco tempo imparò a leggere l’alfabeto per
i ciechi, il quale è fatto con caratteri a rilievo, che
essi toccano, giovandosi del tatto per decifrarli.
Il direttore, accortosi delle sue buone disposi-
zioni per la musica, lo mise a imparare il vio-
Pagina 123
lino. Egli fece rapidi progressi; tanto rapidi che
dopo tre anni di studio incessante, fu giudicato
capace di far da maestro ad altri infelici come lui.
Che bel giorno fu quello per Michelino !
Tutto quello che guadagnava, lo dava al suo
babbo, dicendogli :
–Non potrò mai rifarti del danno che ti ho recato.
Michelino è sempre nell’Ospizio. Egli è ora un
valente professore e il pensiero di poter sosten-
tare la sua famiglia, lo compensa della perdita
della vista.
Allorchè sua madre va a vederlo, e lo com-
piange, egli risponde :
– Quando Iddio chiude una finestra, apre una
porta. Anche a me ne ha aperta una dalla quale
mi viene tanta consolazione–e accenna al violino
che dà il pane ai suoi ed a lui il conforto.
DOMANDE–Perchè il falegname diceva a Michelino di
badare al petrolio ? Che cosa può accadere avvicinando
il petrolio al fuoco? Con qual mezzo Michelino imparò a
leggere essendo cieco? Perchè diceva alla madre che quando
Iddio chiude una finestra, apre una porta?
Le conseguenze di una imprudenza si possono
risentire per tutta la vita. Per questo non bisogna
mai disprezzare gli avvertimenti che ci dànno i
genitori. Essi ne sanno più di noi e parlano sem-
pre per il nostro bene.
I sensi
– CREDETE che gli occhi servano soltanto di
ornamento al viso ? – domandò la maestra.
Pagina 124
– No, davvero: gli occhi servono per vedere
gli oggetti.
– Bene; ora vi dirò che la facoltà del vedere
è un senso, e si chiama vista.
Noi non abbiamo un senso solo; ne abbiamo
anzi cinque.
Gli orecchi ci servono a udire, e un altro senso
è l’udito.
Se vi turaste gli orecchi, non udreste più. Ma
vi sono taluni che non hanno bisogno di turarsi
gli orecchi per non udire. Quei poveretti si chia-
mano sordi.
I vecchi, generalmente , hanno l’udito debole,
e per questo bisogna parlare loro a voce alta,
affinchè possano capire quello che si dice.
Si può divenir sordi anche in seguito a una
infermità, ed i sordi sono molto infelici.
Talvolta si nasce anche sordi.
Quei poveretti, non udendo, non possono im-
parare a parlare. Ma il sentimento della carità,
che ha spinto l’uomo a inventare il mezzo d’in-
segnare a leggere ai ciechi, gli ha pure sugge-
rito il mezzo per alleviare la sventura dei sor-
domuti.
A forza di cenni s’insegna loro a parlare con
le dita, e anche a pronunziare le parole.
Ora, dunque, noi conosciamo due sensi: la vi-
sta e l’udito.
Mi sapreste nominare un terzo senso ? – do-
mandò la maestra.
Nessuno rispose; allora ella disse:
Pagina 125
– Quando mangiate un confetto, non è vero
che vi accorgete che è dolce? Se, invece, vi met-
tete in bocca il sale sentite che è amaro. Il senso
che vi fa distinguere i diversi sapori delle cose
che vi mettete in bocca, si chiama gusto.
Un quarto senso è l’odorato.
L’odorato ci permette di sentire il gradevole odo-
re dei fiori, ma non sempre ci porta odori buoni.
Spesso, per mezzo di questo senso, ci giungono
odori sgradevoli, puzzi addirittura, che ci fanno
arricciare il naso.
Il tatto è il quinto senso.
Esso ci permette di sentire se un oggetto è
molle o duro, solido o liquido , ruvido o liscio,
caldo o freddo.
Questo senso risiede in tutta la superficie del
nostro corpo, ma è più sviluppato che altrove nei
polpastrelli della dita.
Ogni senso ha organi speciali.
Gli occhi sono gli organi della vista, gli orec-
chi dell’udito, le narici dell’odorato, la lingua del
gusto, la pelle del tatto.
I sensi hanno bisogno di cura perchè si man-
tengano fini, e ci rendano quei servigi cui li
ha destinati la natura.
DOMANDE–Dite : a che cosa servono gli occhi? Gli orec-
chi? La lingua? Il naso? Che cosa è il tatto?
Il signor Versacci
IL nome vero di quel bambino sversato, era Luigi
Pagina 126
Pini. Ma, invece, tutti i compagni lo chiamavano
il signor Versacci.
Essi facevano male, perchè non si mettono ma i
soprannomi a nessuno. Ma Luigi se lo meritava.
Egli, parlando e anche tacendo, faceva mille boc-
cacce. E, non contento di questo, passava le dita
dal naso alla bocca, il che era anche peggio.
Perchè, se le boccacce sono bratto a vedersi,
quella di mettersi le dita nel naso è una vera
sconcezza, per non dir peggio.
Il maestro lo riprendeva di continuo, i com-
pagni lo canzonavano, ma Luigi non si correg-
geva.
Il bambino era scusabile in parte. Egli non
aveva la mamma che lo educasse.
Luigi non avea mai avuto le carezze e gli
ammonimenti della mamma. La sua era morta
quando egli era piccino piccino, e il babbo, con-
tinuamente occupato, non badava a quel bam-
bino, che cresceva così poco educato.
I compagni lo sfuggivano vedendo che si met-
teva sempre le mani nel naso, e si mangiava le
unghie.
Essi sapevano che quelle cose non si fanno, e
provavano ribrezzo ad accostarsi a chi le faceva
sempre.
Luigi era di famiglia agiata e abitava una
bella casa con un giardinetto. Su quel giardino
rispondevano le finestre di un’ altra casa molto
più modesta.
Pagina 127
Luigi, un giorno, dietro le inferriate del pian-
terreno, vide seduta una bimba pallida pallida,
che guardava i fiori con occhio bramoso.
La bimba sorrise e Luigi ne colse tanti e glieli
passò attraverso l’inferriata. Un sorriso di gioia
illuminò il viso della bimba.
– Vuoi venire in giardino?
–Non mi posso muovere, sono tanto malata–
rispose la bimba.–Ho passato a letto tutto l’in-
verno e ora, che è primavera, mi portano qui a
respirare un po’ d’aria, ma non posso camminare.
Da quel giorno Luigi fece amicizia con la
piccina e per lei coglieva i fiori più belli del
giardino.
La malatina, quando ebbe preso più confidenza
con lui, gli domandava quel che faceva a scuola;
e Luigi si sfogava di quel soprannome di signor
Versacci, che gli avevano affibbiato i compagni,
e le manifestava il proposito di menar le mani
una volta per levar loro l’ùzzolo di canzonarlo.
– No, Luigi, sarebbe peggiore il rimedio del
male. Cerca di correggerti invece.
E ogni volta che Luigi faceva una boccaccia
o allungava l’indice per metterselo nel naso, la
bimba gli dava un’occhiata supplichevole.
Così, a poco a poco, lo svezzò dal far quei ver-
sacci e lo ridusse composto e pulito.
Naturalmente i compagni cessarono di canzo-
narlo, e non lo evitarono più.
Pagina 128
Peccato che la malatina non avesse potuto ve-
gliare sempre su Luigi!
Ella morì alla fine di maggio e Luigi la pian-
se amaramente.
Non potendo più darle i fiori del giardino, ne
ornava la tomba di lei, e il ricordo della sua
piccola amica non si cancellò dal suo cuore.
Sentiva di doverle tanto!
DOMANDE. – Perchè Luigi si era meritato il brutto so-
prannome di signor Versacci ? Perchè i compagni lo evi-
tavano ? Perchè la bimba disse a Luigi che non doveva
menar le mani? Con quale mezzo ella riuscì a corregger-
lo? Perchè Luigi ne pianse la morte?
Con la dolcezza si ottengono tante cose che non
si otterrebbero con la prepotenza. La dolcezza è
una chiave che apre tutti i cuori.
Maggio
Il maggio è venuto: lo sanno i bambini
Dal canto festoso dei vispi uccellini,
E vedon la selva e vedon il prato
Coperti di un ampio tappeto gemmato.
È tepida l’aria, il sole scintilla
Sui campi di grano, sull’aprica villa,
Sul piano, sul monte, sul fiume, sul mare,
E tutto c’invita, bambini, a cantare.
Schiudete, piccini, le bocche ridenti
E corra quel canto sull’ala dei venti,
E intanto le piccole mani operose
Intreccin ghirlande di gigli e di rose.
Pagina 129
È maggio e l’Italia più bella ne appare.
Dall’Alpi nevose al lido del mare,
Di verde, di fiori, di luce vestita ;
È tutta una festa, nel maggio, la vita!
La scuola
LA maestra disse a Gino Tosi, che stava di
posto accanto a Berto Carli e fra loro due face-
vano a gara nell’imparare :
– Vorrei sapere, Gino, perchè venite a scuola ?
– A scuola si viene per imparare tante cose utili.
– Solamente ?
– Anche per imparare a star buoni, ad essere
ubbidienti, docili, rispettosi e disciplinati–disse
Berto Carli.
–Non ti avevo interrogato e se tu sapessi che
cosa è disciplina, non metteresti bocca quando
la maestra non t’interroga. – Berto fece il viso
rosso e tacque. La lezione l’aveva capita.
– Che cosa hai imparato fin qui a scuola,
Gino ?
– Ho imparato a leggere, a scrivere, a far di
conto; ho imparato anche il nome di tanti og-
getti di uso comune, e che ci sono utili.
– Va bene. Tu e i tuoi compagni ne impare-
rete altri. Nomina tutti gli oggetti che sono nella
scuola.
- Nella scuola sono i banchi, il tavolino,
le seggiole, l’armadio, la lavagna, il pallottoliere,
Pagina 130
i cartelloni, una croce, il ritratto del Re e diversi
altri oggetti–disse il bambino volgendo intorno
a sè lo sguardo.
– E tu, Carli –domandò la maestra–mi sa-
presti dire di dove si entra nella scuola ?
– Nella scuola si entra dalla porta ; i fine-
stroni lasciano penetrare la luce.
– E la scuola com’è fatta ?
– La scuola è una stanza chiusa da quattro
pareti. Il soffitto la copre , sul pavimento si po-
sano i piedi.
– Di che sono fatte le pareti della scuola ?
– Le pareti sono fatte di pietre e di mat-
toni.
– Solamente ? Ma che cosa tiene uniti pietre
e mattoni ? – domandò la maestra.
– La calce – rispose un altro ; ed aggiunse :
– Le pareti sono coperte d’intonaco.
– E il soffitto della scuola, come sarà fatto ?
Tutti gli sguardi degli scolaretti si volsero in
su, ma nessuno rispose, e la maestra disse :
– Il soffitto è fatto di canne sostenute da travi
di legno, o di ferro ed è ricoperto d’intonaco co-
me le pareti.
Le stanze sono anche a vôlta ; le vôlte sono
tutte di muratura, cioè non sono sorrette nè da
travi, nè da spranghe.
Mi sapreste dire ora di che cosa è fatto il pa-
vimento di questa stanza ?
Di mattoni – risposero diversi bambini.
Pagina 131
– Ma non tutti i mattoni, avrete visto, sono
compagni ; ce ne sono di argilla comune, di ce-
mento, come si vedono in quasi tutte le case ,
e di majolica, come quelli di molte cucine, che
sono lucidi, tanto che sembrano verniciati.
Di che cosa sono fatte le porte, le imposte, i
telaj delle porte e delle finestre ?
– Di legno – rispose Berto – e si chiamano
affissi. Di legno sono fatti anche i mobili.
– Ma bene ! – Sapete come si chiama la pie-
tra sottile e scura di cui è fatta la lavagna ?
Un gran silenzio si fece nella scuola e la mae-
stra disse:
– Il nome della pietra di cui è fatta la la-
vagna è ardèsia. Sulla lavagna si scrive col gesso.
I cartelloni, appesi al muro, sono di carta di-
pinta, incollata sul cartone.
Al tavolino sta seduta la maestra; gli scolari
stanno sui banchi.
La maestra insegna; gli scolari imparano.
Ma debbono stare attenti, se vogliono imparare.
Altrimenti la maestra spreca il fiato ed essi non
profittano.
Se non istanno attenti, rimangono ignoranti;
l’ignoranza è vergognosa quando vi sono i mezzi
d’imparare.
A voi tutti questi mezzi non mancano; ve li
offre la scuola, dunque approfittatene.
DOMANDE–Perchè si va a scuola ? Quante pareti ha la
scuola ? Il soffitto è piano o a vôlta? Come si costruiscono
Pagina 132
le pareti? Di che si ricoprono? Come è fatto il pavimento?
Di che son tatti gli affissi ? Quali sono gli oggetti che
si vedono nella scuola ? Che cosa occorre fare per impa-
rare ? Quando è riprovevole l’ignoranza ?
A scuola bisogna andare sempre puliti.
La pulizia della persona ci è imposta non solo
dal riguardo che si deve agli altri, ma dalla ne-
cessità di serbarsi sani.
Il nostro corpo ha bisogno di essere lavato fre-
quentemente. Le unghie sudice non sono soltanto
una sconcezza, ma anche un pericolo per la salute.
I capelli debbono essere spazzolati e pettinati,
i denti puliti ogni mattina, gli abiti spolverati
ogni volta che si tolgono di dosso, la biancheria
cambiata più spesso che si può.
I bambini puliti e ravviati leggono un sorriso
benevolo sulle labbra delle persone che li avvici-
nano. I bambini sudici sono accolti con un atto
di ribrezzo.
Il difetto di Lina
LINA era una buona bambina, ma aveva un
brutto difetto: essa vantava sempre l’ agiatezza
della sua famiglia, le sue belle vesti, i bei doni
che riceveva dai genitori, e la sua bella casa.
Lina faceva male, perchè fra le sue compagne
di scuola ve n’erano molte, le quali non avevano
altro che vestitini semplici, e case piccine e mo-
deste.
Una delle compagne di Lina, per nome Maria,
Pagina 133
dopo essere stata un giorno a sentire la descri-
zione di tutte quelle belle cose, disse:
– Sai, Lina, io ho un buchino di casa, i mo-
bili sono vecchi e stanno ritti per miracolo; non
ho belle bambole, non ho regali da nessuno, ma
sono tanto felice e dico sempre:
« Casa mia, casa mia,
Per piccina che tu sia, tu mi sembri una badìa »
Così credo che diranno anche le mie compa-
gne, perchè tutte hanno amore per la loro casa
e ci tornano con gioia.
Non i mobili belli, nè le belle stanze ci fanno
amare la casa.
– No, davvero – dissero molte bambine.
Maria soggiunse :
– Tutte in casa troviamo la mamma, che sor-
ride, rivedendoci dopo la breve assenza ; troviamo
i fratellini, che ci fanno festa, e il babbo, che ci
domanda che cosa abbiamo fatto a scuola, e ci
dimostra in mille modi il suo affetto.
Tutto questo ci rende cara la casa più umile.
Lina chinò il capo umiliata da quella cortese
lezione, e non cercò più di sopraffare le compagne.
DOMANDE–Perchè Lina faceva male a vantare ciò che
possedeva ? Perchè la casa più umile ci deve esser cara ?
Sono forse i mobili che fanno la casa ? Come si devono
dare gli ammonimenti alle compagne ?
Chi sa contentarsi del poco che ha , è sempre
felice a questo mondo. Chi è saggio non guarda
Pagina 134
davanti a sè, cioè non guarda quelli che hanno
di più. Egli guarda dietro a sè, cioè quelli che
hanno meno, e per misero che sia , vede sempre
che v’è qualcuno anche più misero di lui.
Un’erba preziosa
DUE bambinette, Annina e Maria, andavano
al mercato portando sul capo una cesta piena di
frutta. Annina si lamentava del peso e sospirava;
Maria invece rideva e scherzava.
Annina, vedendo rider la compagna , le do-
mandò :
– Come mai sei tanto allegra ? La tua cesta
pesa quanto la mia e tu non sei più robusta di me.
– Ti dirò – rispose Maria – Io ho messo
sotto la cesta una certa erba, che mi fa sentire
appena il peso.
– Davvero ? dev’essere un’erba preziosa ! Dim-
mi come si chiama e dove si trova.
– Quest’erba–rispose Maria–cresce per tutto
dove si coltiva : essa si chiama pazienza !
DOMANDE–Dove andarono Annina e Maria? Perchè An-
nina sospirava e brontolava? Perchè Maria, invece, era al-
legra ? Come si chiama la virtù che ci aiuta a sopportare
le sventure e i disagi ?
Le tre bambine
C’ERANO una volta tre bambine, che andava-
no a scuola con i loro panierini infilati nel brac-
Pagina 135
cio , e si riparavano tutte e tre sotto lo stesso
ombrello.
– Io – diceva la più grande – voglio esser
savia e studiare. Se alla fine del mese avrò buo-
ni punti , la mamma mi regalerà un bell’ orolo-
gino d’argento.
– La mia mamma è povera – disse la se-
conda–e non mi può regalar nulla ; ma quan-
do mi son portata bene, mi bacia e mi dice che
sono la sua consolazione.
La più piccola balbettò :
–Io non avrò nè orologio, nè baci, perchè la
mamma e il babbo mi sono morti quando ero
in fasce. Sarò studiosa, senza pensare alla ricom-
pensa, soltanto perchè bisogna studiare.
Camminava lentamente dietro alle tre bambi-
ne una vecchia, e prestava orecchio ai loro di-
scorsi.
Quando l’ultima delle bimbe ebbe terminato di
parlare, la vecchia disse :
– Pare impossibile che la più piccina fra voi
tre, sia la più assennata ! Chi studia soltanto in
vista di ottenere una ricompensa, non istudierà
più quando saprà di non poterla avere.
Le due bambine maggiori abbassarono il capo
umiliate ; la piccina invece guardò in faccia
la vecchia e le sorrise come per ringraziarla.
DOMANDE–Perchè la vecchia disse che la più piccina
delle bimbe era la più assennata ? Quale è lo scopo di
chi studia ? Quale è la ricompensa che si deve sperare
dallo studio ?
Pagina 136
Ogni dovere compiuto di buona voglia ci rende
tranquilli e felici. E la felicità consiste appunto
nella soddisfazione di averlo compiuto.
Le case
GLI uomini costruiscono le case per vivervi
riparati dal vento , dal freddo , dalla pioggia e
dal sole.
Le case sono costruite dai muratori con pietre,
calce, rena e mattoni.
Le case hanno fondamenta nella terra. Queste
sorreggono i muri. Sui muri si appoggia il tetto
che ha un’armatura di legno o di ferro, ed è co-
perto di tegoli ed embrici.
Le case sono divise in stanze. Nelle case si
entra dalle porte ; la luce vi penetra dalle
finestre.
È un grande sventurato chi non ha casa ove
ripararsi.
Di fatto, per indicare un uomo misero, si dice
che non ha casa nè tetto.
Alcuni poveri contadini o pastori abitano pic-
cole capanne di strame e legname. Essi sono de-
gni di compassione perchè nelle campagne in-
salubri contraggono tante malattie.
I popoli dei paesi freddissimi , dove la terra
scomparisce sotto il ghiaccio , per soffrire meno
scavano buche sotto terra e nella neve.
Tutti gli uomini, nei tempi antichi, vivevano
Pagina 137
nelle grotte o in certe capanne sorrette da pali
piantati nell’acqua.
Le belle case , ampie , ben costruite e ornate,
si chiamano palazzi.
Quelle comode, pulite, ma più modeste, si chia-
mano case.
Le case piccole, anguste, meschine , si dicono
casupole o catapecchie.
Le case situate in campagna e circondate da
giardini si dicono ville.
Per salire nelle case vi sono le scale formate
da scalini.
Il ripiano delle scale si chiama pianerottolo.
Le scale sono a branche o a chiocciola.
Quelle che stanno davanti alle chiese si chia-
mano gradinate.
DOMANDE–Come sono divise le case ? Da che cosa sono
coperte ? Quali sono i palazzi ? Quali le ville ? Con che
mezzo si sale nelle case ?
La casa imbandierata
I muratori avevano terminato di coprire il tetto,
e il padrone , dopo aver fatto issar le bandiere
tricolori sulla casa, li aveva invitati a mangiare
i maccheroni. A pranzo però c’erano altre pie-
tanze, oltre i maccheroni, perchè il padrone ave-
va voluto che quei lavoranti, i quali avevano speso
le loro fatiche nel costruire la sua casa , godes-
sero di un giorno di festa.
Pagina 138
In capo tavola , alla sua destra , il padrone
aveva fatto sedere un bel vecchio robusto , che
ancora si arrampicava sui palchi e lavorava dalla
mattina alla sera.
Tutti parlavano di fabbriche, nelle quali ave-
vano lavorato; di pericoli corsi, di difficoltà sor-
montate.
– Anch’io ho avuto i giorni belli come que-
sto, ma anche i giorni brutti – disse il vecchio.
Ero giovine e lavoravo a edificare un palazzo.
Con me lavorava pure il mio figliolo Gianni,
che faceva il manovale , e andava sempre su e
giù a portar calcina e materiali.
Un giorno, io ero a terreno che spianavo i pavi-
menti, quando sento un rovinìo, che fece tremare
la casa dalle fondamenta.
Non mi rimase un briciolo di fiato, e le gam-
be non mi volevano portare. Certo era rovinato
qualcosa e Gianni era su.
Stavo sempre lì, fermo, rimbecillito, senza po-
termi muovere, quando vidi il mio figliolo tutto
sanguinante , portato a braccia da compagni.
Sentii dire che una volticella s’ era sfondata , e
Gianni era caduto di sotto.
Vederlo, prenderlo fra le braccia e portarlo a
medicare nella prima farmacia che trovai , fu
tutt’una.
Gianni s’ era fatto poco o nulla. Qualche scor-
ticatura alle mani e molte contusioni, ma io l’a-
vevo creduto morto e quel che patii lo so io solo.
/ BEGIN PAGE [139] /
…vidi il mio figliolo tutto sanguinante, portato... pag. 138
Pagina 140
– Fortuna che andò così – osservò un altro
muratore. – Ma quanti compagni non ho veduto
morire sotto le macerie !
– Che ci volete fare ? –rispose il vecchio –
Il nostro è un mestiere pericoloso , ma anche
tanti altri mestieri espongono alla morte chi li
esercita. Bisogna vivere onestamente come se si
dovesse comparire da un momento all’altro da-
vanti a Dio. Questo è il mezzo per non aver
paura.
– E quello per esser felici qual’è ? – doman-
dò un giovane.
– Quello di contentarsi della propria sorte, di
guardare chi sta peggio di noi, e di ringraziare
Iddio del bene che ci dà.
– Parlate d’oro – disse il padrone commosso,
stringendo la mano al vecchio. – Siete una perla
d’uomo e d’operaio.
E tutti fecero coro al padrone , perchè tutti
rispettavano e amavano il vecchio.
DOMANDE–Che festa si suol fare quando si copre una
nuova casa? Come si chiamano gli operai che costruisco-
no le case ? Come si chiamano quelli che portano calce e
materiali ? Quale è il mezzo per non temere la morte ?
Quale è il segreto per essere felici ?
Lavorare è dovere.
Chi non lavora non ha diritto di mangiare, e
chi mangia senza aver lavorato è come se man-
giasse roba rubata.
Pagina 141
La gente che lavora è benedetta da Dio e ama-
ta da tutti; a quella che non lavora incoglie male,
perchè non ha seco la benedizione del Signore ,
nè la stima degli uomini onesti.
Il lavoro è ricchezza. Chi lavora non è mai
povero, perchè si guadagna il pane quotidiano ,
e anche nei momenti di scarsi lavori, é più fa-
cile che l’uomo laborioso non rimanga a spasso,
e raccapezzi la sua giornata.
I mestieri
- IN questa stanza ci sono mobili usuali di le-
gname comune ; sapreste dirmi, bambini , come
si chiama l’operaio che fa questi mobili ? – do-
mandò la maestra.
Baldo Sironi, che era figliuolo d’un falegname,
rispose pronto:
- Chi fa questi mobili usuali si chiama fale-
gname. Il falegname fa pure le finestre , le per-
siane e le porte.
- Bene: dunque il falegname fa mobili usuali
e affissi; ma l’operaio che fa mobili più fini, com-
posti di legni più rari, come si chiama ?
- Stipettaio – rispose Baldo. – Esso fa stipi,
credenze, cassettoni, comodini e mensole.
- E come si chiama chi fa gli utensili di ra-
me per cucina , come caldaie, cazzeruole, bric-
chi e teglie ?
Nessuno lo sapeva e la maestra disse :
Pagina 142
– Chi fa gli utensili di rame da cucina si
chiama ramaio; chi fabbrica serrature per le
porte e paletti, si chiama fabbro. Il bottaio fa le
botti ove si ripone il vino; lo stagnaio i condotti
per l’acqua e per il gaz illuminante, e le gron-
daie dei tetti.
Chi impasta i mattoni si dice mattonaio ; chi
li cuoce fornaciaio. Chi costruisce carrozze è
carrozzaio; chi fa selle per cavalli sellaio. Il
fornaio fa il pane; il tessitore tesse la lana , il
cotone, il lino e la seta; il materassaio fa le ma-
terasse sulle quali dormiamo. Il tappezziere im-
bottisce i mobili e li riveste di stoffa. Il vetraio
mette i vetri alle finestre; l’imbianchino imbian-
ca le stanze; la lavandaia lava i panni sudici ,
la sarta cuce i vestiti da donna, il sarto quelli
da uomo; il calzolaio fa le scarpe ; il cappellaio
i cappelli.
Oltre questi vi sono molti altri mestieri , che
sono indispensabili alla vita.
DOMANDE–Come si chiama chi fa i mobili usuali ? Co-
me si chiama chi fa i mobili di lusso ? E chi fa gli uten-
sili di cucina ? E chi fa i vestiti ? I mestieri sono utili
all’uomo ?
Tutti abbiamo bisogno delle persone che eserci-
tano i diversi mestieri.
E noi non solo dobbiamo puntualmente pagarle
per le loro fatiche, ma anche rispettarle , perchè
chi lavora, chi s’industria, ha diritto di essere
rispettato e trattato bene.
Pagina 143
Non mi sta bene
LA signora Berni aveva tre figlie. Due di esse
erano buone , ragionevoli e studiose ; la minore,
Sofia , era prepotente, irragionevole e sgarbata.
Per quanto la mamma la correggesse sempre ,
Sofia non voleva emendarsi di quei tre brutti di-
fetti, che le rendevano la vita amara, perchè non
c’era giorno che non le procurassero qualche sgri-
data.
A Pasqua la signora Berni regalò un vestito
a ciascuna delle sue figliole, e chiamò una sarta
per farglieli fare.
Il giorno in cui la sarta riportò i tre vestitini,
la signora Berni non era in casa. Le due mag-
giori se li provarono, e trovandovi qualche di-
fetto, pregarono la sarta di correggerlo.
Quando fu il turno di Sofia, questa andò da-
vanti allo specchio, e, vedendo che il vestito non
le stava come voleva, incominciò a brontolare
con la sarta e a dirle che se non conosceva il
mestiere, doveva andarlo a imparare.
– Ma il vestito si può correggere – diceva la
sarta pacatamente. – Non ha altro difetto che
quello di esser largo di vita.
– Non mi sta bene – gridava Sofia indispet-
tita più che mai e , toltosi il vestito , lo buttò
come un cencio per terra.
La sarta aveva le lagrime agli occhi.
In quel momento entrò la mamma, e vedendo
Pagina 144
il vestito in terra e Sofia sulle furie, capì che
questa ne aveva fatta una delle sue.
Con buone parole, cercò di consolare la sarta,
e condotta Sofia in un’altra stanza le disse :
– Non puoi capire quanto sei stata cattiva
trattando male quella donna. Ella è di buona
famiglia, e, trovandosi in miseria per la morte
del marito, si è messa a far la sarta. Io avevo
voluto aiutarla dandole del lavoro, e tu, con la
tua prepotenza, converti in tanto dolore per lei,
il sollievo che volevo recarle.
Sofia sentiva tutta la sua colpa, ora che la
collera era svanita, e si vergognava.
Quando poco dopo, la sarta traversava l’anti-
camera per andarsene, Sofia la raggiunse dicen-
dole con gli occhi bassi e la voce tremante :
– Mi compatisca, sono stata prepotente, irra-
gionevole e sgarbata.
– Oh ! signorina...–rispose la sarta, e nuove
lagrime le sgorgarono dagli occhi. – Se sapesse
quanto è duro il sentirsi trattar male !
Non disse altro, ma Sofia si guardò bene, in
avvenire, di cedere alla collera e usò sempre modi
cortesi con tutti e specialmente con la gente di
umile condizione.
DOMANDE : Quali erano i tre brutti difetti di Sofia ?
Era felice Sofia ? Perchè ? Come si deve trattare chi la-
vora ? Perchè la gente di umile condizione merita speciali
riguardi ?
Pagina 145
Gli animali
- NON solo gli uomini, cioè i nostri simili, ci
sono di aiuto e di giovamento, perchè provvedono
ai bisogni della nostra vita,–disse la maestra–
ma anche molti animali ci sono utili.
Gli animali soffrono anch’essi se sono trattati
male, e per questo è obbligo nostro di non farli
patire in nessun modo.
Gli animali sono creature di Dio come noi.
– Chi di voi – aggiunse la maestra–non ha
sulla coscienza qualche maltrattamento fatto a
un cane, a un gatto, o a qualche altro animale?
Tutti tacquero ; ma il Segni ed il Carli ar-
rossirono ; e ne avevan di che. Il giorno prima
la maestra li aveva sorpresi nel cortile della scuola,
mentre tiravano sassate a un gattuccio della
custode.
Ora faceva loro intendere che biasimava la loro
condotta.
–Gli animali–continuò la maestra dopo quella
utile digressione–sono compagni dell’uomo.
Tutti voi conoscete i cani, i gatti , i cavalli ,
i buoi, gli asini, le pecore, le capre, i topi, i
polli, le anitre, i pesci, le farfalle, le formiche,
le mosche, le api e i passerotti che cinguettano
sui tetti. Forse conoscete pure le bisce, le lucer-
tole e le rane.
Ma gli animali che conoscete non sono che i
meno. Invece sulla terra ce n’è tanti tanti.
Pagina 146
Sui cartelloni di scuola avete veduto rappre-
sentati elefanti, leoni, tigri e giraffe; ma avete
mai veduto quegli animali nei nostri paesi?
– Nossignora.
– E perchè ? Perchè ogni parte del mondo ,
come ha piante speciali, ha pure animali speciali.
Gli animali sono molto diversi fra loro. Vi
pare che un bove somigli ad un’ anitra ; un
cefalo ad una lucertola ; una chiocciola ad una
mosca?
I bambini risero sentendo fare quei confronti,
e la maestra continuò:
– Alcuni animali vivono sulla terra, altri nel-
l’aria e altri nell’acqua.
I bovi, i cani, i cavalli sono quadrupedi, per-
chè hanno quattro piedi per camminare.
I passerotti, le anitre, i polli sono volatili , e
per volare hanno…
– Le ali.
– I cefali, le triglie, le sardine, sono pesci; e
che cos’hanno i pesci per nuotare ?
Nessuno fiatò , e la maestra suggerì :
– I pesci hanno le pinne e con quelle nuotano.
Le farfalle, le formiche e le mosche sono in-
setti. Alcuni insetti volano ed altri no.
Le bisce e le lucertole sono rettili, e strisciano
sulla terra.
Le conoscete le lucertole ?
– Sì, altro ! Vanno a scaldarsi al sole , ma
scappano appena vedono gente.
Pagina 147
– Scappan perchè hanno paura dei ragazzacci,
che le molestano. Se nessuno le avesse mai tor-
mentate, le lucertoline non sarebbero tanto pau-
rose. Bisogna guardarle e lasciarle stare.
DOMANDE–Perchè non si debbono maltrattare gli ani-
mali ? Nominate quelli che conoscete. Quali sono i quadru-
pedi? Perchè si chiamano così? Quali i volatili ? Che cosa
hanno per volare ? Quali i pesci ? Di che sono forniti per
nuotare ? Nominate alcuni insetti. Nominate alcuni rettili.
Il ragno canzonava il baco da seta:
– Dio mio, gli diceva, come sei lento nel tuo
lavoro. Guarda come sono lesto io! Dal dire al
fare t’improvviso una bella tela.
- È vero – rispose il baco – ma a che serve,
dimmi, la tua tela? A imbrattare i muri ed a ten-
dere agguati. Il mio lavoro, almeno, è utile. La-
voro poco, ma lavoro bene.
Tutti lavorano
AL podere di Pietro Balena , sui bei colli
toscani, tutti lavoravano. Lavorava il vecchio
capoccia, che aveva sulle spalle settant’anni so-
nati e non c’era giorno di sole o di pioggia che
non andasse nel campo ; lavorava la Menica ,
la massaia, cucinando per tutti, tenendo in or-
dine la casa, facendo il pane e il bucato. Lavo-
ravano anche i figli di Pietro, dalla mattina alla
Pagina 148
sera, e lavoravan le nuore andando a far l’erba
per le bestie della stalla, governando i polli e aiu-
tando ora a vendemmiare, ora a strappare le er-
bacce, ora a cogliere le frutta e gli erbaggi, che
gli uomini portavano al mercato.
I bovi poi, non se ne parla, chè la terra era
dura, e a tirar l’aratro sulle piagge ci voleva fa-
tica.
Tonio solo, il figlio minore del capoccia, non
intendeva di lavorare. Quando il babbo o i fra-
telli voltavan l’occhio, egli scappava subito a fare
il chiasso con i compagni dei poderi vicini, e se
gli affidavano i maiali per condurli a pascere nel
querceto, li piantava lì, e se n’andava.
Pietro il capoccia, sarebbe stato severo col fi-
gliuolo, ma c’era la mamma, che gli copriva tutte
le bricconate; e cosi Pietro, di dieci, ne sapeva
una, a dir molto.
Il proverbio dice: Il medico pietoso fa la pia-
ga puzzolente. La Menica, di fatto, con la sua in-
dulgenza, avvezzava Tonio per la forca.
Un giorno peró, che Tonio, invece di lavorare,
s’era, al solito, imbrancato con i compagni, pro-
pose loro di andare nella bandita di caccia di
Melete, dove c’erano i fagiani a bizzeffe.
Vedendo che quei bellissimi uccelli non fug-
givano dai rami su cui erano posati, i monelli
presero alcuni sassi e cominciarono a tirarli con-
tro i fagiani. Uno cadde morto e la sassaiola con-
tinuava.
/ BEGIN PAGE [149] /

era stato preso per il bavero dalla guardia,... pag. 150
Pagina 150
Da un ciuffo d’alberi sbucò fuori a un tratto,
una guardia della bandita, col fucile. I monelli
fuggirono tutti, meno Tonio, che era stato preso
per il bavero dalla guardia , e non si poteva
muovere.
La guardia lo consegnò ai carabinieri, e in
mezzo a loro Tonio ebbe lo scorno di traversare
il paese, e di comparire davanti al babbo.
Da quel giorno, nessuno lo perdette più un
momento di vista, e tutti i lavori più faticosi
toccavano a Tonio.
Ma anche se non fosse stato sorvegliato, Tonio
non avrebbe più fatto il vagabondo come prima.
Egli aveva capito a sue spese che : niente fa-
cendo s’impara a far male.
DOMANDE – Mancavano i buoni esempj a Tonio? Perchè
si ostinava a fare il vagabondo ? Che cosa avviene a chi
sta in ozio? Come dice il proverbio?
Una cicala che avea cantato tutta l’estate, al
sopraggiungere del freddo si trovò sprovvista di
tutto e andò a chiedere soccorso alla formica.
– Che cosa facevi durante la buona stagione?
–le domandò l’operoso insetto.
– Cantavo per rallegrare il passeggiere.
– Ebbene, ora balla! –le rispose la formica.
Voci degli animali
Sui tetti il gatto miagola,
Sull’uscio abbaia il cane ;
Pagina 151
Gracchian ne’ fossi l’anitre,
E gracidan le rane.
Mugghian le vacche, belano
Nel prato gli agnellini;
E le galline chiocciano
Chiamando i lor pulcini.
Presso alla stalla l’asino
Raglia; il caval nitrisce;
Tafani e mosche ronzano,
Ed il maial grugnisce.
I passerin garriscono;
La tortorella geme,
E le colombe placide
Tuban dall’alto insieme.
Ma il buon fanciul non biascica,
Neppur cinguetta, o grida;
Lascia alle scimmie il merito
Di far versacci e strida.
Malfatti.
I minerali
– ORMAI, bambini, voi conoscete gli animali
ed i vegetali, e non potreste scambiare un albero
con un bove.
Tutti si misero a ridere a quella osservazione
della maestra.
- Animali e vegetali vivono, cioè nascono,
crescono, si nutriscono e muoiono.
Pagina 152
Sulla terra, però, vi sono altri corpi che non
nascono, non crescono, non si nutriscono e non
muoiono, e questi corpi sono i minerali. Una
manciata di terra, un pezzo di ferro, una pietra
sono minerali.
Senza le pietre e i marmi come si potrebbero
fabbricare le case solide e belle ? Senza la terra
come potrebbero vegetare le piante ? Senza il
ferro, il rame, il piombo, lo stagno, l’oro, l’ar-
gento come si potrebbero fabbricare navi, uten-
sili, macchino e monete ?
Vedete dunque di quanta utilità sono i mi-
nerali!
Essi si trovano alla superficie del suolo, nel
seno della terra, e sulle montagne.
Le pietre, i marmi e le diverse terre si estrag-
gono dalle cave. I metalli quasi sempre si tro-
vano in filoni o vene nell’ interno delle rocce, e
quei luoghi si chiamano miniere. I cavatori ca-
vano le pietre; i minatori i metalli.
La ghiaia, la rena, la sabbia, sono rocce stri-
tolate; anche la terra è roccia sminuzzata.
Il sale, di cui facciamo tanto uso, è un mine-
rale. Il carbon fòssile, che alimenta le macchine,
è anche un minerale.
Se gli animali e i vegetali ci sono utili, anche
i minerali, bambini, non sono da disprezzarsi.
Essi ci offrono il materiale per fabbricare le case,
per costruire le macchine, e tanti utensili indi-
spensabili alla nostra vita. Vedete come Iddio ha
Pagina 153
pensato a noi; ringraziatelo sempre per la sua
immensa bontà.
DOMANDE – Come si distingue un minerale da un ani-
male e da un vegetale ? Quali sono i minerali ? Quali sono
i metalli ? Da dove si cavano i minerali ? Da dove i me-
talli ?
Iddio, come un buon padre, ha provveduto a
tutti i bisogni delle sue creature. Noi abbiamo il
dovere di affaticarci per utilizzare tutti i tesori
che Iddio ha sparsi sulla Terra.
Gli amici del contadino
VICINO alla casa di un contadino c’ era un
prato nel quale spesso pascolavano insieme un
cavallo, una vacca e una pecora.
Ma il cavallo era troppo superbo per avvici-
narsi alla vacca o alla pecora, e diceva :
– Non ispetta forse a me l’ onore di portare
in groppa il padrone ? E non sono io pure che
trascino il calesse con la padrona e i bambini ?
Per questo teneva la testa alta ed evitava di
mescolarsi con i suoi compagni.
La vacca pure era troppo superba per pascere
insieme con la pecora, e diceva:
– Non sono io forse che fornisco al mio pa-
drone il latte per bere e col quale fa il burro e
il formaggio ?
Pagina 154
La pecora non si poteva persuadere che i
suoi compagni tenessero la testa così alta, e di-
ceva :
– Non fornisco io pure il latte col quale i pa-
droni fanno la ricotta e il cacio ? E inoltre non
procuro loro la lana per riempire le materasse e
i guanciali , per farsi vestiti , coperte ed altre
cose ? Non so come farebbero, durante l’inverno,
se non avessero la mia lana. I padroni potreb-
bero fare a meno del cavallo e della vacca, ma
non di me.
– Chicchiricchì – gridava il gallo sull’aia –
come sono utile agli abitanti della casa ! Li de-
sto all’alba col mio grido.
– Coccodè ! coccodè – faceva la gallina cam-
minando in mezzo ai pulcini, – Coccodè ! io sono
più utile di te , gallo. Io faccio l’uovo tutti i
giorni e con le mie uova , la padrona prepara
tante buone pietanze per i suoi bambini.
– Gnau ! gnau ! – gridava il gatto correndo
per la casa. – Se non ci fossi io, i topi mange-
rebbero tutto il grano nel granaio, e finirebbero
il cacio.
– Bau ! bau ! – faceva il cane mettendo la te-
sta fuori del canile. – E io non faccio forse più
di tutti? non veglio sulla casa e ne tengo lon-
tani i ladri che verrebbero a rubare la roba al
padrone ? Senza di me come farebbe ?
Appunto in quel momento, il contadino tor-
nava dal prato , dove era stato a vedere il ca-
Pagina 155
vallo, la vacca e la pecora. Egli dette una man-
ciata di becchine ai polli , mise un po’ di latte
nella scodella del micio, e poi gettò un osso al
cane dimostrando a tutti che pensava a loro,
perchè ognuno di essi lo serviva come poteva,
ed eragli utile.
DOMANDE – Di quale utilità ci è il cavallo ? Che cosa
ci fornisce la vacca? Che cosa ci dà la pecora? La gallina
che cosa produce? Dite che cosa fanno il gatto e il cane.
Perchè il padrone trattava i suoi animali egualmente ?
L’ultimo giorno di scuola
BERTO CARLI era tutto gongolante l’ultimo
giorno di scuola, mentre c’era un altro scola-
retto col viso abbattuto, che non osava alzar gli
occhi sulla maestra.
Quel bambino afflitto era Ciro Galli.
Ciro aveva fatto come certi cavalli che non
vincono mai le corse. Sul principio dell’anno sco-
lastico aveva tenuto testa ai migliori della classe;
a un tratto s’era lasciato vincere dalla svoglia-
tezza, e ora pativa tanto, ma tanto ! Che bella
figura avrebbe fatta con la maestra , con i ge-
nitori e con quei compagni, ai quali aveva la-
sciato libero il terreno ! Come si mordeva le
mani ! Se fosse potuto tornare addietro !
Berto fissò Ciro e si accorse dal viso di lui che
qualcosa lo turbava: il resto lo indovinò.
Pagina 156
In un battibaleno , gli venne in mente una
idea e avrebbe voluto manifestarla lì per lì a Ci-
ro; ma la maestra era in cattedra e dovette aspet-
tare, e aspettare un pezzo, perchè la maestra fa-
ceva un discorsetto d’addio ai suoi scolaretti per
esortarli a non buttar da parte i libri durante
le vacanze.
Quando ella ebbe terminato, Berto fu tra i primi
ad alzarsi e, preso per un braccio Ciro, lo con-
dusse nel cortile.
– Lasciami stare – disse Ciro , di cattivo u-
more.
– Senti – rispose Berto , senza lasciarsi inti-
midire da quell’ accoglienza. – Io so perchè tu
sei così accigliato, ma non ti disperare; a tutto
c’è rimedio. Domani e doman l’altro è festa, gli
esami cominciano soltanto martedì. Vuoi che og-
gi, subito , incominciamo a rileggere insieme
tutto quello che la maestra ci ha spiegato ? Farà
bene a tutt’e due.
– Tu passerai di certo all’esame; non hai bi-
sogno di far questa fatica.
– E se volessi farla per te ? – disse Berto
Ciro non rispose, ma buttò le braccia al collo
di Berto, e gli disse:
– Come sei buono !
La sera tutti e due i bimbi erano curvi sui
libri , e Berto frugava nella memoria per ricor-
darsi le spiegazioni della maestra , e si aiutava
con i quaderni mettendo tutto l’impegno possi-
Pagina 157
bile a far capire al compagno ciò che egli sa-
peva.
– Ma è tardi , smettete – diceva la signora
Carli.
– Lasciami fare, mamma; per noi il tempo è
moneta–rispondeva Berto.
A vederlo così applicato, così affaccendato, pa-
reva che il timore di non passare all’esame gli
servisse di stimolo. Invece era la passione per
il compagno.
Così continuarono i bambini per due giorni.
Berto fu interrogato il primo ed ebbe dieci in
tutto, con lode.
Poi venne il turno di Ciro.
Berto tremava più di lui vedendolo esitare tal-
volta a rispondere; gli avrebbe voluto suggerire
le risposte... come fare... ?
Ma anche Ciro fu promosso e appena fuori
della sala degli esami , si gettò al collo dell’a-
mico piangendo:
– Mi hai salvato ! – gli disse.
– Ti ho dato una spinta e nulla più. Ora che
abbiamo preso a volerci bene studiando insieme,
continueremo a stare insieme nelle vacanze.
– Non domando di meglio.
Quell’esame fu il principio di una salda ami-
cizia fra i due bambini, la quale non si rallentò
mai con gli anni.
DOMANDE – Perchè Ciro era afflitto l’ ultimo giorno
della scuola ? Quale proposta gli fece Berto ? Quale fu il
Pagina 158
risultato della proposta di Berto ? Quale sentimento legò
i due bambini ?
L’amicizia è un sentimento gentile, che va col-
tivato con cura, come un fiore delicato. L’amici-
zia si fonda sulla fiducia, e se questa manca, l’a-
micizia vien meno. Un amico ha diritto di con-
tare sul nostro aiuto, come noi contiamo sul suo,
e per l’amico ci si deve sacrificare volontaria-
mente. I tristi, i cattivi e gli egoisti non hanno
amici. I buoni ne hanno molti, e traggon sempre
conforto dall’appoggio di quelli.
(Segue Cuoricini d’Oro. Libro di lettura per la terza classe)
/ BEGIN PAGE [159] /
INDICE
Esercizi di ricapitolazione … Pag. 5
Emilia e Gino … “ 10
I capricci di Gino … “ 11
Gino riflette … “ 12
Il ritorno a scuola … “ 13
Amore verso i Maestri … “ 14
Amore verso i compagni … “ 15
La disgrazia di Bianca … “ 16
La cucina e i suoi arredi … “ 17
La lezione continua … “ 19
Buone amiche … “ 20
In casa di Bianca … “ 21
La visita a Bianca … “ 23
All’ospedale … “ 24
La mamma mia (poesia) … “ 26
In giardino … “ 27
La vendemmia … “ 28
La festa della Maestra … “ 31
Una gioia meritata … “ 32
Le cose pericolose … “ 34
I consigli della maestra … “ 35
Il vaso rotto … “ 36
La moneta trovata … “ 38
All’Ufficio municipale … “ 40
Le monete … “ 42
A che cosa servono le monete … “ 44
La carità … “ 45
La preghiera interrotta … “ 48
Dio è presente ovunque (poesia) … “ 51
Dal chicco al granaio … “ 51
Dal granaio al forno … “ 53
L’abbondanza (poesia) … “ 55
I pettirossi … “ 56
La canzonetta delle stagioni (poesia) … “ 58
Pagina 160
Gli alberi Pag. 59
Il legname … “ 61
Al giardino pubblico … “ 62
La pianta d’amorino … “ 66
I vegetali … “ 67
Le piante tessili … “ 69
L’albero di Natale … “ 70
Gli augurj di Natale (poesia) … “ 73
Le paure di Sandrino … “ 73
L’orto della zia Balbina … “ 76
Un arrivo inatteso … “ 77
Come Rita e Gabriele passarono il capo d’anno … “ 79
Nel regno della zia Balbina … “ 81
Nel pollaio della zia Balbina … “ 83
Nella stalla della zia Balbina … “ 85
Per capo d’anno (alla mamma) (poesia) … “ 88
La divisione dell’anno … “ 89
Tempo e stagioni … “ 91
Chi ha tempo non aspetti tempo … “ 93
Il 9 Gennaio … “ 95
Il cuore di Vittorio Emanuele II … “ 97
La patria … “ 100
L’Italia … “ 102
La bandiera d’Italia … “ 103
Italia (poesia) … “ 106
I colori … “ 106
Un giorno di neve … “ 108
Il corpo umano … “ 111
L’arrivo del Re … “ 113
La bontà del Re Umberto … “ 114
A S. M. la Regina d’Italia (poesia) … “ 116
La luce … “ 117
La luce artificiale … “ 119
Il cieco … “ 121
I sensi … “ 123
Il signor Versacci … “ 125
Maggio (poesia) … “ 128
La scuola … “ 128
Il difetto di Lina … “ 132
Un’erba preziosa … “ 134
Le tre bambine … “ 134
Le case … “ 136
La casa imbandierata … “ 137
I mestieri … “ 141
Non mi sta bene … “ 143
Gli animali … “ 145
Tutti lavorano … “ 147
Voci degli animali (poesia) … “ 150
I minerali … “ 151
Gli amici del contadino … “ 153
L’ultimo giorno di scuola … “ 155