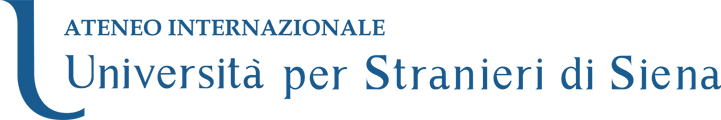Quando l'inglese parlava italiano: breve storia dell'insegnamento dell'italiano in Inghilterra - Emma Daria Perlo
Quando l'inglese parlava italiano: breve storia dell'insegnamento dell'italiano in Inghilterra
di Emma Daria Perlo
Introduzione
L'italiano è ancora oggi una lingua che registra numeri significativi come lingua straniera: sono infatti circa 2,06 milioni le persone che lo studiano in 113 Paesi diversi (MAECI, 2021). Tuttavia la diffusione internazionale dell’italiano non è un fenomeno recente: affonda le sue radici nei secoli passati, quando la lingua e la cultura italiane suscitarono grande curiosità e prestigio oltre i confini della penisola. In particolare, l’Inghilterra fu tra i primi Paesi europei a sviluppare un interesse stabile per la nostra lingua.
I primi contatti e l'epoca elisabettiana
I primi contatti documentati tra Italia e Inghilterra sono testimoniati dalle relazioni di ambasciatori veneziani: la prima traccia di relazioni diplomatiche e di invio di rappresentanze estere in Inghilterra da parte della Repubblica di Venezia risale al 1370, in una lettera che il re inglese Edoardo III inviò al doge Andrea Contarini (Wyatt, 2005). Nei secoli successivi diversi personaggi italiani di rilievo visitarono l'Inghilterra e riportarono le loro impressioni. Tra questi citiamo l'umanista fiorentino Poggio Bracciolini, il futuro papa Pio II (Enea Silvio Piccolomini) e Baldassarre Castiglione.
Fig. 1 Pinturicchio, Enea Piccolomini (Pio II) ambasciatore in Scozia con James I
Nel Cinquecento iniziarono a circolare anche all'estero, e in Inghilterra, le prime grammatiche per stranieri (ad esempio The Principal Rules of Italian Grammar di William Thomas). La conoscenza dell'italiano acquistò importanza per almeno due motivi: in primo luogo il prestigio culturale e letterario di opere scritte in volgare, come la Commedia, e degli autori Petrarca, Boccaccio e Machiavelli; in secondo luogo la necessità di comunicare con le rappresentanze italiane presenti in Inghilterra per ragioni commerciali e professionali. All'epoca l'inglese non era ancora una lingua franca diffusa in tutto il continente, e non era scontato che uno straniero che venisse oltremanica la conoscesse.
Nel Cinquecento l'insegnamento delle lingue moderne (italiano, francese, spagnolo) non era ancora diffuso nelle scuole: prevalevano latino e greco. Questo generò una domanda di insegnanti privati, compresi maestri d'italiano. A Londra vivevano molti italiani, spesso esuli fuggiti dalle persecuzioni religiose, e molti aprirono scuole private dove si insegnavano anche le lingue moderne (Yates, 1937).
Dal punto di vista dell'insegnamento dell'italiano, però, la figura del docente privato, il tutor, è la più rilevante. Durante l'epoca elisabettiana lo studio dell'italiano tra nobili e gentry divenne quasi d'obbligo: la regina stessa lo parlava fluentemente, grazie agli insegnamenti di Giovan Battista Castiglione. Alcuni maestri riuscirono a ottenere stabilità economica e una certa celebrità: Michelangelo Florio insegnò a Lady Jane Grey e forse anche alla giovane Elisabetta; Gianbattista Castelvetro lavorò alla corte di Giacomo I; Claudius Hollyband pubblicò manuali per l'apprendimento dell'italiano (The Italian Schoolemaister, 1597; Campo di Fior, 1583). (Pizzoli, 2004).
Fig. 2 William Hole, ritratto di John Florio, 1611
La figura più importante di questo periodo è però certamente John Florio, figlio del già citato Michelangelo. A venticinque anni pubblicò il suo primo libro, First Fruits (1578), ispirato alle Hore di ricreatione di Lodovico Guicciardini e al Libro aureo di Antonio De Guevara. Il manuale è una raccolta di dialoghi di difficoltà crescente, organizzati su due colonne per offrire la versione in inglese e quella in italiano. Sia First Fruits sia Second Fruits (1591) offrono una panoramica della vita inglese dell'epoca: più che spiegazioni grammaticali sono raccolte di vocaboli, proverbi e modi di dire. Nel 1598 Florio pubblicò il suo dizionario italiano-inglese, poi rivisto nel 1611 con il titolo A World of Words. Il dizionario rimase uno standard per tutto il Seicento e influenzò le opere successive (Yates, 1934).
Il Grand Tour e la stagione lirica
Nel secolo successivo l'eredità di Florio fu raccolta da Giovanni Torriano, maestro e autore giunto in Inghilterra intorno al 1620. Torriano non era solo un insegnante d'italiano: è considerato anche tra i primi maestri a insegnare l'inglese in Italia (Rossi, 1991). Egli intrattenne rapporti con la corte inglese e si ispirò ai lavori di Florio, proseguendone la tradizione: nel 1666 pubblicò una raccolta di proverbi (Piazza universale di proverbi italiani) che amplia opere analoghe di epoche precedenti. Inoltre, nel 1659 curò una nuova edizione del dizionario di Florio, consultando anche il Vocabolario della Crusca per integrare gli autori e i materiali.
Fig. 3 Frontespizio del Dizionario Italiano-Inglese, rivisto e ampliato da Torriano, 1659
Nelle sue opere più pratiche Torriano mostrò consapevolezza dei cambiamenti nelle ragioni dello studio dell'italiano: la sua dedica del 1640, The Italian Tutor, è rivolta a una compagnia di mercanti, sottolineando come l'interesse per l'italiano stesse virando verso scopi più concreti e professionali. La sua grammatica più nota, Della Lingua Toscana Romana (1657), venne ampliata e ripubblicata nel 1673 con il titolo The Italian Reviv'd (il Grande Incendio di Londra del 1666 aveva distrutto molte copie). Entrambe le opere contengono sezioni grammaticali complete e dialoghi pensati sia per il viaggiatore in Italia sia per l'italiano che si recava a Londra.
In questo periodo prende infatti piede la moda del Grand Tour: il viaggio culturale attraverso l'Europa, compiuto soprattutto da giovani aristocratici come parte della loro formazione. Non è un caso che Torriano usi protagonisti di questo tipo nei suoi dialoghi. Verso la fine del Seicento e nel corso del Settecento, inoltre, l'interesse per l'italiano venne alimentato anche dal successo dell'opera lirica. Baretti, una delle figure più rilevanti nella promozione della cultura e della lingua italiana in Inghilterra dopo Florio, notò che «qui la lingua italiana va ripigliando terreno, mercé dell’Opera che si è finalmente ristabilita». L'opera creò anche un nuovo pubblico femminile: per le donne della borghesia furono scritti manuali ad hoc; per esempio Casotti dedicò la sua grammatica A New Method of Teaching the Italian Tongue to Ladies and Gentlemen (1709) «alle signore della borghesia». Nel Settecento comparvero grammatiche rivolte a chi non conosceva il latino, che fino ad allora era spesso dato per scontato nelle spiegazioni grammaticali.
Figure 4 Introduzione a Method of Teaching the Italian Tongue to Ladies and Gentlemen (1709)
Conclusione
Dal XIX secolo in poi l'interesse per l'italiano in Inghilterra subì un calo: nella prima metà dell'Ottocento il movimento romantico aveva ancora mantenuto vivo l'interesse per la lingua, ma nella seconda metà il ruolo dell'italiano si ridusse soprattutto al settore musicale. Il francese era ormai diventato la lingua più popolare in ambiti diplomatici e culturali in Europa, e in molte scuole inglesi si insegnava più francese che italiano. Allo stesso tempo, in Italia si diffuse l'apprendimento dell'inglese.
Nel XX secolo però si avviò un processo di istituzionalizzazione dell'insegnamento dell'italiano: la lingua trovò spazio nelle università (in Inghilterra, per esempio, a Oxford nel 1903) e venne inserita nei curricula scolastici di diversi paesi, pur spesso in posizione marginale rispetto ad altre lingue. Inoltre, la presenza di comunità italiane all'estero (come negli Stati Uniti, Australia, Brasile o Argentina) contribuì a mantenere vivo l'interesse per l'italiano.
Oggi l'italiano viene studiato per motivi diversi: per la letteratura, la musica e l'opera, il turismo culturale, la cucina, la moda, nonché per legami personali e migratori. La sua storia in Inghilterra racconta non solo l'espansione di una lingua, ma anche un dialogo culturale duraturo fra due paesi che, nel corso dei secoli, si sono arricchiti a vicenda.
novembre 2025
Fonti
MAECI, Stati generali della lingua e della creatività italiana nel mondo, 2021
Palermo, M., & Poggiogalli, D. (2019), Grammatiche di italiano per stranieri dal ’500 a oggi: profilo storico e antologia, Pisa, Pacini Editore.
Pizzoli, L. (2004), Le grammatiche di italiano per inglesi, 1550-1776: un’analisi linguistica, Firenze, Accademia della Crusca.
Rossi, S. (1991), Giovanni Torriano: il primo insegnante di inglese in Italia, in Chaney, E., & Vassallo, P. (a cura di), Journal of Anglo-Italian Studies, 1, pp. 36-50, Msida, Malta University Press.
Simonini, R. C., Jr. (1952), Italian Scholarship in Renaissance England, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.
Wyatt, M. (2005), The Italian Encounter with Tudor England, Cambridge, Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/cbo9780511484094
Yates, F. A. (1968), John Florio: The life of an Italian in Shakespeare’s England, New York, Octagon Books.